#catarsis poetica
Text

Créditos en la imagen
6K notes
·
View notes
Text
ONCE UPON A MIDNIGHT DREARY, WHILE I PONDERED, WEAK AND WEARY

Mezzanotte. C’è un orario più suggestivo? È un varco, la soglia tra ciò che è stato e ciò che sarà; l’ora in cui termina l’incantesimo della fata madrina di Cenerentola; l’ora dei baci di cui il Quartetto Cetra metteva in guardia; l’ora in cui si attiva l’assicurazione dell’auto e quella dopo la quale è consigliabile non dar da mangiare ai gremlin, ed è l’ora che se c’è qualche evento che ti interessa non sai di preciso in quale giorno scriverlo in agenda. Tutte cose che sarebbero prive della stessa suggestione se accadessero, che ne so, alle ore dieci, ore due, un quarto alle tre, tour jeté, doppia piroetta, contropiroetta, pas de deux, figura della teiera, caricamento finale ed eccola che vola!
La mezzanotte è anche l’ora in cui Edgar Allan Poe meditava stanco e affaticato sopra un raro codice obliato, e si può dire che Taylor Swift abbia fatto più o meno la stessa cosa, ma coi gatti sul letto in luogo del corvo appollaiato sul busto di Atena.
Per sua stessa definizione, Midnights, il suo decimo album, è infatti “una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio tra terrori e dolci sogni. I pavimenti su cui camminiamo avanti indietro e i demoni che affrontiamo.”
Un “concept album”, insomma, che ha ad oggetto quel che la tiene sveglia la notte, tra dubbi, sensi di colpa, desideri di rivalsa, tragedie, amore e sguardi speranzosi al futuro.
Direi a buon diritto una ponderazione, di chi, insonne, cerca se stesso e spera di trovarsi allo scoccare delle dodici. Speculazioni, perfino, di cosa avrebbe potuto e dovuto essere, in un ricorso alle ipotesi che si trova non solo nel titolo della sesta traccia dell’edizione 3am, Would’ve, Could’ve, Should’ve, ma anche nei ritornelli di Bigger Than The Whole Sky.
L’album raccoglie riflessioni che originano in vari periodi della sua vita, remoti e recenti, e musicalmente e testualmente è pieno di richiami (qualcuno più palese di altri) alle ere passate (su tutti: quel’”I remember”, seppur distorto, di Question…? è lo stesso di Out Of The Woods), come se una sorta di filo invisibile legasse tutte queste canzoni a quelle precedenti.
In effetti, la prima cosa che ha attirato la mia attenzione è stato il sound, nuovo ma al contempo in buona misura familiare, un sound che per forza di cose ha trovato una sua originalità e individualità con il progredire degli ascolti, ma che di primo acchito mi ha fatto pensare a 1989 e a Lover.
D’altronde, per quanto Taylor sia solita sperimentare, non si può dire che vi sia mai stata una cesura così netta o cambi di rotta così drastici da disancorarla dalla sua consolidata poetica. La sua carriera potrebbe dirsi un albero che per quanto presenti ramificazioni e innesti e grovigli, comunque per forza poggia su un tronco portante, a sua volta radicato a un concetto di base; se vogliamo un vero e proprio fulcro: l’attingere al proprio vissuto, mettendo in scena il personale con una notevole dose di schiettezza, nell’incessante ricerca della catarsi. E non è, questo, un mero marchio di fabbrica della Taylor cantautrice: è proprio la sua filigrana, sia che si tratti della Taylor “campagnola” del debutto o di quella accademicadellacrusca del duo folklore/evermore.
Sennonché la catarsi, pur nascendo nell’intimità di una singola persona, smette quasi subito di essere purificazione individuale e sublima in universale, diventando patrimonio di chiunque le sue canzoni le ascolti, che abbia o no vissuto esperienze analoghe o almeno assimilabili. A volte — perlomeno è così per me — è semplicemente il suo modo di vedere le cose o di interpretare la vita che mi fa partire per la tangente e mi consente di ragionare sulle mie questioni, che con le sue sono affini tanto quanto un pesce è affine a una bicicletta. Per esempio io, a forza di ascoltare it’s time go e a farmi certi piantoni nel parcheggio, ho raggiunto l’illuminazione come Buddha (ancora non c’era l’inflazione energetica) e ho trovato il coraggio di cancellarmi dall’albo degli avvocati. No, per dire.
In questo caso specifico è stata You’re On Your Own, Kid a mandarmi il cervello in ebollizione, e chissà quale altre drastiche decisioni mi attendono in futuro “solo perché me l’ha detto Taylor Swift”. Madò, manco fossi entrata in Scientology.
Ora, fatte queste dovute premesse, direi che è il caso di tuffarsi senza ulteriori indugi nella mia personalissima esegesi di ‘sto fracco di canzoni (ventuno, mortaccisua, qua c’è gente che ha stipendi da guadagnare e telefilm da guardare), continuando una tradizione che ha compiuto dieci anni proprio questo ottobre, inaugurata col tomone su Red.
Ma vi devo avvertire: non vi piacerà proprio tutto tutto quello che troverete scritto qui di seguito. Perciò accendete le torce e affilate i forconi, e in caso venitemi a cercare che facciamo a botte sulle divergenze dogmatiche che ci separano. Prima, però, dear reader(s), beccatevi
il Tomone 7.0.™
MIDNIGHTS BECOME MY AFTERNOONS
Lavender Haze
[Taylor Swift, Jack Antonoff, Zoë Kravitz, Mark Spears, Jahaan Sweet, Sam Dew]
“Lavender haze” è un’espressione degli anni ’50 del Novecento usata per descrivere l’essere innamorati. E uno dice, vabbè, sticazzi. E infatti non è tanto questo ad avermi colpito, ma che sia andata a pescarla da un telefilm, Mad Man. È un po’ come se io scrivessi una canzone e la chiamassi “Scrocchiazzeppi”, che è una parola che ho sentito in Distretto di Polizia.
Di tutto il cucuzzaro, questa è tra le canzoni che mi piacciono di meno, anche se in effetti farei prima a elencare quelle che mi piacciono. Ecco, si doveva dire e si è detto.
Ignoro addirittura quante volte abbia dovuto ascoltarla per scriverci sopra due righe visto che la trovo così poco memorabile che ogni volta che arrivavo alla fine non mi ricordavo nemmeno di averla fatta iniziare, e dovevo — Iddio me ne scampi e liberi — sorbirmela daccapo (poffare! Volano parole mordaci!).
Di più: è la traccia di apertura, su cui grava la responsabilità di fare strada a tutte quelle che seguono, è quella che indirizza il primo (quantunque acerbo) giudizio sul resto del disco. Ecco, a me quel primo giudizio veicolato da Lavender Haze è stato di noia tendente a "maccheèstammerda" "mmh, bruttino". Sì, per carità, un pregiudizio che ha avuto modo di evolvere e in parte ribaltarsi man mano che ho approfondito gli ascolti, ma di cui Lavender Haze è abbastanza responsabile. È pur vero che se come traccia di apertura ci fosse stata Midnight Rain avrei tirato il disco dalla finestra ancora prima di arrivare alla numero due.
Tematicamente, la canzone riprende concetti che già presenti in reputation: i versi “I’ve been under scrutiny / You handle it beautifully” e “They're bringing up my history / But you weren't even listening” sono speculari a “My baby's fly like a jet stream / High above the whole scene” di Call It What You Want e “And here's to my baby / He ain't reading what they call me lately” di This Is Why We Can’t Have Nice Things, e in essi emerge tutta la gratitudine di avere al proprio fianco una persona che se ne frega del delirio che le ruota intorno, tra media ossessionati, haters squinternati e fan sciroccati.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 4 (shit)
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “I'm damned if I do give a damn what people say”
Maroon
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Dal (color) lavanda si passa al rosso. Rectius: a cinquanta sfumature di rosso (su per giù). Alcune sono menzionate per il tramite di aggettivi: rosé (rosato, qui sostantivato a indicare il vino), burgundy (borgogna), scarlet (scarlatto), maroon (granata); altre invece a mezzo di sostantivi indicanti cose che hanno in comune il colore nelle sue gradazioni: blood (sangue), rust (ruggine), carnations (garofani), roses (rose), rubies (rubini).
Il rosso è un colore caro alla poetica swiftiana, a partire dall’album eponimo, Red, ed è il colore che per eccellenza individua la passione, quello che rappresenta un sentimento acceso, dirompente, eclatante, sia nel bene sia nel male. E infatti in quell’album le sue esperienze e l’amore vengono raccontati con aggettivi perentori (burning, sad, beautiful, tragic, happy, free, confused, lonely, treacherous, reckless). Se mi passate la metafora starwarsiana, la Taylor del 2012 era un Sith che viveva di assoluti.
In questa canzone, invece, quel che colpisce sono le tonalità con cui il sentimento è descritto: si abbandonano i termini categorici e si ammette e riconosce che l’amore vive diversi gradi di intensità: dalla leggerezza del rosato al parossismo dello scarlatto, dal livido del borgogna alla ricchezza del rubino, e tutto il resto del cucuzzaro che passa in mezzo. E può accadere, come qui è accaduto, che quei colori affievoliscano insieme al sentimento stesso: un po’ come il sangue, che dapprima sgorga rosso intenso ma poi si ossida e diventa marrone. Qui non soltanto ci viene esplicitamente detto che la relazione è in qualche modo finita (“And I lost you”; “And I wake with your memory over me”) ma ci viene anche visivamente suggerito con l’eloquente immagine della ruggine sui telefoni (tanto a livello cromatico, un bruno rossastro non certo vivido, quanto a livello squisitamente simbolico, di corrosione e indice di poca “manutenzione”). Anche i garofani scambiati per rose potrebbero essere sintomatici di qualche problema: sebbene entrambi i fiori rappresentino e significhino l’amore in vario modo, di certo confonderli tra loro potrebbe voler alludere a qualche sorta di inganno, o di equivoco, o di illusione. Peraltro, “Garofani rossi per te / ho comprato stasera” suona proprio male.
#AlcoholicCount: 2 (rosé, wine)
#CurseWordsCount: 5 (cheap-ass, shit, fuckin’ x2)
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “And I wake with your memory over me / That's a real fuckin' legacy, legacy”
Anti-hero
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Nelle narrazioni, l’antieroe è un personaggio archetipico frequentemente confuso con l’antagonista, il cattivo, qualcuno che svolge la sua funzione narrativa in aperta opposizione all’eroe (colui che muove la storia), ostacolandone i tentativi di quello di raggiungere gli obiettivi che si è dato. Normalmente l’antagonista si pone in contrasto con le caratteristiche e le istanze positive che fanno capo a quest’ultimo, in una sorta di dialettica hegeliana.
Ecco, l’antieroe non è nulla di tutto questo: non è l’opposto dell’eroe ma un suo tipo particolare, in un rapporto di genus e species. Christopher Vogler, nel suo “Il viaggio dell’eroe” (Dino Audino Editore, 2017, pag. 43) suddivide l’archetipo in due categorie: da una parte, “personaggi che si comportano come eroi convenzionali ma hanno una forte impronta cinica”; dall’altra personaggi tragici, “figure centrali di una storia che potrebbero non piacere e non essere ammirate e le cui azioni potrebbero persino essere biasimate”. In particolare, questi ultimi “non sconfiggono i loro demoni interiori e ne sono colpiti e distrutti”.
L’“anti-hero” con cui si identifica Taylor in questa canzone rientra evidentemente nella seconda categoria: l’invecchiare senza contestualmente maturare (“I have this thing where I get older, but just never wiser”), il complottare (“my scheming”), il darsi alla macchia con le persone (“All of the people I've ghosted stand there in the room”), il narcisismo dissimulato e travestito da altruismo (“Did you hear my covert narcissism / I disguise as altruism like some kind of congressman?”), sono tutti comportamenti o difetti che ben si attagliano all’archetipo di cui si sta cantando. Peraltro, se Vogler ritiene che questo archetipo sia spesso incapace di vincere i propri demoni, ecco che in qualche modo Taylor conferma la teoria quando mette in bocca ai propri immaginari parenti la frase “She's laughing up at us from hell!”. E sì, per quanto le lamentele dei familiari delusi dal de cuius durante la lettura del testamento lascino il tempo che trovano, la possibilità — anche solo remota — che sia finita all’inferno non depone certo a favore di qualcuno che abbia superato i propri difetti.
L’antieroe è, anche per questo, una figura con la quale si tende a empatizzare. Ritengo che il picco dell’empatia qui avvenga nella seconda strofa: con pochi versi suggestivi e visivamente evocativi — un “mostro” impossibile da uccidere e troppo grande (direi nel senso di “impegnativo”) da frequentare, che dalla collina barcolla in direzione della città pronto a distruggere tutto sul suo cammino — ci viene spiegato cosa si prova a perdere il controllo della propria immagine e di come l’idea che gli altri (i media soprattutto) hanno di lei prende il sopravvento e travolge (o rischi di travolgere) tutto quanto: la sua vita, la sua relazione, le sue amicizie, la sua stessa personalità.
Questa canzone per me vince il jackpot. È la mia preferita a mani basse, bassissime. Così basse che posso quasi dare il cinque a Taylor all’inferno.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 1
#FavLyrics: “I have this thing where I get older, but just never wiser / Midnights become my afternoons”
Snow On The Beach feat. Lana Del Rey
[Taylor Swift, Jack Antonoff, Lana Del Rey]
Servizio catering Del Rey & co., disponibili per compleanni, cerimonie civili e religiose e cene aziendali. No, perché è un po’ così che mi immagino il contributo di Lana Del Rey a questa canzone: l’aver portato i cappuccini in studio di registrazione. Ochèi, ochèi, in realtà la si nota (con delle belle cuffie) nell’armonizzazione delle due voci, impalpabile e fuggevole… come neve sulla spiaggia.
La canzone racconta di un innamoramento simultaneo di due persone, un’esperienza ritenuta bizzarra ma bellissima come quando nevica al mare (evento atmosferico voluto dalla lobby dei ristoratori marittimi che così possono appendere la foto sulla parete vicino a quella col vip della tv che era entrato per usare il bagno una volta), descritto con l’uso sapiente di uno stesso verbo — to fall — che ha due significati: cadere (la neve, appunto) ma anche innamorarsi.
Ora, devo ammettere che su questa canzone non riesco a decidermi: non la trovo necessariamente brutta, al più noiosa, ma in ogni caso — sia che piaccia sia che non piaccia — penso che saremo tutti concordi nell’ammettere che abbia il peggior bridge di sempre, ancora peggiore di quello di Cuernavaca, Messico, che è crollato il giorno dell’inaugurazione facendo precipitare nel fiume sindaco e giornalisti. ¡Ay, caramba!
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 3 (fuckin’)
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Life is emotionally abusive”
You're On Your Own, Kid
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Anti-hero è la mia preferita ma vince su questa davvero di pochissime lunghezze; perfino con la moviola sarebbe difficile stabilirne il primato.
You're On Your Own, Kid è un ottimo esempio per spiegare quello che intendevo nell’introduzione, quando dicevo che non importa quanto le mie esperienze di vita c’entrino un cactus con le sue, perché bene o male c’è sempre, in uno dei suoi versi, qualcosa che mi illumina sulla via di Damasco. Per esempio, che c’entro io con lo struggermi romanticamente per qualcuno che non mi nota (“I wait patiently / he's gonna notice me / It's okay, we're the best of friends), o a cui non frega proprio nulla (“Just to learn that you never cared”), o coi disturbi del comportamento alimentare (“I search the party of better bodies”; “I hosted parties and starved my body”)? Zero, zip, zilch, nada, niente. Eppure questa canzone mi fa partire per la tangente, perché quell’“you’re on your own, kid” mi apre un intero universo di consapevolezza che va ben oltre la narrazione della sua vita che fa nella canzone.
Anche nel suo discorso per la sua laurea honoris causa all’New York University (io me sò laureata a quella de Macerata, altro che Grande Mela, e ho pure dovuto studiarci sopra, vedete che siamo proprio agli antipodi?) aveva utilizzato questa stessa espressione. Lì prendeva le mosse da un discorso di venti minuti (tra i più belli che abbia mai ascoltato) rivolto a chi aveva appena raggiunto quel traguardo davanti al quale si spalanca quella vita adulta di cui finalmente si può prendere le redini (per quanto spaventoso possa essere): “The scary news is, you’re own your own, now. But the cool news is, you’re own your own, now!”.
Qui la medesima saggezza origina da un luogo diverso, e sebbene parta da altre premesse, altre esperienze, altri presupposti, in ogni caso è carica della medesima accezione positiva che echeggia nel discorso di laurea. Il brano, che attraversa emozioni come la speranza (nelle prime due strofe) e la disillusione (in tutto il resto eccettuato il finale), da ultimo lascia cadere il velo di Maya di schopenhaueriana memoria e arriva a una realizzazione potentissima (“And I saw something they can't take away”) che ribalta il significato — di sconforto dato dal sentirsi soli e abbandonati, di non avere altro che se stessi nel senso più negativo possibile — di tutti quegli “you’re own your own, kid” cantati fino a quel momento: è un invito a essere demiurghi del proprio destino, una volta capito che in qualcosa di perso può celarsi qualcosa di guadagnato, o che in un capitolo che si chiude si nasconde la possibilità di un rinnovamento positivo (“'Cause there were pages turned with the bridges burned / Everything you lose is a step you take”). E, quel che è più importante, non c’è motivo di avere paura perché… sei per conto tuo.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “From sprinkler splashes to fireplace ashes / I called a taxi to take me there / I search the party of better bodies / Just to learn that my dreams aren't rare”
Midnight Rain
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Midnight Rain ha lo stesso problema di Lavender Haze: non ha nulla che me la renda memorabile. A differenza dell’altra, però, che almeno è orecchiabile, questa per me è lacunosa anche in quel dipartimento. Manca senza dubbio di un climax (e il paragone con You're On Your Own, Kid, che la precede, è inevitabile) e sebbene parecchie altre canzoni in questo album non siano necessariamente dirompenti nei bridge e nelle variazioni, questa qui è monotona e incolore nella sua interezza. E non è nemmeno anticlimatica, perché l’anticlimax implicherebbe una digradazione da un punto alto a uno più basso, cosa possibile solo se c’è effettivamente un punto alto da cui scendere: qui è elettroencefalogramma piatto dall’inizio alla fine. Onestamente non credo che mi capiterà di ascoltarla anche solo un’altra volta in un futuro prossimo, in uno remoto e in tutti i futuri che stanno in mezzo.
(Taccio sulla voce distorta perché a questo punto sarebbe come sparare sulla Croce Rossa).
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 1 (il mio, e questa canzone è l’arma del delitto)
#FavLyrics: “My town was a wasteland / Full of cages, full of fences / Pageant queens and big pretenders”
Question...?
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Questa canzone parla di due persone precedentemente coinvolte in una relazione amorosa che hanno preso strade diverse; ma una delle due (e ti pare che non era la gattara) è ferma a rimuginare e chiede all’altro se con la sua nuova fiamma abbia già vissuto quanto vissuto con lei.
Oltre all’“I remember” di Out Of The Woods, c’è un verso (“Painted all my nights / A color I have searched for since”) che richiama quanto già espresso in uno di illicit affairs (“You showed me colors you know I can't see with anyone else”).
#AlcoholicCount: inquantificabile (one drink after another)
#CurseWordsCount: 3 (fuckin’ x2, dickhead)
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Painted all my nights / A color I have searched for since”
Vigilante Shit
[Taylor Swift]
Una canzone dalle vibes fortemente noir, tanto nel testo e nel modo in cui è cantato (lento, deliberato), quanto nella melodia. E visto che me l’hanno inopinatamente cancellata, fingerò che valga come terza stagione di Why Women Kill.
Il brano ricorda per forza di cose no body, no crime, dove Taylor si era incaricata di farsi giustizia da sé — e infatti qui dice che è “on my vigilante shit again”. Tuttavia, se là era giudice, giuria e, soprattutto, boia, qui si limita alla delazione: tanto all’FBI, a cui vengono spifferati crimini da colletto bianco dell’uomo di cui intende vendicarsi, quanto alla moglie di quest’ultimo, la quale, al termine di un bel divorzio, alla fine si becca casa, figli e Mercedes.
In effetti, sembra anche — e forse lo è davvero — il prosieguo e la conclusione di mad woman: lì infatti si dichiara che, nonostante la società disapprovi le donne arrabbiate, non si dimenticheranno i torti subiti e prima o poi si reagirà (“Does a scorpion sting when fighting back? / They strike to kill and you know I will”; “My cannons all firing at your yacht / They say «move on» / But you know I won’t”; “And you'll poke that bear 'til her claws come out”). E in Vigilante Shit, spiffera di qua e spiffera di là, si è senz’altro agito. Di più, in entrambe le canzoni si menziona una moglie tradita (probabilmente sempre la stessa, e vien da pensare a quella di Scooter Braun, peraltro con un giudizio pendente a suo carico per qualche imbroglio su dei fondi di investimento). Insomma, due più due fa quattro e i conti tornano perfino a me che al liceo sono uscita con tre in matematica.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 4 (shit)
#MurderCount: nessuno, ma dice che potrebbe provare, e pertanto risponderebbe di delitto tentato qualora compisse atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie e o l’evento non si verifica.
#FavLyrics: “And I don't dress for villains / Or for innocents / I’m on my vigilante shit again”
Bejeweled
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
«Cosa? Che cosa? È un’ora che ti aspetto! Non è possibile, tu non sei al lavoro! Ma come non vieni? Ah sì? E io sai cosa ti dico? Adesso esco e vado col primo che incontro!»
«Buonaseeera!»
L’avreste mai detto che lo spot del 2001 della Fiat Punto avrebbe anticipato una canzone di Taylor Swift? Qui siamo ben oltre le previsioni fatte dai Simpson; persino Nostradamus e Beda il Venerabile impallidiscono in confronto.
Perché proprio come la ragazza della pubblicità, anche Taylor lamenta un evidente mancanza di interesse da parte del suo “baby boy”: di più, si rende proprio conto di non essere una priorità per l’altra persona (“Putting someone first only works when you're in their top five”; “Don't put me in the basement / When I want the penthouse of your heart”), mentre per lei è l’esatto contrario (“Did all the extra credit then got graded on a curve”; “I made you my world / Have you heard?”).
Soprattutto, capisce anche che è ingiusto lasciarsi offuscare quando in realtà si dovrebbe brillare (“And I miss you / But I miss sparkling”), perché brillante è proprio ciò che si è (“What's a girl gonna do? / A diamond's gotta shine”; “Best believe I'm still bejeweled / When I walk in the room / I can still make the whole place shimmer”). Una dichiarazione ontologica, quella, già presente in All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault) (“The idea you had of me, who was she? / A never-needy, ever-lovely jewel whose shine reflects on you”) e in mirrorball (“Drunk as they watch my shattered edges glisten”).
E allora sai cosa? E allora sticazzi, “I’m going out tonight” e, a seconda di come mi gira, deciderò se ricordarmi o no di te (“And when I meet the band / They ask, ‘Do you have a man?’ / I could still say, ‘I don't remember’” — e da uno smaliziato ma piuttosto innocente “non mi ricordo” al ben più drastico e già rodato “ho scordato che tu sia mai esistito” il passo è breve).
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Sapphire tears on my face / Sadness became my whole sky”
Labyrinth
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Taylor, gattara pazza de mi corazón, perché, perché ancora con ‘sta voce distorta che me pare quando te se scaricavano le batterie del walkman?
Ora, se sia per caso o per complotto non lo saprei dire, ma tutto quello che ho detto per Midnight Rain vale anche per questa canzone, e anche qui ogni volta che arrivo alla fine mi viene da pensare “Bene, e quindi? Finisce così? Addirittura quattro minuti per non dire assolutamente niente?”.
Questa, però, nonostante tutto mi piaciucchia, di sicuro più di Midnight Rain, ma ogni volta che penso “Ochèi, forse l’ho giudicata male, in effetti è bellina” arriva quella orribile distorsione che pare che a parlare sia un pentito di mafia a cui hanno camuffato la voce per non farlo riconoscere dai sicari del boss ed ecco che se ne va il beneficio del dubbio.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “I thought the plane was going down / How'd you turn it right around?”
Karma
[Taylor Swift, Jack Antonoff, Mark Spears, Jahaan Sweet, Keanu Torres]
Stavo lì a sforzarmi di ricordare se abbia mai visto il karma in azione in prima persona e mi sono ricordata di quando una macchina sulla strada per Macerata (che è tremenda, tutta curve e saliscendi e trattori che vanno a due ed è un attimo che finisci dentro a un campo) correva e sorpassava come chi ha appena mangiato il pesce crudo a Gubbio e cerca disperatamente di raggiungere il cesso più vicino, salvo poi venir fermata dai Carabinieri che stavano appostati in fondo alla discesa. Non so se conti come allineamento karmico, però è stato un momento piuttosto soddisfacente.
A naso, credo che TS non abbia scritto questa canzone in riferimento ai sorpassi selvaggi, ma d’altronde, come dicevo, io e lei abbiamo esperienze di vita ben poco paragonabili. Il concetto di base che tratta la canzone — vedere con soddisfazione che chi ha seminato vento finalmente raccoglie tempesta — però, arriva forte e chiaro.
L’idea del karma non è estranea a Taylor, che già lo menzionava espressamente in Look What You Made Do: “The world moves on, another day, another drama, drama / But not for me, not for me, all I think about is karma”. In questo brano, però, non lo si cita soltanto di sfuggita ma lo si sviscera, in quello che è e in quello che rappresenta. Intanto, lo si descrive attraverso una lunga serie di metafore: un fidanzato, un dio, una brezza, un pensiero rilassante (immagino che infonda una certa tranquillità la convinzione che prima o poi chi ci ha fatto un torto verrà ripagato con la sua stessa moneta), un tuono, una regina e finanche un gatto che le fa le fusa in grembo; e ancora con un paio di similitudini: un acrobata e un cacciatore di taglie.
Volendo, anche Vigilante Shit si può interpretare in senso karmico (perché il cattivo ha avuto quel che si meritava), tuttavia lì c’è un invito a essere concreta parte attiva nel ripristino dell’equilibrio universale (“Don’t get sad, get even”), che mal si concilia con l’idea stessa di karma, basata sull’attesa passiva — ci viene solo richiesto di comportarci rettamente — dell’agire di qualche forza arcana.
Comunque, dal modo in cui si parla del karma in questa canzone, è evidente che lo si ritiene un’entità dai feeenomenali poteri cosmici (tanto che tra i sostantivi che lo descrivono troviamo “dio”, “regina” e “tuono”), implacabile persino (“Karma's on your scent like a bounty hunter / Karma's gonna track you down / Step by step from town to town”), e appunto sarebbe bene evitare di trovarsi sul suo cammino e prenderlo dritto in faccia come un 38 barrato qualsiasi. Ecco perché Taylor dice di tenere pulito il suo lato della strada (“And I keep my side of the street clean”): cioè si comporta in modo che il karma non abbia nulla da rimproverarle. Che è la versione un po’ più igienica del cospargere di sangue d’agnello lo stipite della porta così che l’angelo sterminatore passi oltre e vada a uccidere i primogeniti di qualcun altro. Perché se ci pensate, se pure regolarmente le piove un bel po’ di merda addosso (penso, tra le altre cose, alla famigerata telefonata tagliata e cucita da Kim Kardashian, o a tutta la questione dei diritti dei master), alla fine, poffare!, si scopre sempre che erano gli altri nel torto, non lei. Perché loro, a differenza sua, non sanno cosa voglia dire tenere le strade pulite (“You wouldn't know what I mean”). Mi domando: c’è mica qualche Comune disposto a farla assessora con delega alla nettezza urbana?
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Ask me what I learned from all those years / Ask me what I earned from all those tears / Ask me why so many fade but I'm still here”
Sweet Nothing
[Taylor Swift, William Bowery]
Contro il logorio della vita moderna o ti fai un Cinar o ti metti al tuo fianco una persona che da te non pretende altro che uno “sweet nothing”, qualcuno che mentre gli altri fuori sgomitano e spingono se ne sta in cucina a canticchiare.
Quello che più colpisce di questo brano è il bridge, costruito tutto sull’allitterazione delle lettere d, s, r, t (“Industry disruptors and soul deconstructors / And smooth-talking hucksters out glad-handing each other”) suoni di per sé piuttosto duri ma che con la voce delicata di Taylor fanno un bel contrasto, e sembrano quasi una dolce filastrocca.
Il bridge prosegue poi con “And the voices that implore / «You should be doing more»” , e potrebbe riferirsi alla vita di Taylor posta sotto il costante scrutinio degli altri in quanto personaggio pubblico, della serie che se dovesse fare una donazione a un rifugio per pinguini vittime di incidenti stradali ci sarà sempre qualcuno che si chiederà perché mai non abbia fatto una donazione anche al centro di recupero per dromedari afflitti da ludopatia.
In generale, per chi non è un personaggio pubblico, in ogni caso è facile interpretare quei versi, come anche il ritornello, nell’ottica di un mondo in cui tutti sono in competizione e cercano di prevaricare, in cui lo “sweet nothing” viene demonizzato, con conseguente senso di colpa se non sei produttivo quanto gli altri (“«You should be doing more»”).
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Industry disrupters and soul deconstructors / And smooth-talking hucksters / Out glad-handing each other / And the voices that implore / «You should be doing more»"
Mastermind
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
“Precisamente tra diciotto anni i pianeti si allineeranno senza affanni…”
“Ahi, in versi, ahi.”
“Di tempo per agire ne avrai a iosa; sguinzaglia i titani, la tua banda mostruosa.”
Una volta anche a me è successo di trovarmi nella stessa stanza con una persona che dici “wow” per via di un raro allineamento planetario, solo che non era una stanza ma un autobus urbano a Milano, e non era per un raro allineamento planetario ma per un ordinario ritardo mostruoso del Frecciarossa su cui avevo viaggiato. Uh, e la persona che dici “wow” era Emanuela Pacotto, e racconterò questa storia fin sul letto di morte, mio ma anche di chiunque altro (con mia madre, sull’autobus con me che “Ma chi conosci a Milano? Era una tua amica di scuola forense?”).
Questa canzone riprende la confessione che Taylor ha già fatto in Anti-hero di essere una persona che pianifica ogni mossa, ogni dettaglio, che nulla di quello che accade e la riguarda è accidentale ma frutto di qualche suo machiavellico complotto. Un po’ la Flintheart Glomgold de noantri, ma senza l’accento scozzese.
Mastermind è la traccia di chiusura dell’album e, come quella di apertura, è sciapa allo stesso modo. È simpatica, ochèi, e parecchio orecchiabile, ma di sicuro nulla di più di questo.
#AlcoholicCount: 2 (liquor, cocktails)
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “No one wanted to play with me as a little kid / So I've been scheming like a criminal ever since”
Hits Different [Target deluxe edition]
[Taylor Swift, Aaron Dessner, Jack Antonoff]
Come Ponzio Pilato, anche Taylor “se ne lava le mani”, salvo poi trascorrere i successivi tre minuti e cinquanta secondi a rimuginarci sopra. “Moving on was always easy / for me to do”, dice. Seee, lallero. Tuttavia questa è una delle canzoni più riuscite di tutto il cucuzzaro mezzanottiano — accattivante, con un bridge travolgente, orecchiabile all’ennesima potenza — quindi chi si lamenta; al più mi lamento che non l’abbiano inserita nell’edizione standard. È frequente che le sue canzoni deluxe siano dei gran pezzoni, basti pensare a Ours, Wonderland, the lakes, right where you left me, it’s time to go; tuttavia gli album di cui quelle sono il complemento (Speak Now, 1989, folklore ed evermore) sono già perfetti così come sono, mentre Midnights avrebbe tratto giovamento da scelte più oculate in termini di tracce: dentro questa e via Snow On The Beach, per esempio, o via Midnight Rain (in realtà Midnight Rain via proprio in generale da ogni piano dell’esistenza).
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 5 (shit x3; asshole)
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Oh my, love is a lie / Shit my friends say to get me by / It hits different / It hits different this time”
The Great War [3am edition]
[Taylor Swift, Aaron Dessner]
And today we're all brothers
Tonight we're all friends
A moment of peace in a war that never ends
Today we're all brothers
We drink and unite
Now Christmas has arrived and the snow turns the ground white
- Sabaton, “Christmas Truce”
Io sono fissata con la storia, la amo quanto amo i gatti, persino i romanzi che leggo devono essere ambientati almeno dagli anni ’50 del Novecento in giù, altrimenti non mi diverto. E non succederà mai, e dico mai, ne sono consapevole, ma se per caso dovesse accadere che Taylor scriva una canzone che parli effettivamente di un evento storico, uno qualsiasi, cadrei morta stecchita all’istante. Mmmh, Didn’t They? conta? Vabbè. Per ora, comunque, mi dovrò fare una ragione che questa canzone rimandi solo col titolo (o forse no? *wink wink nudge nudge*) alla prima guerra mondiale e non ne racconti in effetti gli accadimenti, come a suo tempo me la sono fatta per la “corsa all’oro” in evermore che era tutt’altra cosa rispetto quella del Klondike di Zio Paperone e di Jack London; ma d’altronde ho due interi album dei Sabaton che soddisfano il mio bisogno di avere musicata la Grande Guerra (Alexa, play “Versailles”).
Ora, questa traccia di apertura dell’edizione 3am fa impallidire Lavender Haze, e non posso fare a meno di pensare a quanto avrebbe potuto cambiare l’intera percezione iniziale che ho avuto di Midnigths se questo brano fosse stato presente all’inizio dell’edizione standard, e invece ecco qua come stiamo, con il mio post più critico di un suo album da dieci anni a questa parte.
Ed è curioso che sia proprio Lavender Haze a tornare in causa, e non tanto perché con The Great War condivide l’essere una traccia di apertura (solo che una è bella e un’altra no), ma perché tematicamente sono in netto contrasto: la prima racconta di quella fase della relazione amorosa in cui tutto è meraviglioso, nella seconda invece la relazione si è trasformata in una guerra e Taylor attinge da un vocabolario specifico, utilizzando termini tipicamente associati ai conflitti e alla morte: la tomba (“Spineless in my tomb of silence”) e anche la cripta (“Screaming from the crypt”), la caduta dei vessilli del nemico (“Tore your banners down”) lo spargimento di sangue (“All that bloodshed”), le bombe (“the bombs were closer”), i soldati caduti (“Soldier down on that icy ground”), le truppe (“So I called off the troops”).
Sebbene siano numerose nelle sue canzoni le occorrenze per “war”, guerra (la si trova in Innocent, Safe & Sound, Clean, You Are In Love, ivy e long story short), ad oggi in un solo altro caso Taylor aveva fatto uso metaforico dell’immaginario bellico: nelle prime due strofe e nei ritornelli di epiphany. The Great War, invece, è metafora dall’inizio alla fine, proprio come è Miss Americana & The Heartbreak Prince, e per questo è efficacissima nel pennellare un quadro terribile, ben lontano da quella sensazione di pacata contentezza di Lavender Haze.
Ma come tutte le guerre reali, anche quelle metaforiche a un certo punto terminano. La prima guerra mondiale con l’armistizio di Compiègne, quella swiftiana con la realizzazione che il proseguire delle ostilità avrebbe condotto alla perdita definitiva dell’altra persona (“So I called off the troops / That was the night I nearly lost you / I really thought I'd lost you”).
Giunge quindi il momento, come d’altronde è successo anche nella realtà, in cui si giura che non si permetterà mai più che qualcosa di simile accada ancora (“It was war, it wasn't fair / And we will never go back to that”). Se non fosse che la storia è, o dovrebbe essere, magistra vitae: sappiamo bene come “la guerra che porrà fine a tutte le guerre” in questo abbia miseramente fallito e, anzi, le condizioni della resa tedesca e la depressione che ne conseguì portarono infine al collasso della Repubblica di Weimar e all’ascesa del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, con a capo Adolf Hitler, e non serve ricordare cosa sia accaduto dopo. Insomma, visti i precedenti, io comunque andrei cauta nel dire che non si arriverà mai più a una guerra (quand’anche metaforica) simile. Certo, se servisse ad avere un’altra canzone così allora daje Taylor, spara a tutti gli arciduchi che vuoi.
Dicevo che il riferimento alla Grande Guerra potrebbe trovarsi non solo nel titolo. Nell’ultima strofa, infatti, si menziona il papavero (“Place a poppy in my hair”): ora, non so se sia una buffa coincidenza o sia stato inserito consapevolmente (e in questo caso chapeau, anche perché mmmh, di tutti i fiori proprio a quello mi va a pensare?), ma il papavero riveste un ruolo importante nell’iconografia del primo conflitto mondiale. Compare per la prima volta in senso simbolico nella poesia “In Flanders Field”, scritta nel 1915 dal tenente colonnello canadese John McCrae in ricordo di un commilitone caduto nella seconda battaglia di Ypres, in Belgio: “In Flanders fields, the poppies blow”; “We shall not sleep, though poppies grow”. La poesia acquisì ben presto una tale popolarità da ispirare il “remembrance poppy”, un papavero artificiale da appuntare agli abiti che, al termine della prima guerra mondiale, servì a onorare i caduti inglesi e americani, e tutt’ora lo si usa come simbolo commemorativo nelle nazioni del Commonwealth nelle cerimonie del “Giorno della memoria”, che cade l’11 novembre. Vedi a forza di ascoltare i Sabaton la roba che si impara? Alexa, play “In Flanders Field”.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: in questa canzone nessuno, ma la prima guerra mondiale ha causato almeno sedici milioni di morti.
#FavLyrics: “All that bloodshed, crimson clover / Uh-huh, the bombs were closer / My hand was the one you reached for / All throughout the Great War”
Bigger Than The Whole Sky [3am edition]
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
La peculiarità di questa canzone è quella di essere plasmabile, di adattarsi alla singola, unica, specifica esperienza di chi la ascolta. È una tela bianca, di cui Taylor, che ci ha messo in mano i pennelli, ha solo definito il fulcro: il dolore, la perdita. A cosa si riferisca questo dolore, in cosa consista questa perdita, tuttavia, sta a noi stabilirlo in base al nostro vissuto, lei non ce lo dice. Per questo c’è chi ci ha visto la narrazione di un aborto spontaneo, chi la fine di una relazione (ma per me sarebbe una banalizzazione eccessiva), chi addirittura la perdita della propria identità.
Quale che sia il caso specifico di cui Taylor ha scritto — magari non necessariamente in riferimento a una sua esperienza ma, come nel caso di happiness, a quella di qualcuno a lei vicino — la canzone origina da un retroterra luttuoso secondo me piuttosto evidente. È un racconto tragico, e lo si intuisce già dal primo verso, con la parola “aftermath” — che per definizione riguarda l’indomani di un disastro o di una calamità — posta alla fine della frase a garanzia di maggior enfasi. È accaduto qualcosa di così devastante da averla lasciata senza parole (“No words appear before me in the aftermath”); lei, che, be’, con le parole ci campa. E la tragedia è così totalizzante che la tristezza va a informare ogni singola cosa che Taylor tocca (“Every single thing I touch becomes sick with sadness”).
La seconda strofa, invece, accosta due diverse — e contrastanti — idee di “consequenzialità”: il battito d’ali di una farfalla in Asia (che secondo la teoria del caos porterebbe un tornado in un’altra parte del mondo) e il non aver pregato. In entrambi i casi c’è un rapporto di causa ed effetto, ma se la prima circostanza menzionata esula dal controllo, e per questo ha un respiro “assolutorio” perché nessuno avrebbe potuto farci nulla, la seconda invece si tramuta in devastante senso di colpa. Certo, pregare Dio conduce allo stesso risultato di assoluta inconcludenza che pregare Superman, Topo Gigio, tutte le evoluzioni di Eevee o non pregare affatto, quindi è irragionevole farsi logorare dal rimorso di essere stati manchevoli. Eppure qualcuno potrebbe dire “Ho fatto anche quello. Non è servito a un cazzo [ma va!], ma almeno posso dire di averle provate tutte e non posso rimproverarmi di niente”. Per esempio, in Soon You’ll Get Better dice “Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too” perché oh, vedi mai, alla fine cosa mi costa? Qui, invece, ci si rimprovera eccome, forse perché incolparci di una nostra supposta mancanza, qualcosa che se ci fosse stata avrebbe fatto la differenza, allontana da noi l’idea spaventosa che la vita sfugge a ogni nostro tentativo di domarla o di indirizzarla, e che la tragedia che ci ha colpiti sia solo il frutto di un mero tiro di dadi del destino.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Every single thing I touch becomes sick with sadness / ‘Cause it's all over now, all out to sea”
Paris [3am edition]
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Avete presente quando in Blank Space mezzo internet aveva capito che un verso facesse “All the lonely Starbucks lovers” anziché “Got a long list of ex-lovers”? Ecco, io qua irrimediabilmente sento “We were in some wharehouse” anziché “We were somewhere else” e mi sfuggiva la ragione per cui avrebbe dovuto trovarsi in un magazzino. Insomma, avrei capito se la canzone si fosse intitolata, che ne so, “Brembate di Sopra”, ma siccome si intitola “Paris” i conti proprio non mi tornavano.
Un’altra cosa che non mi torna, ma stavolta sul serio, è il vino economico, di cui anche in Maroon: perché, con tutti i soldi che ha, questa me beve il Tavernello?
#AlcoholicCount: 5 (wine x2, champagne x3)
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Sit quiet by my side in the shade / And not the kind that's thrown / I mean, the kind under where a tree has grown”
High Infidelity [3am edition]
[Taylor Swift, Aaron Dessner]
Fedeltà: qualcosa che puoi ricercare in un cane, in un Carabiniere, eventualmente in un cane Carabiniere ma anche in un Carabiniere cane (il primo in senso cinofilo, l’altro in senso cialtrone), in un marine, in un impianto stereo e nella tessera punti del supermercato, ma non in una canzone di Taylor Swift. Infatti la fedeltà, o, meglio, la sua carenza, è un tema che è già stato sviluppato — vuoi in modo approfondito, vuoi soltanto en passant — in parecchi suoi brani: dalla ormai remotissima Should’ve Said No fino ad arrivare al blocco indie di august; betty; illicit affairs; mad woman; no body, no crime; ivy, passando per Better Than Revenge e Girl At Home.
High Infidelity, come già illicit affairs, è esplicita del tema fin dal titolo, ma se in illicit affairs è evidente il senso di colpa che permea l’intera canzone per un comportamento che si sa sbagliato, qui il tradimento invece è vissuto come qualcosa di inevitabile in una relazione ormai danneggiata (“Lock broken / Slur spoken / Wound open”; “Your picket fence is sharp as knives”), salvifico addirittura (“Do I really have to tell you how he brought me back to life?”).
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: nei fatti nessuno, però potrebbe essere un campanello d’allarme il fatto che rifletta sui modi in cui si può uccidere una persona amata, quindi la gattara potrebbe essere destinataria di una misura di sicurezza praeter delictum.
#FavLyrics: “You know there's many different ways that you can kill the one you love / The slowest way is never loving them enough”
Glitch [3am edition]
[Taylor Swift, Jack Antonoff, Sam Dew, Mark Anthony Spears]
Questa canzone sconfessa quanto detto in Mastermind: se là l’amore sbocciato era frutto di una macchinazione, qui invece è il risultato di un errore imprevedibile del sistema TS, di un comportamento anomalo del programma (“We were supposed to be just friends”; “I was supposed to sweat you out”; “I think there's been a glitch”). In questo senso, quindi, è simile a Paper Rings quando dice “I hate accidents except when we went from friends to this”.
Comunque, te guarda la vita quanto è balorda: io quest’estate, per un glitch del sistema, nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico mi sono vista sparire il campo compilato relativo al possesso della laurea, titolo che dava due punti secchi, il che ha portato, cinque giorni prima dell’orale, all’invio di una pec impanicata a mezzanotte (almeno io e TS triboliamo agli stessi orari) in cui dimostravo in tutti i modi la sussistenza del requisito (“Ce l’ho la laurea, ce l’ho, me ne sono pentita ma ce l’hoooo”); quest’altra, invece, per un glitch del sistema, trova l’amore. Come disse Scarlet Witch, it doesn’t seem fair.
(comunque poi i punti me li hanno riconosciuti) (e da quella graduatoria poi sono stata pure assunta)
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “In search of glorious happenings of happenstance on someone else's playground”
Would’ve, Could’ve, Should’ve [3am edition]
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Il proverbiale senno di poi di cui sono piene le fosse, che ai comuni mortali consente una ponderazione sulle scelte passate, e a Taylor Swift pure, ma a lei, in aggiunta, consente anche di scrivere canzoni che definire spettacolari è dire poco. Io, purtroppo, faccio parte della prima categoria, perché sennò sai quante hit avrei sfornato sul senno di poi dell’aver fatto giurisprudenza.
Con questa canzone andiamo lontano, lontanissimo nel tempo, a qualcosina meno di tre lustri fa, perché a quel “nineteen” i nostri sensi di ragno si allertano e la mente corre subito a Dear John (“Don't you think nineteen's too young to be played / By your dark twisted games?”) e a quella relazione sbilanciata e manipolatoria. Da una parte, infatti, abbiamo lei, ancora troppo giovane (“a child”, “nineteen”) e di conseguenza ancora priva degli strumenti per difendersi; dall’altra lui, un “grown man” che ha omesso di prendersi la responsabilità dei suoi comportamenti (“[…] did it matter / If you got to wash your hands?”).
Ora, se vogliamo, anche in Dear John c’è un embrionale senno di poi (“I should’ve known”), ma lì le vicende sono ancora troppo fresche per poterle esaminare con il dovuto distacco, cosa che è invece possibile fare in Would’ve, Could’ve, Should’ve, stanti i molti anni passati. Si badi, e in effetti trattandosi di Taylor sarebbe strano il contrario, che “analisi distaccata” è diversa da “asettica”, perché la canzone è vibrante di emozione, di trasporto, di passione (nel senso proprio etimologico, dal latino pati, cioè “patire, soffrire”). Infatti, nonostante il tempo trascorso, vediamo bene come quel rapporto ancora la perseguiti (“The tomb won’t close”; “I regret you all the time”; “I can't let this go / I fight with you in my sleep / The wound won't close”, “If clarity's in death, then why won't this die?”), ma non perché ne abbia nostalgia o si sia pentita del fatto che sia naufragato, ma perché l’ha resa una persona diversa e a lei manca quella che era prima (“I miss who I used to be”), e le manca un’adolescenza che non le ridarà più nessuno (“Give me back my girlhood, it was mine first”).
Il bridge di questa canzone (Snow On The Beach, te possino ciaccà, prendi appunti) è il mio preferito di tutto l’album (forse addirittura nella mia top five di tutta la sua discografia) e introduce un’ulteriore variazione che mi fa altrettanto impazzire. Strutturalmente quindi manca la solita alternanza standard tra strofe, ritornelli, bridge, ritornello, e lo stesso bridge in questo brano svolge la doppia funzione di “collegamento” e di chiusura, con la sua ripetizione due volte di seguito nel finale. La parte migliore, peraltro, è il modo in cui dapprima prende velocità e poi a un tratto si frena (quando arriva a “Stained glass windows in my mind” e “I keep on waiting for a sign”) per ricominciare veloce. L’equivalente musicale delle montagne russe. Tra l’altro mi ha ricordato a una cover di “Whiskey In The Jar”che ho ascoltato tanti anni fa in un pub a Lisbona: il ragazzo che cantava faceva più o meno lo stesso giochetto, aumentando e diminuendo la velocità del ritornello e, inutile dirlo, quella è una delle cover più riuscite che abbia mai ascoltato in vita mia.
#AlcoholicCount: 0
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “God rest my soul / I miss who I used to be / The tomb won't close / Stained glass windows in my mind / I regret you all the time”
Dear Reader [3am edition]
[Taylor Swift, Jack Antonoff]
Come già Snow On The Beach, anche Dear Reader mi lascia combattuta, perché pure questa non la ritengo necessariamente brutta, ma mi annoia allo stesso modo. Rispetto all’altra, tuttavia, a livello di testo ci sono cose interessanti, con alcuni versi latori di verità universali che può essere utile tenere a mente (“If it feels like a trap/ You're already in one”; “Bend when you can / Snap when you have to”; “You don't have to answer / Just 'cause they asked you”), un po’ come già in marjorie. Il problema più che altro risiede nella parte finale, totalmente sbrodolata nell’esecuzione, che infatti appare disordinata (e di nuovo la voce distorta, diocrisantemo, io giuro che la denuncio).
#AlcoholicCount: 4 (my fourth drink)
#CurseWordsCount: 0
#MurderCount: 0
#FavLyrics: “Never take advice from someone who's falling apart"
IT MUST BE EXHAUSTING ALWAYS ROOTING FOR THE ANTI-HERO
Una premessa e due confessioni: è sempre affascinante trascorrere un po’ di tempo a cercare di capire cosa passi nel cervello di Taylor Swift, ma scrivere questo post è stata una gran fatica. Per prima cosa, perché da qualche anno a questa parte faccio fatica in ogni aspetto della vita; poi perché mi ero intrippata a vedere The Crown e per un mese è stato il mio solo e unico interesse; poi ancora per mancanza di tempo, mica come quando dovevo trovare il modo di passare quelle cinque ore di scuola forense ogni lunedì (avendo fatto voto di non ascoltare una singola parola di lezione, ma obbligata a frequentare pena invalidamento del semestre di pratica); infine, e presumo sia la ragione principale, le altre suonano più come scuse: perché quest’album, come il cheddar a Kuzco, no me gusta.
O, comunque, non del tutto.
Forse, più esattamente, la sensazione che mi dà questo disco l’ha spiegata bene uno degli sceneggiatori cialtroni di Occhi del Cuore, prima di intortare René con il monologo sulla locura: “per funzionare funziona, ma rischi di non convincere”.
Ecco, allora: Midnights non mi convince.
Al primo ascolto l’ho bocciato interamente, con solo Anti-hero e You're On Your Own, Kid a tenere in piedi la baracca. E ne sono rimasta sorpresa come restano sorpresi i vicini di casa alla notizia dell’inquilino del piano di sotto che ha sventrato come un gamberetto l’intera famiglia usando il coltello a mandorla del Grana Padano: “Salutava sempre, ferst riacscion sciòk”.
Ma è comunque Taylor Swift, perciò gli ho dato il beneficio del dubbio: forse il problema non era che fosse un album poco ispirato, ma ero io dell’umore sbagliato per apprezzarlo in modo adeguato (venivo da un periodo di merda, e ora mi trovo in una benvenuta fase di tregua tra quello e il prossimo periodo di merda che di sicuro mi aspetta dietro l’angolo): un “It’s me, hi, I’m the problem, it’s me” da manuale. Insomma, ero più che disposta ad andare a Canossa. Ebbene, trascorso poco più di un mese, credo che — per prendere in prestito una frase da happiness — siano vere entrambe le cose.
Peraltro ho anche avuto modo di notare una certa polarizzazione nelle opinioni, e non mi pare ci sia stato il consenso generalizzato e unanime che hanno avuto folklore ed evermore. Non che ciò sia dirimente, sintomatico o rappresentativo di alcunché ma, e torno a parlare per me, confesso ogni assenza di folgorazione: né all’inizio (come con Speak Now, Red, 1989 e folklore), né durante, né dopo (come con evermore); nessuna discesa su di me della fiammella della Verità come lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste o quello che diavolo era, che io al catechismo prestavo meno attenzione che a scuola forense.
Per quanto Midnights presenti tante belle canzoni (qualcuna molto più che solo bella), in realtà mi è difficile immaginarlo svettare in una discografia che contiene titoli come Speak Now, Red, 1989, reputation, folklore ed evermore, ognuno in qualche misura iconico, se non proprio autorevole; due cose che secondo me è incapace di essere Midnights. Se fosse un cartello stradale non sarebbe uno stop ma un semplice dare precedenza: qualcosa che ti fa rallentare ma non necessariamente fermare, e quando vedi che la strada è libera pigi sull’acceleratore, già concentrato sui segnali che verranno e dimentico di quelli che hai superato.
Ho spulciato la Treccani per cercare un termine che descriva la sensazione che mi dà Midnights, e quel termine è “anodino”: “senza carattere, insignificante; o che non prende posizione decisa, che non esprime un parere netto”. È proprio quella mancanza di decisione che mi perseguita. Perché nonostante sia un “concept album”, il cui filo conduttore sono le notti insonni passate a rimuginare sull’esistenza, in ogni caso l’esecuzione mi pare frammentata e il tema disorganico, con tanti picchi, senza dubbio, ma anche altrettante banalità.
L’edizione “standard”, che di base è il vero Midnitghs, suona atipicamente ordinaria, scialba addirittura; non sono nemmeno sicura che lo si potrebbe considerare un buon album di debutto se fosse di un qualsiasi artista a caso, ma di certo per essere il decimo di Taylor Swift è ben poco persuasivo. Raga, sia chiaro, chiarissimo: è più che concesso, a ‘sta pora crista, di non fare gol a ogni tiro in porta, va bene pure se ogni tanto prende la traversa o spara la palla sulle tribune, perché se esiste qualcuno, in tutto il mondo mondiale, che si è guadagnato il diritto di non dover dimostrare più niente a nessuno, quel qualcuno è proprio lei.
Magari, toh, lei e Alberto Angela. Ma soprattutto lei.
Quanto all’edizione 3am, con le sue The Great War, Bigger Than The Whole Sky, High Infidelity, Would’ve, Could’ve, Should’ve da una parte e Paris, Glitch, Dear Reader dall’altra sembra mantenere l’equilibrio tra pezzi riusciti e no, anche se in proporzione e per mera questione di quantità, rispetto alla standard qui i pezzi davvero riusciti sono di più. Ed è anche questo il problema: mi resta difficile considerare Midnights come un unicum e non come due entità separate, di cui una che funziona meglio dell’altra.
E tutte le belle canzoni che pure ci sono paiono non servire un disegno unitario — l’album, appunto, col suo tema dichiarato — ma restano splendide in modo fine a se stesse, un arcipelago di isolotti con palmizi rigogliosi e lambiti da acque cristalline ma senza un istmo di terra che li unisca, o almeno un traghetto della Grimaldi Lines che li colleghi.
Potreste obiettare, e forse in parte avreste anche ragione, che non potrebbe essere altrimenti, non trattandosi di un concept album duro e puro che racconta una singola storia a capitoli come un romanzo in musica (come quelli dei Rhapsody of Fire, che hanno dato vita a vere e proprie saghe fantasy, o quelli degli Avantasia dei primi anni), e nemmeno un concept album che è espressione del modo di vedere il mondo del suo protagonista fittizio (come American Idiot dei Green Day), ma di un concept album che si sviluppa soltanto intorno a un’idea di base, a un tema e non a una trama, le cui canzoni restano slegate per forza di cose (per di più raccontando randomici pezzi di vita sparsi negli anni). Ora, anche i due album dei Sabaton a cui accennavo (The Great War e The War To End All Wars), che raccontano la prima guerra mondiale, sono composti di tanti tasselli separati — una canzone parla del Barone Rosso, una di Lawrence d’Arabia, una della tregua di Natale, un’altra ancora del trattato di Versailles e via dicendo. Ecco, nonostante ciò, entrambi gli album appaiono coesi, unitari, focalizzati, armonici. Invece Midnights mi pare disgregato.
Sbaglierò di poco se preconizzo qui e ora che, una volta placatasi la normale e fisiologica eccitazione che è corollario immancabile di ogni nuovo album di TS, Midnights passerà decisamente in sordina. Ma mi importa? In realtà no, perché potrebbe fare un album di soli borborigmi e ci sarà lo stesso almeno un paio di canzoni per cui griderò al capolavoro, di cui mi farò portavoce indefessa della loro necessarietà in riguardo al progresso della civiltà umana, e per quelle due canzoni varrà comunque la pena di star dietro, sempre e comunque, nei secoli dei secoli, a Taylor Swift.
P.S. se, stante questa mia intemerata, ci sarà qualcuno, in questo fandom di sbullonati, che mi augurerà di non trovare il biglietto per il concerto o mi accuserà di lesa maestà, ecco, io a quel qualcuno dirò: “A proposito di maestà, bravo che me l’hai ricordato, è ora di farsi un tè e di bingiare daccapo The Crown. Toodle-oo!”)
***
Per chi di voi si fosse sintonizzato soltanto adesso, ecco gli altri tomoni:
Red dead revolution
‘Cause she’s still preoccupied with 19… 19… 1989
(Frankly, me dear, I do and I don’t give a damn about my bad) reputation
(If you wanna be my) lover
That’s all folk(lore)
Quoth the raven, “evermore”
Cicero pro domo sua: giacché ho perorato la mia causa di scribacchina, ne approfitto per segnalare anche i miei due romanzi: Zugzwang - Il dilemma del pistolero e il suo sequel Sicilian Defense, editi da Nativi Digitali Edizioni. Tra i personaggi principali c’è una ragazza bionda, ma non è Taylor Swift.
7 notes
·
View notes
Text
Bajo la presión del silencio, hasta el sentimiento más puro se confunde.
-SIL. 🍀
#desorden en letras#somnium ipsa loquitur#sil#frases tristes#frases del alma#frasesbreves#frases#catarsis de almas#cosas del alma#con el alma rota#silencio#accionpoetica#accion poetica#pensar#sentir#sentimientos#miedo a amar#amarte#amar a muerte
122 notes
·
View notes
Photo

#haiku #poesia #poesiamexicana #poiesis #catarsis #creación #creatividad #poetica #poesiamexicana #poesiajaponesa #literatura #escrito #palabraescrita #arteescrito #arte #Nuevoescrito (en México, Ensenada) https://www.instagram.com/p/CNGq5b6s4Km/?igshid=kiwsxidbzolg
#haiku#poesia#poesiamexicana#poiesis#catarsis#creación#creatividad#poetica#poesiajaponesa#literatura#escrito#palabraescrita#arteescrito#arte#nuevoescrito
0 notes
Text
JOHN PEPPER
IL CONFINE ASSENTE
Gianluca Marziani
La fotografia che riparte dal punto zero, dal rumore bianco, dal vuoto apparente. La fotografia che riconquista lo spazio e il tempo, dentro la coscienza metafisica del DESERTO, nel luogo reale che più di ogni altro contiene il luogo ideale, lo spirito aleggiante, il primo suono liberato.
Scattare fotografie davanti ad un confine assente significa riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, assumendosi la responsabilità dell’immagine, abitando la coscienza divinatoria dell’occhio. Lo spazio riconquistato è lo spazio che la Storia aveva riempito in modo bulimico, è lo spazio che il Novecento ha decostruito fino a perderne frammenti, è lo spazio che il nuovo millennio cerca di diluire nel flusso liquido delle intelligenze artificiali. Il tempo riconquistato è il tempo che la Storia aveva insanguinato in una ciclica catarsi biblica, è il tempo che il Novecento ha sradicato per ripiantare semi geneticamente modificati, è il tempo che il nuovo millennio cerca di manipolare tra mistificazioni, nascondimenti e distopie. Quel confine assente permette di riappropriarsi dello spazio e del tempo liberato, acquisendo consapevolezza del “prima” e del “dopo”, di uno spazio e di un tempo che nei deserti torna originario, limpido, sostanziale. La fotografia delle assenze, per paradosso metafisico, agisce prima di ogni origine archeologica, prima del Sapiens, prima dei graffiti dentro le grotte, captando il preumano e il postumano, muovendosi nella natura naturans che distrugge per creare. La fotografia è testimone luminosa degli elementi nascosti nel vuoto, una risonanza magnetica che eccita i protoni delle antiche storie, così da catturare frammenti fatui che il nostro occhio, reale eppure fantastico, interpreta con discrezione poetica e libertà filologica.
Quando vidi per la prima volta le stampe di INHABITED DESERTS, ebbi una scarica alla radice mentale dello sguardo, nel punto limbico in cui l’esperienza visiva partorisce l’immagine matrice, la prima luce, l’archetipo da direzionare coi propri codici culturali. John R. Pepper, per un attimo, mi stava rapendo dal rumore cromatico del quotidiano. Ero dentro il rumore bianco del punto zero, nel frangente in cui comprendi la possibilità prima del caos, il nuovo inizio ciclico, la chiave di ridefinizione dello sguardo stesso.
Quei deserti sono il prologo dopo la Storia, una rinascita interiore che si sublima nel linguaggio fotografico. Qualcuno potrebbe dire che anche la pittura sia un linguaggio di rinascita, una chiave per ripulire il codice figurativo dal carico nozionistico. In realtà, se parliamo di rinascita nel tempo tecnologico, la pittura trattiene memorie secolari che ne inficiano la purezza, con l’aggiunta di una manualità dilatata che l’allontana dall’istante percepito; mentre la fotografia condensa, nella sintesi tecnologica, la rivelazione nell’occhio, l’impatto diretto sul nascondimento, l’immediatezza di una densità sottostante.
Nel deserto si condensa l’origine del fuoco, il primo nominare, il disegno rivelatorio
Il deserto aggrega genesi e miti, evocando tradizioni orali e sacre scritture, un immenso bagaglio letterario che in quel silenzio cosmico conserva la potenza di Jahvè, il seme di Adam e il suo complementare Hawwà. Nel deserto ripensiamo all’inizio biblico, a quel purissimo incipit in cui Jahvè, circondato da una terra desertificata, mette le mani nella creta (adamah) e plasma Adam, il primo uomo. Jahvè, a quel punto, crea un giardino con piante e alberi, il fatidico Eden dove Adam vive in maniera ignara, non avendo una controparte che crei il desiderio: e con esso quel senso d’incompletezza che lo porterà a cercare Lei, la parte mancante, la Ishà (Ish significa uomo) che offrirà un primo confine allo sguardo, dando pienezza al vuoto originario. Da quel momento il deserto inizia a pulsare e l’umanità, sotto le spoglie del primo connubio, tramanda la Storia.
Il deserto è lo spazio ancestrale prima dello spazio abitato, il vuoto più denso del Pianeta, geografia evocante che culla mitologie seminali. Il deserto trattiene la densità delle storie attraverso il silenzio ascetico, l’atmosfera limpida, l’impossibilità di generare caos. Perché dove non esiste rumore non può esserci mistificazione: e tutto permane in limpidezza, proprio come nel codice sorgente del Pianeta. Così tornano a galla milioni di parole tramante e di pagine scritte nei secoli, migliaia di sguardi che hanno riempito quel silenzio con le loro allegorie, i loro simboli, le loro metafore di vita. E così il deserto rivela la sua energia enciclopedica, il suo sapere originario, la sua pazienza metafisica.
Mi sovviene la letteratura radicale di Antonio Moresco, scrittore che sradica il realismo per denudare le polarità significanti dell’umano. Un approccio che ingloba religioni e mitologie, immaginando un’origine contestuale per il Primo Uomo dopo l’umanità, dopo il caos globalista, dopo la cultura del Capitale. Per Moresco il paesaggio è un soggetto narrante che conduce i sopravvissuti alle radici geologiche, dentro un processo di mineralizzazione che attira sabbia e pelle, pietra e spirito, radici e anime. Sentivo il bisogno di uno scrittore d’appoggio marmoreo, un raccordo tra le scritture sacre e il rituale di un presente senza mediazioni. Serviva una letteratura che dilatasse la sociologia metropolitana di Rem Koolhaas, l’analisi postmediale di Jean Baudrillard, l’antropologia sullo spazio urbano di Franco La Cecla. Una cifra narrativa che superasse la progressione lineare del racconto, in grado di avvicinare i tre principali libri sacri (Bibbia, Tōrāh, Corano) alla vertigine del postumano, offrendo spazio ad una metafisica del reale, dietro il reale, oltre il reale. Ed è nel superamento di una realtà apparente che cresce l’energia nascosta del deserto, la sua storia mai interrotta, la sua capacità di conservare i semi di ogni passaggio umanitario.
INHABITED DESERTS è una formidabile avventura umana che ha visto John R. Pepper tracciare linee rosse sulla mappa satellitare del Pianeta. Tre anni di lavoro e 18.000 chilometri percorsi tra Stati Uniti, Russia, Oman, Iran, Israele e Mauritania… luoghi e deserti che racchiudono complessità e diversità, due cose che lo rendono il più spoglio degli habitat ma anche la geografia spirituale di quel dato Paese, la sua sintesi denudata e preurbana. Esistono deserti di sabbia gialla o terra scura, deserti rocciosi, deserti dove il verde mantiene presenza, deserti pianeggianti o montagnosi, variabili nelle temperature, nei colori, nella fauna locale. Soprattutto, esiste un modus con cui l’autore ha fotografato decine di luoghi silenziosi nelle diverse ore della giornata. Un approccio che non segue il tema del reportage ma che, al contrario, pone il deserto sulla linea strategica di Monet e Cézanne, dove lo sguardo in bianconero seziona il visibile per ricostruirlo con lo strumento della luce. Pepper sfugge alle arguzie da software digitale, evitando il maquillage d’artificio e sposando il tema analogico in maniera sensibile. Modula le scale dei grigi con rabdomantica nitidezza, profilando le dune come fossero lame, sezionando i contrasti con ambivalenze semantiche, intuendo l’istante in cui il sole disegna senza sbavature.
La fotografia di Pepper crea un morbido clima pittorico, un’atmosfera di rarefazione modulata che sensibilizza le particelle dei bianchi e neri, suonando mille sfumature sul pentagramma visuale del grigio. Non era semplice comprendere le assenze silenziose, l’apertura infinita di campo, il peso del cielo, la sostenibilità gravitazionale della terra. Lo spazio sconfinato pone quesiti strategici, imponendo una scelta di perimetro, affinché nel confine dato si delinei la grammatica dell’occhio. Per il nostro autore quel confine è forza di gravità, stabilità ed equidistanza, espressione e concetto. Un confine che si rivela nella qualità luministica, nei tagli d’inquadratura, nell’istante prescelto, negli equilibri tra le parti. Pepper amalgama tutto ciò, creando un’estetica fortemente pittorica, sia nelle attitudini che nei risultati formali. Un’estetica che ingloba la pittura dentro la sua anima meccanica, così da mantenere immediatezza (fotografia) e durata (pittura), istante e memoria.
Dentro la natura ottica si distende il presente atmosferico, la sua dimensione fisica che implica storie di passaggi reali, comunità nomadi, conflitti e nuove armonie. Il deserto ci invita al ripensamento di molte strutture del pensiero occidentale, ad un nuovo rapporto con i confini geografici, ad un’analisi dei sistemi democratici e non. Quel vuoto lunare accoglie riflessioni lente e chirurgiche, consapevoli del reale ma anche del substrato energetico che riempie l’atmosfera animistica del silenzio. Solo qui esiste lo spazio transnazionale del dialogo platonico, una specie di terra comune in cui ridurre i conflitti mentre si affrontano crisi finanziarie, epidemie, disastri naturali e tensioni geopolitiche. Se l’umanità avrà un nuovo domani si dovrà ripartire dall’immagine simbolica di un deserto, da una dottrina che ridefinisca il peso del denaro e la sua distribuzione planetaria. Si dovrà ripartire dal silenzio, dal sapere dottrinale, dalla guida di grandi menti “postumane”.
Il vuoto apparente conserva la pienezza dell’esperienza metabolizzata
Le ombre narrano da sempre alchimie narrative, misteri fiabeschi, paure ancestrali. Sono la zona oscura dietro la luce solare, il contraltare simbolico che teatralizza i corpi nel paesaggio, esaltando il carattere ambiguo oltre l’apparenza luminosa. Nel deserto le ombre diventano giganti dal mistero solido, sorta di proiezioni panteistiche che raccolgono tracce mitologiche, passi dell’Antico Testamento ma anche zone del presente letterario, da Éric-Emmanuel Schmitt a Paul Bowles, da Joseph Conrad a Dino Buzzati. Le ombre di Pepper disegnano la luce di contrasto, sempre con granature atmosferiche dal tenore impalpabile, con quella patina gassosa che ammorbidisce le superfici, diminuendo le distanze tra una realtà percepita e un sogno ad occhi aperti. La gravità compositiva si bilancia con leggerezza aerea e spinta terrestre, sorta di cucitura tra luce e ombra per sostenere l’equilibrio iconografico dello spazio concluso. Il processo tecnico tiene assieme l’intero ciclo, dando superficie coerente ma, soprattutto, sintonia interiore alla biologia del deserto.
Qualcuno si potrebbe chiedere se esista un suono reale nei paesaggi desertici. Il vento, strumento polifonico della Natura, è la prima voce che riempie l’aria, scorrendo con flussi ondosi d’intensità variabile. Ebbene, oltre il tangibile esistono altri suoni nascosti e microscopici. E sono quei suoni di cui si accorge una certa musica elettronica, la cosiddetta noise-ambient in cui bordoni, glitch, nastri registrati, campionamenti e synth compattano il caos microscopico dei paesaggi integri. Mi riferisco a Vladislav Delay, Rafael Anton Irisarri, William Basinski, Ben Frost, GAS, Oren Ambarchi… tutti musicisti che hanno affrontato i paesaggi estremi del Pianeta, registrando la vita micro e l’eco del macro, ricucendo il caos in disordine, definendo il suono altrimenti invisibile. Sono loro la colonna sonora dei deserti di Pepper, gli artefici involontari del suono necessario, il tappeto acustico che amplifica il fattore di potenza. Fate una prova e sfogliate il catalogo ascoltando la loro musica: la vostra percezione subirà un immediato ampliamento sensoriale, a riprova di quanto siano connessi il paesaggio e il suono, il pensiero e le note, la filosofia e il pentagramma. Ciò che sembra rumore nasconde le migliori composizioni naturistiche del nostro tempo; ed è un suono arcaico, michelangiolesco, creato in purezza tecnologica. Una musica che ci stimola ad usare un microscopio interiore, ingrandendo il poco visibile dei deserti, immaginando l’invisibile della memoria, intuendo la coscienza etica di ogni storia che nel deserto ha preso forma e contenuto.
Qualcuno potrebbe chiedere lumi sulle radici cinematografiche dei confini assenti. Partirei da “Nanuk l’eschimese”, documentario del 1922 a firma Robert J. Flaherty, esempio radiante di una rivelazione del vuoto sconfinato, in questo caso tra le comunità Inuit del Circolo Polare Artico. Aggiungerei “Stalker” di Andrej Tarkovskij, il più incredibile viaggio nello sconfinamento metafisico, nel paesaggio in cui ogni assenza conserva memorie del tempo universale. Non dimenticherei il lituano Sharunas Bartas: “Lontano da Dio e dagli uomini” indaga una delle ultime popolazioni indigene della Siberia, “Freedom” affronta il tema della droga nel contesto radicale del deserto marocchino. Due film in cui vince il flusso purificato e la nitidezza del confine distante, in cui l’uomo si fonde con la biologia del paesaggio fino a perdersi senza disperdersi. E poi citerei Chris Marker con il suo montaggio di fotogrammi statici per “La Jetée”, prova definitiva di un profilo dinamico dentro fotografie che si interrogano sui confini spaziotemporali.
John R. Pepper ha evocato e risolto la sua linea d’ombra, metabolizzando l’orizzonte conradiano con l’invenzione di un proprio confine. Ha capito la quadratura dei deserti, la loro energia metaforica, il grumo di contenuti sottotraccia. Per farlo gli serviva molta pazienza, frutto di lunghe attese e utili frangenti, brevissimi istanti in cui perimetri e luce combaciavano eroticamente. La dilatazione del tempo lo ha fatto aderire alla dimensione dello spazio, al gigantismo panoramico in cui solo l’artista può gestire il fuoriscala, quel quid così abnorme da rendere la foto una momentanea particella di Dio. Ogni stampa, conservando la linea d’ombra nel cuore, risolve il tema del vuoto con l’intuizione di una pienezza invisibile. Il bianconero si riempie di lingue arcaiche, incisioni sulla roccia, parabole e racconti, si riempie di archetipi e leggende, uomini e donne, animali e vegetali, si riempie di crudeltà e bellezza, solitudine e incontro, di sentimenti estremi e piccole storie individuali… in quelle stampe non vediamo presenze umane ma percepiamo il passaggio nei millenni, le mutazioni geologiche nei milioni di anni, indietro fino al primo granello di sabbia, fino all’inizio di ogni inizio, fino al…………………..
2 notes
·
View notes
Text
“Appassionato dal carattere sibillino di ogni cosa”: non potete non leggere Giorgos Seferis, l’Odisseo del Novecento
Con levantina malizia – per altro sostanzialmente sconosciuta a un poeta della luminosità – Giorgos Seferis chiude il discorso di accettazione sul palco del Nobel per la letteratura così: “grato alla ‘bontà di Svezia’ che mi ha permesso, infine, di sentirmi come un ‘nessuno’ – intendete questa parola nel senso che Ulisse la usò per rispondere al Ciclope, Polifemo: ‘nessuno’ – un nessuno, giunto da quella corrente misteriosa che è la Grecia”. Nell’asserzione, appunto, c’è l’astuzia e la verità: tutti siamo dei ‘nessuno’ all’ombra di nomi altisonanti. In più, era il 1963, Seferis aggiungeva una stilettata: la lingua greca, che ha dato all’Occidente le fondamenta ora è un mistero.
*
Giorgios Seferis fu il primo Nobel per la letteratura greco, seguito, quarant’anni fa, da Odysseas Elytis. Al drappello avrebbe dovuto unirsi Ghiannis Ritsos, per alcuni tra i sommi poeti di sempre. Grecia terra di poeti: lo testimonia il ‘Meridiano’ Mondadori del 2010, Poeti greci del Novecento, allestito da Nicola Crocetti e da Filippomaria Pontani – figlio del grande grecista Filippo Maria. Nell’introduzione al volume complessivo dedicato a Seferis per la collana de ‘i Nobel’ – prima Club degli Editori, poi Utet – nel 1971, Vittorio Sereni parla della prima volta che ha letto il poeta greco. “Nel 1949, quando si lavorava con un gruppo di amici a ‘La Rassegna d’Italia’ allora diretta da Sergio Solmi, ci arrivò un plico da Giuseppe Ungaretti. Conteneva le prime cinque poesie di Seferis tradotte in Italia ad opera di quello stesso Filippo Maria Pontani che già ci aveva fatto conoscere la poesia di Kavafis. Le poesie apparvero nel numero di luglio-agosto della ‘Rassegna’ e dettero inizio alla fortuna del poeta in Italia”. Fortuna oggi decisamente defunta. Le Poesie di Seferis nella traduzione di Pontani, infatti, vengono pubblicate da Mondadori nel 1963 e continuamente ristampate fino agli Ottanta, quando escono dall’orbita della fama. Per fortuna, piuttosto, che c’è Nicola Crocetti: nel 2017 traduce Le poesie di Seferis per la propria casa editrice.
*
Oggi i poeti modesti si leggono tra loro, si commentano, sanno cosa ha scritto Pico Pallino e ne citano con aspro gusto qualche verso udito nella città di X al festival Y. Non leggono i grandi. Chi legge oggi Seferis? Il grande poeta de Il “Tordo” e del Re d’Asíne, poesie che sono nel carnet di chiunque scriva, di chiunque sia davvero uomo, insieme a quelle di Iosif Brodskij – a cui lo apparenta l’esilio – e di Yves Bonnefoy, di W.H. Auden e di Kavafis, di Thomas S. Eliot e di Eugenio Montale e di Osip Mandel’stam, per dire. Sentite:
Tutto il mattino scrutammo d’intorno la rocca,
cominciando dal lato dell’ombra, dove il mare verde
senza barbagli, petto di pavone ucciso,
ci accolse come il tempo senza vuoti…
Dalla parte del sole un lungo litorale spalancato,
e la luce forbiva diamanti alle muraglie.
Non v’era creatura viva, fuggiaschi i palombacci
e il re d’Asíne, che cerchiamo da due anni,
sconosciuto e scordato da tutti, anche da Omero
una parola sola nell’Iliade, e mal certa
gettata qua come la funebre maschera d’oro.
La toccasti, ricordi il suo rimbombo? Vuoto nella luce,
un doglio secco nel suolo scavato;
eguale era il rimbombo del mare ai nostri remi.
Il re d’Asíne, un vuoto sotto la maschera, sempre
Con noi, sempre con noi dovunque, dietro un nome…
I suoi figli statue, battiti d’ali le sue brame e il vento
nelle more dei suoi pensieri, e le sue navi
attraccate in un porto sparito.
Sotto la maschera un vuoto.
*
La grandezza stordisce perché Seferis porta l’arcaico nell’oggi, istoriando la luce, dando tempo alla fermezza. Si potrebbe fare una conferenza su quella similitudine – che è ‘modernista’ ed è del sempre. Il mare che è come un “petto di pavone ucciso” e che “ci accolse come il tempo senza vuoti”.
*
Henry Miller va in Grecia per conoscerne il poeta, quell’Odisseo risorto nel Novecento. Nel Colosso di Marussi, pubblicato nel 1941, lo descrive così: “languido, soave, vitale, capace di sorprendenti atti di forza e d’agilità… vi viene incontro con tutto il suo essere, avvolgendovelo intorno al braccio con calore e con tenerezza… appassionato dal carattere sibillino di ogni cosa”. Una squillante vitalità tesa ai sibili del creato.
*
Mi appassiona questa denuncia di poetica. “Non è la mia opera che m’interessa al di sopra di tutto: è l’opera, senza alcun possessivo: è questa che deve vivere, ove pure in essa si brucino i nostri contributi individuali. Ho la più chiara coscienza che non viviamo in tempi in cui il poeta possa credere che l’attende la fama, bensì in tempi di oblio. Ma questo non m’induce a essere meno devoto al mio credo: lo sono di più”. Una miniera di luce nell’oblio. Certi che non esiste un ‘proprio’ nella poesia – semmai, l’appropriato, l’appropriarsi di un’era, di cui si è la torcia, quello che fiamma – e brucia, spegnendosi.
*
Nel 1949 Filippo Maria Pontani, il primo e fedele traduttore, ne scrive così. “Ha rotto definitivamente gli schemi di una tradizione esausta. La sua rivoluzione può assegnargli il posto che spetta nella lirica italiana all’Ungaretti, mentre più d’un aspetto dell’ispirazione e della forma, e l’amore per T.S. Eliot, fanno talora pensare al Montale. Il mondo del S., pieno di accoramento per la sua terra (echi profondi della tragedia microasiatica), percorso dall’alito del mare, dalla memoria attonita e commossa delle reliquie, dei simboli, dei miti di mondi sepolti, dall’amaro disincantamento della vita quotidiana, è un mondo di cupo e tragico pessimismo, che trova in una poesia via via più libera da compromessi di ‘canto’, austera insieme e tremante, grave e pura, schiva e padroneggiata e tuttavia suggestivamente evocativa, la sola, e la più alta, catarsi”.
*
L’esilio è l’emblema della vita di Seferis. Prima lo subisce, tragicamente. Nativo di Smirne, nel 1922, di fronte all’avanzata violenta dei turchi di Kemal deve ritirarsi con la famiglia ad Atene. Così racconta i fatti Vittorio Sereni: “In una situazione di per sé confusa, complicata dall’oscuro intralcio di interessi delle potenze dell’Intesa, i fatti si svolsero sotto gli occhi dei rappresentanti di queste, sia diplomatici sia militari. Truppe turche entrarono a Smirne il 9 settembre del 1922 e il 13 il fuoco avvampò… massacri e sevizie si svolsero anche alla luce del giorno e i turchi sparavano su quanti cercavano scampo verso il mare per un imbarco disperato su qualunque mezzo natante. Tra i 75.000 e 100.000 fu calcolato il numero delle vittime, molte delle quali giacevano sulla pubblica via”. Seferis studia giurisprudenza a Parigi, con il padre. In quel disastroso 1922 Thomas S. Eliot pubblica La terra desolata, così importante per Seferis. Avviato alla carriera diplomatica, il greco incontra il poeta prediletto nel 1951, quando è in Inghilterra al servizio del ministero degli esteri. In UK, poi, sarà ambasciatore dal 1957 al 1961. Tre anni prima di Seferis, nel 1960, un altro poeta alto diplomatico fu insignito del Nobel, Saint-John Perse, seguace di un altro poeta diplomatico, Paul Claudel. I poeti, celebri o pezzenti, sono sempre in viaggio, in mondi ‘altri’.
*
Poeta disincantato, teso alla vita, Seferis è un diarista eccellente. La ‘lettera’, in lui, non predomina sul frugare il giorno: il corpo si fa verbo, semmai, la parola intenzione che tende le dita. “Un qualunque villaggio mi darebbe mille volte più umanità della giungla ateniese. Bisogno intenso – ieri e oggi – di lasciare tutte queste idiozie: non per avere il tempo di fare letteratura, ma per maturare e morire da uomo”. E poi: “Nel pomeriggio ho spaccato legna fino all’imbrunire. Sono tornato a casa sudato, con le mani piene di resina. Bagno; e poi mi sono seduto al mio tavolo. Ho finito la poesia. Titolo: Il “Tordo”. Non so se è buona. So che è finita. Adesso deve asciugarsi”. Spaccare la legna come scrivere poesia; il sudore e l’asciugatura della poesia, essudata.
*
Bisognerebbe ripubblicare il diario in cui Seferis racconta dei suoi incontri con Thomas S. Eliot lungo un decennio, dal 1951 (“da Stephen Spender, ricevimento in onore di Auden… ho conosciuto Eliot. Sennonché le cose erano organizzate in tal modo che ha parlato tutta la sera con mia moglie. Erano sistemati alla stessa tavola”) al 1962, con quella chiusa, “Mentre lo salutavo, mi ha chiesto come ci facciamo il segno della croce noi ortodossi”.
*
Il dettaglio dell’appartamento di Thomas S. Eliot a Kensington (è il 10 dicembre 1960) dice del carattere del poeta. “Nessun lusso all’interno; arredamento piuttosto impersonale, a una prima occhiata. Fuoco acceso nel caminetto del salotto. Al muro uno schizzo di Pound, fatto da Wyndham Lewis, un piccolo paesaggio di John Ruskin e un acquerello di Edward Lear. C’era anche un busto del poeta, di J. Epstein, che non m’ha entusiasmato”. Il poeta che si autocanonizza – con busto in casa – parla per accenni, vescovili. “Abbiamo parlato di Pound. Ha detto bene dei Canti pisani. ‘Era sempre in movimento’, ha continuato, ‘tutto il tempo di Londra ha portato camicie Schiller, sempre trasandato. Più tardi ho saputo – ha sorriso – che se le faceva su misura’”. Cattedratico, cardinalizio, mai una parola di troppo, Eliot è il poeta cittadino che del sodale dice per accennare alle camicie, allo stato trasandato. Dall’altra, il poeta della vitalità, solare, che spacca la legna ed è abbagliato dal nitore formale della poesia eliotiana. Che incontro buffo: l’uomo e il verbo, l’omerico e il labirintico, la luce e l’ombra.
*
Seferis ha tradotto il Cantico dei Cantici e l’Apocalisse; ha scritto un saggio sulle ambigue prossimità tra Eliot e Kavafis. Ha detto: “Quanto più l’artista è ‘pari a se stesso’ tanto più pienamente trasfonde il suo tempo nell’opera”. L’impegno di un poeta con la propria epoca è diventare uomo, individuo scalpellato dal verbo, autonomo, mai in resa. (d.b.)
**
Argonauti
E un’anima
se si vuole conoscere
in un’anima
rimiri:
lo straniero, il nemico, lo vedemmo allo specchio.
Erano bravi ragazzi i compagni, non gridavano
né di stanchezza né di sete né di gelo,
erano come gli alberi e le onde
che ricevono vento e pioggia
ricevono notte e sole
senza mutare in mezzo a mutamenti.
Erano bravi ragazzi, interi giorni
sudavano sul remo, gli occhi bassi,
respirando in cadenza
e il sangue imporporava una docile pelle.
Cantarono una volta, gli occhi bassi,
quando doppiammo l’isola scabra dei fichi d’India
a ponente, di là da quel Capo dei cani uggiolanti.
Se si vuole conoscere – dicevano –
miri in un’anima – dicevano –
e battevano i remi l’oro del mare nel crepuscolo.
Passammo capi molti molte isole il mare
che mette ad altro mare, gabbiani, foche.
Ululati di donne sventurate
piangevano i figli perduti,
altre come frenetiche cercavano Alessandro
Magno, glorie colate a picco in fondo all’Asia.
Attraccammo
a rive colme d’aromi notturni
e gorgheggi d’uccelli, e un’acqua che lasciava nelle mani
la memoria di gran felicità.
Non finivano, i viaggi.
Si fecero le anime loro una cosa sola con remi e scalmi
con la grave figura della prora,
col solco del timone, con l’acqua che frangeva
gli specchiati sembianti.
I compagni finirono, a turno,
con gli occhi bassi. I loro remi additano
il posto dove dormono, sul lido.
Non li ricorda più nessuno. È giusto.
Giorgos Seferis
Da “Leggenda”, 1935; traduzione italiana di Filippo Maria Pontani
L'articolo “Appassionato dal carattere sibillino di ogni cosa”: non potete non leggere Giorgos Seferis, l’Odisseo del Novecento proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2H2gjJ9
5 notes
·
View notes
Link
William S. Burroughs e la tecnica del cut-up19 ottobre
Quando cominciò a insegnare scrittura creativa al City College di New York,
William Seward Burroughs II
non era molto convinto di quello che stesse facendo. Innanzitutto, non era certo che la scrittura si potesse insegnare; il suo era stato un percorso lungo e accidentato, al termine del quale aveva capito che scrivere era anche una forma di catarsi. «Non potete scrivere a meno che non vogliate scrivere, e non potete volerlo a meno che non ve lo sentiate». Perciò: che cosa stava facendo? E poi doveva scontrarsi con l’idea che gli studenti si erano fatti di lui leggendo i suoi libri: «Erano delusi perché durante la lezione avevo giacca e cravatta; si aspettavano di vedermi comparire nudo con su un cazzo finto, credo».
William Burroughs era diverso dagli altri membri della
Beat Generation
, molto diverso da Jack Kerouac. Quando i due s’incontrarono per la prima volta, nel 1944, Kerouac aveva ventun anni e aveva già deciso che sarebbe diventato uno scrittore. Parlava sempre di scrittura e di libri, e spesso se ne stava seduto in un angolo con un taccuino. Scrivere era la sola cosa a cui pensava, non aveva mai voluto fare altro. Burroughs, invece, era sempre stato più inquieto. Sebbene fosse omosessuale, si sposò due volte. Dalla seconda moglie, Joan Vollmer, ebbe anche un figlio, ma la relazione finì in tragedia: in un episodio che non fu mai chiarito, una specie di rievocazione della leggenda della mela di Guglielmo Tell, dalla pistola che Burroughs aveva tra le mani partì un colpo che uccise sua moglie. Qualche tempo dopo, dichiarò: «Sono obbligato a giungere alla terrificante conclusione che senza la morte di Joan non sarei mai diventato uno scrittore».
Viaggiò moltissimo, tra l’Europa e il Sud America. Per un lungo periodo stette a Tangeri, in Marocco: era già tossicodipendente, e alternava momenti di lucidità a giorni di cupa apatia. Nel 1957, Allen Ginsberg e Jack Kerouac andarono a trovarlo e scoprirono una serie di appunti interessanti. Erano frammenti allucinati e sconnessi, storie di sesso e droga e violenza e morte oltre ogni trasgressione, visioni terrificanti condite di umorismo nero, esperienze autobiografiche che a tratti assumevano un tono documentaristico. Interrogato su quei testi, disse soltanto che scriveva
le cose più orribili che riusciva a immaginare
. Burroughs è inquietante e affascinante allo stesso tempo; la sua scrittura è lirica, così poetica, anche (soprattutto) quando affonda nelle scene più squallide. Quando si ha la tentazione di distogliere lo sguardo, una goccia di sangue sul braccio di un drogato «sboccia come un fiore cinese». In un attimo «un’orchidea rossa fiorì all’estremità del contagocce». Kerouac e Ginsberg aiutarono Burroughs a rendere gli appunti più organici e il risultato di quel lavoro s’intitola
Pasto nudo
(il titolo lo scelse Kerouac perché quel libro era la rappresentazione più precisa di “un attimo congelato, quando ognuno vede cosa c’è sulla punta della forchetta”). Resta un romanzo irregolare, non sempre efficace, a tratti così straniante da risultare inaccessibile, senz’altro unico nel suo genere.
«Tutto appartiene al ladro ispirato e devoto»
Dopo il periodo vissuto a Tangeri, William Burroughs si trasferì a Parigi dove conobbe il pittore Brion Gysin. I due avviarono una relazione che condizionò anche la scrittura; Burroughs perfezionò la frammentazione che aveva sperimentato con Pasto nudo attraverso lo studio della tecnica del cut-up. Partendo dall’assunto che anche la parola è un’immagine, il metodo consiste nel tagliare delle pagine di un testo per rimetterle insieme in combinazioni a montaggio; vuol dire saccheggiare le opere degli altri, letteralmente, collegando «pezzetti vividi di dettagli che svaniscono». Succede comunque, diceva Burroughs, l’influenza tra artisti è fondamentale nel processo creativo, perché non possiamo rubare consapevolmente? Insieme a Gysin scrisse un manifesto dal titolo Les Voleurs.
Parole, colori, luci, suoni, pietra, legno, bronzo appartengono all’artista vivente. Appartengono a chiunque sappia usarli. Saccheggiate il Louvre! A bas l’originalité, lo sterile e assertivo ego che imprigiona mentre crea. En haut le vol – puro, sfrontato, totale.
Questa e molte altre riflessioni sono contenute in
La scrittura creativa
, una raccolta di articoli che Burroughs scrisse per la rubrica
The time of the assassins
che teneva sul mensile
Crawdaddy
, testi rielaborati e integrati per letture pubbliche, conferenze e lezioni. Secondo Burroughs, la scrittura doveva svincolarsi dalla «camicia di forza sequenziale e figurativa del romanzo» perché «
la coscienza è un cut-up; la vita è un cut-up
. Ogni volta che andate giù per la strada o guardate fuori dalla finestra, il fluire della vostra coscienza è tagliato da fattori a casaccio».
I primi esperimenti di
cut-up
di Burroughs e Gysin confluirono nel libro
Minutes to go
del 1959. I due estrapolavano passi dalla Bibbia, da Shakespeare, e poi li mescolavano con altri frammenti: i risultati erano imprevisti, i periodi assumevano nuovi e più ambigui significati. Gran parte del lavoro consisteva nel selezionare il materiale stilisticamente interessante per distinguerlo da ciò che restava un ammasso insensato di parole. Un’evoluzione del
cut-up
è il
fold-in
, che si sostanzia nel piegare una pagina in due e di porla accanto a un’altra per ottenere un terzo scritto. Dalla carta passarono al magnetofono: registravano le loro voci, poi acceleravano e rallentavano il nastro, tornavano indietro, tagliavano e montavano. Burroughs affermò che quando si facevano esperimenti di
cut-up
per lunghi periodi, alcune rielaborazioni sembravano riferirsi a eventi futuri. Una sorta di allarmismo generale si diffuse in Inghilterra nel 1971, quando Konstantine Raudive utilizzò la tecnica per il progetto
Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead
. Burroughs era annoiato da certe questioni («Be’, cosa si aspettavano? Un coro d’angeli con suggerimenti per le operazioni in borsa?»), non era coinvolto dalla natura delle voci, era soltanto affascinato dalle potenzialità della tecnica.
Burroughs utilizzò il metodo del cut-up in alcuni romanzi (come Strade morte o Interzona), ma sapeva che libri troppo sperimentali non trovano grande riscontro tra i lettori, così cominciò a usarlo per fini specifici: per descrivere, per esempio, stati di alterazione o dissociazione mentale di alcuni personaggi. Aveva notato proprio questo: che i risultati ottenuti applicando la tecnica alla scrittura erano molto simili ai discorsi che potevano appartenere a soggetti con disturbi psichici. Allen Ginsberg sosteneva che dietro la tecnica del cut-up c’era un’ambizione più elevata che partiva dal presupposto che le singole impressioni sensoriali fossero condizionate dal linguaggio e dalla forma di pensiero che si apprendono dalla nascita. Secondo Ginsberg, Burroughs cominciò a sospettare, in modo più o meno patologico, che queste impressioni potessero addirittura essere state programmate nel nostro corpo, in un progetto di condizionamento universale. Come scrive Lemarie, autore della sua biografia: «Il contagio virale è più di un’ossessione nell’opera di Burroughs. È il fondamento della sua mitologia».
***
Pasto nudo
. Adelphi, 2009. Traduzione di Franca Cavagnoli.
La scrittura creativa
. Sugarco edizioni. Traduzione di Giulio Saponaro.
Un estratto da
William Burroughs. Una biografia
di Gérard-Georges Lemaire.
Bonus track per scrittori
Uno dei compiti che Burroughs assegnava più spesso ai suoi studenti era
L’esercizio passeggiata
. Consisteva nel fare una passeggiata, appunto, con l’attenzione rivolta a un solo aspetto delle situazioni che s’incontravano. La versione originale di questo esercizio gli era stata insegnata in Ohio da un vecchio don della Mafia. L’intento è “vedere chiunque prima che lui veda te”. Se lo farete, diceva, vi renderete conto che ci sono altri attori che stanno facendo il vostro stesso gioco. Prima o poi, per quanto possiate essere bravi, qualcuno vi vedrà. Cercate di indovinare perché vi ha visto. E poi chiedetevi: a cosa stavate pensando quando siete stati scoperti?
p.s.: quando William Burroughs viveva a Tangeri, gli abitanti della zona lo chiamavano
El hombre invisible
.
1 note
·
View note
Text

Volevo nascondermi | Mariano Iacobellis S.I.
Volevo nascondermi, ultima fatica di Giorgio Diritti, è un film intenso che racconta la ricerca di senso di un uomo, apparentemente abbandonato da tutto e da tutti, che trova finalmente un modo per riuscire a esprimere il suo sfavillante mondo interiore con il disegno e l'arte figurativa.
L'incredibile biografia di Antonio Ligabue, uno dei principali pittori italiani del ‘900 – ma anche una persona che conosceva perfettamente cosa volesse dire soffrire e sentirsi soli nella vita di tutti i giorni – consente allo spettatore di fare un’esperienza visiva che definirei quasi una mistica del colore. Lo spettatore entra nei quadri di Ligabue, fa le stesse sue esperienze, vede con lo stesso occhio, diviene, in qualche modo, anche lui animale. Elio Germano, che aveva già vestito i panni di Leopardi, dà un volto e un’umanità indimenticabili a questo Ligabue, oltre a compiere una prova attoriale vigorosa, di rara freschezza e intensità. Come Ligabue compie la stessa catarsi che l’artista metteva in atto realizzando le sue opere. L’artista prende forma lentamente, si plasma come la creta che lavora, ruggisce come la tigre che dipinge, urla come la scimmia che trasfigura le sue urla più profonde.
La regia, tenera e coinvolgente nel modo di descrivere il mondo della Bassa coi suoi panorami e personaggi, così come poetica e folle nell’entrare nel mondo interiore di Ligabue, rimane molto didascalica e non va ad approfondire i tasselli che ne compongono la sceneggiatura. Il racconto rischia di ancorarsi troppo a una leggerezza di fondo, quasi favolistica, e non tematizza, ad esempio, la durezza degli animi di una popolazione distrutta dalla Seconda guerra mondiale.
Tuttavia il film di Diritti è di solida fattura e di solida onestà emotiva ed evita di essere piattamente illustrativo e caricaturale: non deraglia seguendo altri esempi di ritratto d’artista (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Schnabel, per esempio) ma apre, invece, una finestra sull’umanità stupefacente di uno dei più singolari artisti italiani del Novecento, facendoci entrare in un mondo fatto al contempo di inquietudine, sofferenza, dolore e profonda bellezza.
youtube
0 notes
Text
DARIO FO
La voce dei piccoli. Dario Fo era un drammaturgo, attore e regista. Rappresenta il potere dei senza potere perchè con i suoi spettacoli riesce a denunciare i problemi che accomunano la società e a ridicolizzare il potere con la sua abilità rappresentata da gesti e dalla sua voce.

Per comprendere meglio il suo teatro possiamo metterlo a confronto con altre due correnti che sono: la commedia dell’arte e il teatro naturalista.
La commedia dell’arte è nata in Italia nel sedicesimo secolo ed è rimasta popolare fino alla metà del diciottesimo secolo. Non si tratta di un genere di rappresentazione teatrale ma di una diversa modalità di riproduzione degli spettacoli. Infatti venivano rappresentate vicende ispirate alla realtà quotidiana, arricchite con numeri acrobatici, danze e canti. Per gli spettacoli gli attori utilizzavano semplici palchi all'aperto o luoghi più convenzionali per spettacoli. Le rappresentazioni non erano basate su testi scritti ma su dei canovacci anche detti scenari. Le commedie avevano personaggi dai caratteri stereotipati, un'esagerata gestualità, dialoghi basati sull'improvvisazione, interludi musicali e buffonerie. Vi erano 'tipi fissi', cioè personaggi che tornavano da uno spettacolo all'altro (come Arlecchino, il Capitano, Brighella ecc.); alcuni dei personaggi portavano sul volto maschere di cuoio e sulla scena si intrecciavano dialetti e lingue differenti.
Mentre Il teatro naturalista nasce nella seconda metà del 1800, fu influenzato dal realismo e naturalismo quindi caratterizzato dallo stile enfatico della recitazione che affermava la necessità di dare anche in teatro un quadro autentico del mondo in tutti i suoi aspetti, compresi quelli più quotidiani e sgradevoli. Era un tipo di teatro che tenta di creare una perfetta illusione di realtà attraverso una serie di strategie drammatiche e teatrali: linguaggio quotidiano; una laica visione del mondo; un focus esclusivo su argomenti che sono contemporanei e indigeni, un ampliamento della gamma sociale dei personaggi ritratti ( da aristocratici del dramma classico , verso borghese e alla fine i protagonisti della classe operaia). I personaggi dovevano essere carnali e sanguigni; la loro motivazione e le loro azioni dovevano essere messe a nudo nella loro ereditarietà e nell'ambiente. La presentazione di un lavoro naturalistico, in termini di impostazione e prestazioni, doveva essere realistico e non appariscente o teatrale. Le idee darwiniane pervadono i lavori naturalistici, in particolare nel determinare l'influenza dell'ambiente sul personaggio e come motivazione del suo comportamento.
Nel teatro di Dario Fo troviamo sia un’unione di entrambi questi due movimenti ma anche delle differenze tra loro. In generale comunque Fo rappresentava i comportamenti umani raccontando storie. Si mostra come un giullare, un personaggio ingombrante che conquistava il pubblico con un linguaggio scenico (il grammelot) che non si fonda sull’articolazione di parole ma riproduce alcune proprietà del sistema fonetico, il che fa sembrare che il giullare faccia un discorso quando in realtà è una sequenza rapida di suoni. Con la figura del giullare fo vuole proprio mostrare l’umanità in tutte le sue sfaccettature, fo occupò tutta la sua vita a indagare ogni aspetto della realtà e spesso e volentieri lo mette in scena ridicolizzandolo, proprio appunto come facevano i giullari medievali alla corte del signore. Lui utilizza la satira (un genere di composizione poetica a carattere moralistico o comico) che mette in risalto costumi o atteggiamenti comuni alla generalità degli uomini. Con la satira riesce a mostrare aspetti dell’uomo ma anche a bilanciare argomenti piuttosto complicati che vanno dalla storia, alla politica, attraverso una semplicità d’espressione. Il teatro di fo è anche un’innovazione perché lui non rappresenta un personaggio sulla scena ma racconta una storia al pubblico; e Fo è un mago nel rendere unica la storia che racconta, proprio come un giullare in piazza. Lui crea la scena semplicemente con il suo corpo e con la sua gestualità, non indossa maschere, non indossa costumi, trucca e non ha scenografia. Con la sola forza del gesto l’attore riesce a evocare oggetti, ambienti e situazioni. La parola unita al gesto permette a fo di interpretare più di un personaggio sulla scena alla volta e in diversi contesti. Non essendoci un’identificazione completa dell’attore con il personaggio fo riesce non solo a raccontare qualcosa ma anche a fornire gli spettatori un’interpretazione del brano. La sua recitazione è quindi straniata e partecipata allo stesso tempo. Le introduzioni delle sue opere servono all’attore anche per instaurare un rapporto dialettico con il pubblico, riesce infatti a rendere lo spettacolo un dialogo diretto tra palco e platea, togliendo inoltre le vesti del teatro leggero al quale erano abituati gli spettatori. Infine, i prologhi hanno una funzione esegetica cioè espositivo e interpretativo spiegando ciò che sta per accadere, inoltre i suoi monologhi non sono sempre di facile comprensione alla platea.
https://www.youtube.com/watch?v=D5vwrEmX5eA&feature=youtu.be
Fo inoltre scrisse un libro chiamato nuovo manuale minimo dell’attore durante la pubblicizzazione di questo libro in un’intervista elenca le 5 regole base per diventare buoni attori secondo la sua opinione:
· Conoscere tutti i mestieri del teatro. Bisogna sapere tutto quello che succede durante la rappresentazione come gli ha insegnato Strehler (regista e direttore artistico italiano), infatti Fo si è reso conto che il professore non lasciava perdere nulla, dalle luci alle scenografie.
· Rompere la quarta parete. Fo credeva che alcuni attori oggigiorno non sanno nemmeno cosa sia la quarta parete (confine ideale interposto tra palcoscenico e platea con il pubblico, quel limite che separa la finzione scenica-rappresentativa dalla realtà, rompere la quarta parete significa rompere l’illusione scenica); l’attore deve riuscire a tirare sul palcoscenico l’ascoltatore, e per far questo bisogna sapere dei trucchi; come per esempio il ritmo improvviso, il gioco confidenziale, l’abbassamento della voce o il gridare a sproposito ma con ironia.
· Giocare con l’imprevisto. Per Fo è importante creare il finto incidente che piano piano si legava ad altri e diventava enorme e che coinvolgeva con paura, con ansia il pubblico che perdeva la sua condizione di spettatore e arrivava a trovarsi in una specie di disperazione. Poi alla fine avveniva la catarsi finale rovesciata e quindi al posto dello spettacolo creava nello spettatore un pensiero.
· Rappresentare non recitare. Il recitare fa si che la voce e il gesto diventino quasi anonimi. Invece la rappresentazione diventa presenza vissuta dall’attore che sta raccontando; e racconta qualcosa che gli sta addosso e che deve togliersi dal cuore dalle spalle per proiettarlo e coinvolgere il pubblico.
· L’attore è generoso. Ci si deve esporre, per essere attori bisogna tirar fuori da te anche il negativo, non soltanto il positivo. Il coinvolgimento totale del pubblico arriva quanto tu hai il tuo essere vivo in similitudine a quello dello spettatore.

VINCITORE PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA
0 notes
Text
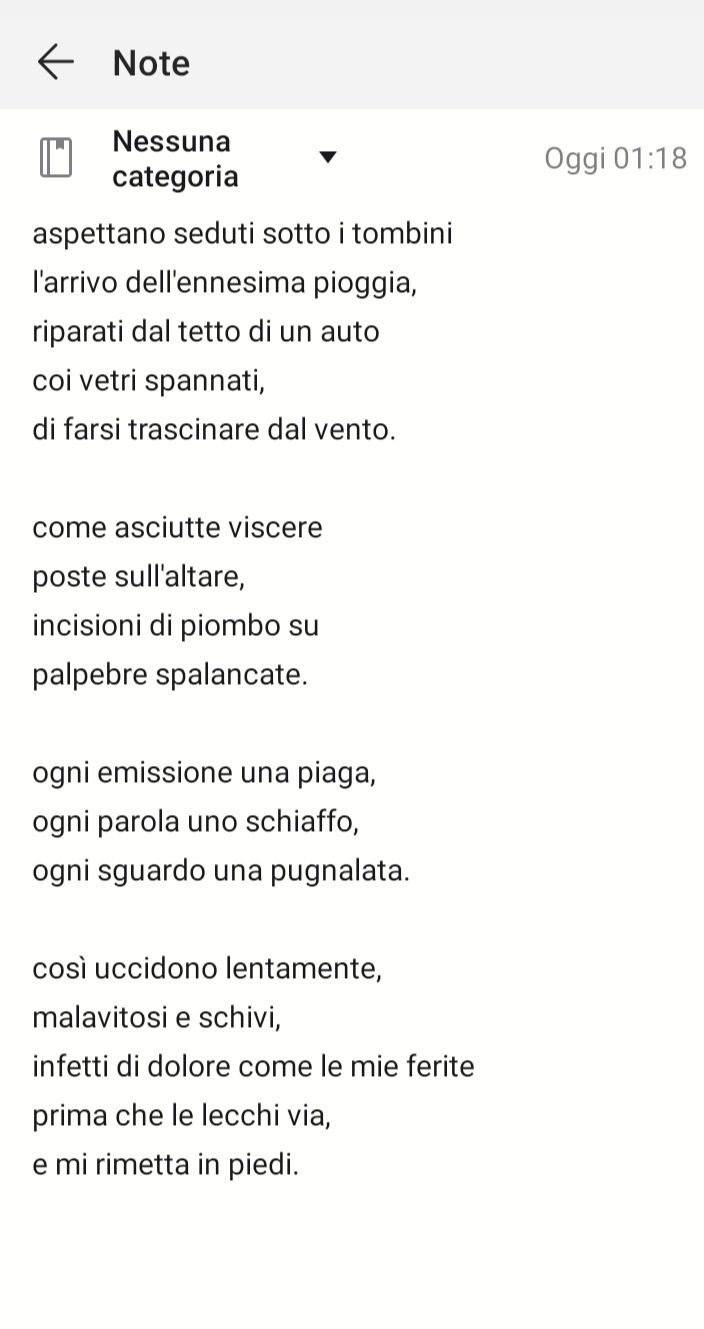
riesco a raggiungere la catarsi poetica solo con tumlr
0 notes
Text
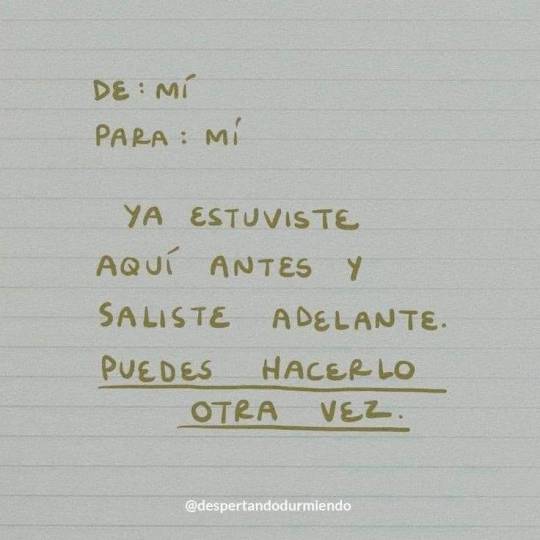
@despertandodurmiendo
#citas#escritos#frases#notas#imagenes#catarsis poetica#catarsis#casiopea#febrero2024#a tu medida#en tu orbita
8K notes
·
View notes
Text
Catarsis.
Era innecesario enterrarme 384.400 metros bajo mis pensamientos cuando no sientes, porque quiero que sientas, sientas lo que yo no y resistas lo que no resistí. Siente y resiste.
0 notes
Text
Tra Colle Brianza, Ello, Olgiate Molgora e Olginate, la sedicesima edizione de Il Giardino delle Esperidi fa muovere i primi passi alla stagione festivaliera del Belpaese.
L’aspirazione era già alta prima che inverno e primavera venissero compromessi dalla diffusione del Covid-19 e dalle relative misure restrittive. Oggi, superato il primo mesiversario della ripartenza e lanciato il cuore oltre l’ostacolo, la brigata di Campsirago Residenza, organizzatrice del festival, decide che è arrivato il momento di provare a ripensare le condizioni materiali in cui sarà possibile esperire l’atmosfera del teatro en plein air e mettere alla prova tanto la disponibilità e l’interesse del pubblico, quanto la creatività e la resilienza degli artisti.
Il risultato è un cartellone ampio e fitto di spettacoli dal mattino alla sera, con la novità di una sezione dedicata ai ragazzi e la conferma della propria declinazione sul contemporaneo. Dalla Natura, tema inizialmente individuato, alla Luna, focus attuale, il passo è stato breve, perché le Esperidi confermano de facto la necessità di una riflessione artistica sul corretto e responsabile posizionamento del Pianeta rispetto a un ecosistema che deve, per forza di cose, dalle sue radici ai suoi sviluppi, essere rivisto in maniera radicale.
Un riposizionamento dalla terra alle stelle che, dunque, non ha sconvolto (e forse non sarebbe potuto essere diversamente, vista la complessità organizzativa imposta dalle norme nazionali e regionali sulla gestione postpandemica) i fondamentali di una manifestazione che, ormai adolescente e a vele spiegate verso la maturità, anela a cogliere entrambe le facce della crisi di un’epoca le cui fondamenta sono ormai franate, ma in cui, allo stesso tempo, sarà possibile scorgere nuove e feconde opportunità di ricostituzione per reggere l’urto del pessimismo in un’ottica scevra da nichilismo.
La nostra presenza è stata limitata ai primi due giorni di festival, quando le novità sono ancora tangenti all’incertezza, ogni cosa, anche la più scontata, necessita – dopo essere stata definita sulla carta – di essere sperimentata sul concreto e ogni routine deve affrontare gli inevitabili imprevisti che sempre possono minacciare lo spettacolo dal vivo e, in particolare in questi tempi bui, attendere al varco i coraggiosi organizzatori di ambiziose attività culturali come le Esperidi.
La prima giornata è stata aperta dallo spettacolo per bambini Favole al telefono di e con Anna Fascendini. Si tratta della messa in scena di un progetto di riflessione sulla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari che ha coinvolto decine di compagnie su tutto il territorio nazionale durante il periodo di confinamento e che vede il coinvolgimento attivo dei bambini nella costruzione di storie fantastiche a partire dal loro stesso vissuto. L’allestimento, purtroppo un po’ perché incastrato in una gestione macchiettistica della relazione con i piccoli complici, un po’ perché ingessato in un forzato spontaneismo creativo, è sembrato essere ancora lontano dal restituire in maniera adeguata nella forma e nei contenuti l’audace tentativo di riscoprire e attualizzare il genio di Rodari.
A tarda serata, è scoccata l’ora di Weiss Weiss. L’essere del non essere. Sulla sparizione di Robert Walser, un esplicito omaggio al controverso e geniale scrittore elvetico da parte della compagnia sperimentale del Teatro della Contraddizione con la direzione di Marco Maria Linzi.
Lo spunto drammaturgico è il Jakob von Gunten, il poetico e immaginifico romanzo in cui, con tratti profondamente autobiografici, Walser raccontò l’eccentrica vicenda di un giovane che, alla ricerca dell’indipendenza, decise di iscriversi alla scuola di formazione per servitori Benjamenta.
Il dramma dipana una storia contorta e intrecciata, letteralmente interminabile, con svariati pseudo-finali e un alto tasso di paradossalità – ulteriormente potenziato da riferimenti visionari ad altre opere dello stesso autore. Suggestivo nella composizione scenografica, funzionale nella vestizione dei personaggi (anche se stucchevole nei banali echi burtoniani e alla The Walking Dead dei tableaux vivants attraverso i quali si realizza scenicamente), ottimo nella tenuta attoriale e poderoso nella disciplina nella loro direzione, lo spettacolo del Teatro della Contraddizione aderisce a un registro brechtiano con innesti kantoriani e si mostra volutamente freddo – per l’impostazione straniante – e consapevolmente lontano da ogni fruizione popular – per la restituzione onirica slegata dalla razionalità e i tempi estremamente dilatati.
Weiss Weiss, al netto della lodevole volontà di proporre un personaggio che in Italia non gode del meritato riconoscimento, è un esempio di teatro ingenuamente furioso nella reazione alle secche del conformismo, ma clamorosamente disciplinante, dunque perfettamente contraddittorio rispetto alle proprie intenzioni di scardinamento dello status quo e, di conseguenza, arido per chi si aspettava in qualche modo mutuata la controversa poetica di Walser in un atto visivamente meno legato a un flusso di parole degno del Novecento di Baricco trasposto nel kolossal da quasi tre ore di Tornatore.
Se da un lato lo spettacolo cerca di sfidare l’accomodante comprensione borghese collocandosi maldestramente nella prospettiva di un lirismo patetico e moralistico, dall’altro esso risulta essere talmente esasperante nel ripetere ad libitum momenti e scelte insignificanti – se non proprio contraddittorie – dal punto di vista storico, psicologico ed estetico da vanificare soluzioni che parevano essere se non proprio vincenti, quantomeno efficaci. Dall’improbabile accento russo degli interpreti all’esondazione zombie oltre la quarta parete nel corso dell’ennesimo finale, dall’insistito frontalismo alla pedante predica di Jacob, dalla piatta bidimensionalità in cui viene degradata l’interessante composizione scenografia alla dirompente dolcezza e ingenuità con cui il protagonista inveisce contro i benpensati esplicitando didascalicamente la propria alterità, Weiss Weiss rimane purtroppo inconsistente per chi non conosce il soggetto della narrazione ed estraneo per chi, avendone già cognizione, ne avrebbe avuto abbastanza dopo un quarto d’ora.
Ombre, ma anche luci, hanno caratterizzato la seconda giornata. Tra gli eventi di assoluto livello, il secondo talk del festival, un interessante incontro tra Vittorio Agnoletto, Oliviero Ponte di Pino e Michele Losi sul tentativo di esplorare gli abissi della relazione tra teatro e contesto pandemico, e soprattutto il «cammino esperienziale e sensoriale» Alberi maestri, un percorso drammatizzato per un numero limitato di spettatori erranti e muniti di cuffie ambientali capaci di riprodurre, insieme al racconto, una «performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa» (note di regie tra caporali).
Nonostante alcuni passaggi risultino superficiali (in particolare l’affermazione secondo la quale una costruzione civile necessiterebbe di fatica mentre un albero crescerebbe quasi spontaneamente sottovaluta il portato etico e politico della cura ecologica che pure rappresenta il core del progetto) e il fatto di aver esperito un percorso senza perfomer (perché donato fuori programma a un piccolo gruppo che, partendo in giorno successivo, non avrebbe avuto modo di partecipare), il «viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso», promosso da Alberi Maestri rimane un momento potente, catartico e convincente della semplicità di un’arte in grado di recuperare la propria connessione intima e diretta con la vita di ognuno.
Trattandosi ancora di uno studio, sospendiamo il giudizio su Annotazioni per un Faust _studio per luoghi remoti di Tommaso Monza e della compagnia Natiscalzi DT, anche se la pochezza creativa e la sensazione di aver assistito a un disegno coreografico poco più che amatoriale siano state, rispettivamente, preoccupanti e imbarazzanti.
Il rapporto tra l’essere individuale e il corpo sociale presentato attraverso una successione di sketch comici e la decostruzione di una comunicazione superflua rispetto al gesto (e viceversa) caratterizza il nostro ultimo spettacolo, TRE_quanto vale un essere umano?, il working in progress diretto da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, con la collaborazione drammaturgica di Marta Dalla Via, e prodotto da Qui e Ora Residenza Teatrale e Zebra.
Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli rappresentano donne comuni, comuni come i vestiti che indossano. Lo schema è semplice, quasi spartano: le tre performer si dimenano di fronte al pubblico in una danza semplice e senza sosta; ognuna di esse, senza soluzione di continuità, risponde in maniera caustica o beffarda alle domande proiettate sul fondo del palco alle loro spalle; il pubblico partecipa euforicamente prima con grasse risate, poi lasciandosi contagiare dall’esplosione del ballo di gruppo sulle melodie di Mueve la colita nella versione di Dj El Gato.
A perplimere non è tanto la percezione di una serie di quadri giustapposti e non ancora adeguatamente legati o la snervante reiterazione di un unico meccanismo drammaturgico basato sulla ricerca della complicità del pubblico attraverso passi di danza infantili, tantomeno le pantomime forzate, le strizzatine d’occhio alla parte più commerciale della cultura pop o un testo scritto in un italiano sgrammaticato che non ha alcuna motivazione drammaturgica specifica.
Di questo allestimento che prova ad aggredire con gioiosa polemica parole (clandestino, omosessualità) e atteggiamenti mainstream (il sessismo, il body shaming), che cita statistiche più o meno a caso su vizi e virtù cui il genere femminile sarebbe costretto dal patriarcato, che estremizza il proprio sarcasmo fino a essere irritante e che individua la catarsi nell’autocompiacimento, a deludere sorprendentemente è stato l’acritico atteggiamento di superiorità di cui è figlio, ossia l’insopportabile prosopopea progressista di chi vede nell’auto-accettazione il fulcro della felicità di coloro i quali, trovandosi per vari motivi in una situazione di alterità, dovrebbero semplicemente sottomettersi senza inficiare o, quantomeno, rendere problematica la norma da cui enfatizzano la propria distanza,
Il problema non è la vetusta forma drammatica dello spettacolo, quanto i contenuti con cui la riempie e nei confronti dei quali mostra una sconcertante ricezione passiva.
Di fronte ai mortificanti cliché culturali che TRE utilizza in un regime totalmente comico e non umoristico, quindi di completa omologazione, lo spettacolo risulta incapace di innestare alcuna riflessione e di farsi carico dell’intima sofferenza della realtà che rappresenta. Guardando i suoi personaggi sembra che i mostri che quella realtà la abitano e a cui pure fa allusione (per esempio, con la sconfortante battuta sulle donne con una costola in meno per colpa di Adamo, quando non è vero neanche il contrario) si possano lasciare alle spalle semplicemente non pensandoci troppo, chiudendosi bene a chiave nel proprio ottimismo.
Un conato buonista che, sinceramente, non fa ben sperare per la versione definitiva di questa produzione.
#gallery-0-3 { margin: auto; } #gallery-0-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-0-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Ph Alvise Crovato 1
Ph Alvise Crovato (1)
Ph Alvise Crovato 5
Ph Alvise Crovato (6)
Ph Alvise Crovato (3)
Ph Alvise Crovato (5)
Ph Alvise Crovato (8)
Ph Alvise Crovato (2)
Ph Alvise Crovato (7)
Alberi Maestri
Ph Alvise Crovato 2
Ph Alvise Crovato (4)
Esperidi on the Moon – XVI Edizione
da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio 2020
Colle Brianza, Olgiate Molgora, Ello, Olginate
sabato 27 giugno, ore 16.00
Villa d’Adda Sirtori, Olginate
Campsirago Residenza presenta:
Favole al telefono
da un’idea di Anna Fascendini
regia Anna Fascendini
produzione di Campsirago Residenza
(debutto live teatro ragazzi)
ore 21.30
Villa d’Adda Sirtori, Olginate
Teatro della Contraddizione presenta:
Weiss Weiss. L’essere del non essere. Sulla sparizione di Robert Walser
di e diretto da Marco Maria Linzi
con Micaela Brignone, Fabio Brusadin, Silvia Camellini, Simone Carta, Sabrina Faroldi, Arianna Granello, Alessandro Lipari, Marco Mannone, Eugenio Mascagni, Stefano Montani, Magda Zaninetti
video artist Stefano Slocovich
costumi Margherita Platè
aiuto regia e foto Daniela Franco
suoni live Leonardo Gaipa
scene Marco Maria Linzi, Sabrina Faroldi, Fabio Brusadin, Ryan Contratista
foto bdyuri_video
(teatro)
domenica 28 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 16.00
Alberi maestri
Da Mondonico a Campsirago
composizione nello spazio Michele Losi
drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi
coreografie Silvia Girardi
costumi e scene Stefania Coretti
suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi
in scena Luca Maria Baldini, Liliana Benini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, Silvia Girardi, Arianna Losi, Michele Losi, Valentina Sordo
un progetto di Pleiadi, Campsirago Residenza
in collaborazione con The International Academy for Natural Arts (NL)
Sponsor tecnico Fratelli Ingegnoli
ore 18.00
Villa d’Adda Sirtori
Olginate
talk a cura di Oliviero Ponte di Pino, in collaborazione con Ateatro, con Vittorio Agnoletto
ore 20.30
Parco di Villa d’Adda Sirtori, Olginate
Natiscalzi DT presenta:
Annotazioni per un Faust _studio per luoghi remoti
un progetto di Tommaso Monza
coreografia e regia Tommaso Monza, Claudia Rossi Valli
danza e azioni sceniche Compagnia Natiscalzi DT
musiche originali dal vivo Giorgio Mirto
produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni, Natiscalzi DT
con il sostegno di Anghiari Dance Hub, Tendance Festival, Festival OrienteOccidente
organizzazione Vittoria Lombardi / cultureandprojects
(prima replica sperimentale, danza, site-specific)
ore 22.30
Parco di Villa d’Adda Sirtori, Olginate
Qui e Ora Residenza Teatrale presenta:
TRE_quanto vale un essere umano? Working progress
ricerca materiali Francesca Albanese, Silvia Baldini, Silvia Gribaudi, Laura Valli
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
regia Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti
collaborazione drammaturgica Marta Dalla Via
produzione Qui e Ora Residenza Teatrale e Zebra
(performance)
Per aspera ad astra / Il Giardino delle Esperidi Tra Colle Brianza, Ello, Olgiate Molgora e Olginate, la sedicesima edizione de Il Giardino delle Esperidi fa muovere i primi passi alla stagione festivaliera del Belpaese.
#Alessandro Lipari#Anna Fascendini#Arianna Granello#Campsirago Residenza#Claudia Rossi Valli#Eugenio Mascagni#Fabio Brusadin#Francesca Albanese#Laura Valli#Magda Zaninetti#Marco Mannone#Marco Maria Linzi#Marta Dalla Via#Matteo Maffesanti#Micaela Brignone#Michele Losi#Qui e Ora Residenza Teatrale#Recensione Alberi maestri#Recensione Weiss Weiss#Robert Walser#Sabrina Faroldi#Sara Molon#Silvia Baldini#Silvia Camellini#Silvia Girardi#Silvia Gribaudi#Simone Carta#Soledad Nicolazzi#Stefano Montani#Tommaso Monza
0 notes
Text
Cut-up tecnique
Quando cominciò a insegnare scrittura creativa al City College di New York, William Burroughs non era molto convinto di quello che stesse facendo. Innanzitutto, non era certo che la scrittura si potesse insegnare; il suo era stato un percorso lungo e accidentato, al termine del quale aveva capito che scrivere era anche una forma di catarsi. «Non potete scrivere a meno che non vogliate scrivere, e non potete volerlo a meno che non ve lo sentiate». Perciò: che cosa stava facendo? E poi doveva scontrarsi con l’idea che gli studenti si erano fatti di lui leggendo i suoi libri: «Erano delusi perché durante la lezione avevo giacca e cravatta; si aspettavano di vedermi comparire nudo con su un cazzo finto, credo».
William Burroughs era diverso dagli altri membri della Beat Generations, molto diverso da Jack Kerouac. Quando i due s’incontrarono per la prima volta, nel 1944, Kerouac aveva ventun anni e aveva già deciso che sarebbe diventato uno scrittore. Parlava sempre di scrittura e di libri, e spesso se ne stava seduto in un angolo con un taccuino. Scrivere era la sola cosa a cui pensava, non aveva mai voluto fare altro. Burroughs, invece, era sempre stato più inquieto. Sebbene fosse omosessuale, si sposò due volte. Dalla seconda moglie, Joan Vollmer, ebbe anche un figlio, ma la relazione finì in tragedia: in un episodio che non fu mai chiarito, una specie di rievocazione della leggenda della mela di Guglielmo Tell, dalla pistola che Burroughs aveva tra le mani partì un colpo che uccise sua moglie. Qualche tempo dopo, dichiarò: «Sono obbligato a giungere alla terrificante conclusione che senza la morte di Joan non sarei mai diventato uno scrittore».
Viaggiò moltissimo, tra l’Europa e il Sud America. Per un lungo periodo stette a Tangeri, in Marocco: era già tossicodipendente, e alternava momenti di lucidità a giorni di cupa apatia. Nel 1957, Allen Ginsberg e Jack Kerouac andarono a trovarlo e scoprirono una serie di appunti interessanti. Erano frammenti allucinati e sconnessi, storie di sesso e droga e violenza e morte oltre ogni trasgressione, visioni terrificanti condite di umorismo nero, esperienze autobiografiche che a tratti assumevano un tono documentaristico. Interrogato su quei testi, disse soltanto che scriveva le cose più orribili che riusciva a immaginare. Burroughs è inquietante e affascinante allo stesso tempo; la sua scrittura è lirica, così poetica, anche (soprattutto) quando affonda nelle scene più squallide. Quando si ha la tentazione di distogliere lo sguardo, una goccia di sangue sul braccio di un drogato «sboccia come un fiore cinese». In un attimo «un’orchidea rossa fiorì all’estremità del contagocce». Kerouac e Ginsberg aiutarono Burroughs a rendere gli appunti più organici e il risultato di quel lavoro s’intitola Pasto nudo (il titolo lo scelse Kerouac perché quel libro era la rappresentazione più precisa di “un attimo congelato, quando ognuno vede cosa c’è sulla punta della forchetta”). Resta un romanzo irregolare, non sempre efficace, a tratti così straniante da risultare inaccessibile, senz’altro unico nel suo genere.
«Tutto appartiene al ladro ispirato e devoto»Dopo il periodo vissuto a Tangeri, William Burroughs si trasferì a Parigi dove conobbe il pittore Brion Gysin. I due avviarono una relazione che condizionò anche la scrittura; Burroughs perfezionò la frammentazione che aveva sperimentato con Pasto nudo attraverso lo studio della tecnica del cut-up. Partendo dall’assunto che anche la parola è un’immagine, il metodo consiste nel tagliare delle pagine di un testo per rimetterle insieme in combinazioni a montaggio; vuol dire saccheggiare le opere degli altri, letteralmente, collegando «pezzetti vividi di dettagli che svaniscono». Succede comunque, diceva Burroughs, l’influenza tra artisti è fondamentale nel processo creativo, perché non possiamo rubare consapevolmente? Insieme a Gysin scrisse un manifesto dal titolo Les Voleurs.
Parole, colori, luci, suoni, pietra, legno, bronzo appartengono all’artista vivente. Appartengono a chiunque sappia usarli. Saccheggiate il Louvre! A bas l’originalité, lo sterile e assertivo ego che imprigiona mentre crea. En haut le vol – puro, sfrontato, totale.
Questa e molte altre riflessioni sono contenute in La scrittura creativa, una raccolta di articoli che Burroughs scrisse per la rubrica The time of the assassins che teneva sul mensile Crawdaddy, testi rielaborati e integrati per letture pubbliche, conferenze e lezioni. Secondo Burroughs, la scrittura doveva svincolarsi dalla «camicia di forza sequenziale e figurativa del romanzo» perché «la coscienza è un cut-up; la vita è un cut-up. Ogni volta che andate giù per la strada o guardate fuori dalla finestra, il fluire della vostra coscienza è tagliato da fattori a casaccio».
I primi esperimenti di cut-up di Burroughs e Gysin confluirono nel libro Minutes to go del 1959. I due estrapolavano passi dalla Bibbia, da Shakespeare, e poi li mescolavano con altri frammenti: i risultati erano imprevisti, i periodi assumevano nuovi e più ambigui significati. Gran parte del lavoro consisteva nel selezionare il materiale stilisticamente interessante per distinguerlo da ciò che restava un ammasso insensato di parole. Un’evoluzione del cut-up è il fold-in, che si sostanzia nel piegare una pagina in due e di porla accanto a un’altra per ottenere un terzo scritto. Dalla carta passarono al magnetofono: registravano le loro voci, poi acceleravano e rallentavano il nastro, tornavano indietro, tagliavano e montavano. Burroughs affermò che quando si facevano esperimenti di cut-up per lunghi periodi, alcune rielaborazioni sembravano riferirsi a eventi futuri. Una sorta di allarmismo generale si diffuse in Inghilterra nel 1971, quando Konstantine Raudive utilizzò la tecnica per il progetto Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead. Burroughs era annoiato da certe questioni («Be’, cosa si aspettavano? Un coro d’angeli con suggerimenti per le operazioni in borsa?»), non era coinvolto dalla natura delle voci, era soltanto affascinato dalle potenzialità della tecnica.
Burroughs utilizzò il metodo del cut-up in alcuni romanzi (come Strade morte o Interzona), ma sapeva che libri troppo sperimentali non trovano grande riscontro tra i lettori, così cominciò a usarlo per fini specifici: per descrivere, per esempio, stati di alterazione o dissociazione mentale di alcuni personaggi. Aveva notato proprio questo: che i risultati ottenuti applicando la tecnica alla scrittura erano molto simili ai discorsi che potevano appartenere a soggetti con disturbi psichici. Allen Ginsberg sosteneva che dietro la tecnica del cut-up c’era un’ambizione più elevata che partiva dal presupposto che le singole impressioni sensoriali fossero condizionate dal linguaggio e dalla forma di pensiero che si apprendono dalla nascita. Secondo Ginsberg, Burroughs cominciò a sospettare, in modo più o meno patologico, che queste impressioni potessero addirittura essere state programmate nel nostro corpo, in un progetto di condizionamento universale. Come scrive Lemarie, autore della sua biografia: «Il contagio virale è più di un’ossessione nell’opera di Burroughs. È il fondamento della sua mitologia».
***
Bonus track per scrittori
Uno dei compiti che Burroughs assegnava più spesso ai suoi studenti era
L’esercizio passeggiata
. Consisteva nel fare una passeggiata, appunto, con l’attenzione rivolta a un solo aspetto delle situazioni che s’incontravano. La versione originale di questo esercizio gli era stata insegnata in Ohio da un vecchio don della Mafia. L’intento è “vedere chiunque prima che lui veda te”. Se lo farete, diceva, vi renderete conto che ci sono altri attori che stanno facendo il vostro stesso gioco. Prima o poi, per quanto possiate essere bravi, qualcuno vi vedrà. Cercate di indovinare perché vi ha visto. E poi chiedetevi: a cosa stavate pensando quando siete stati scoperti?
p.s.: quando William Burroughs viveva a Tangeri, gli abitanti della zona lo chiamavano El hombre invisible.
0 notes
Photo
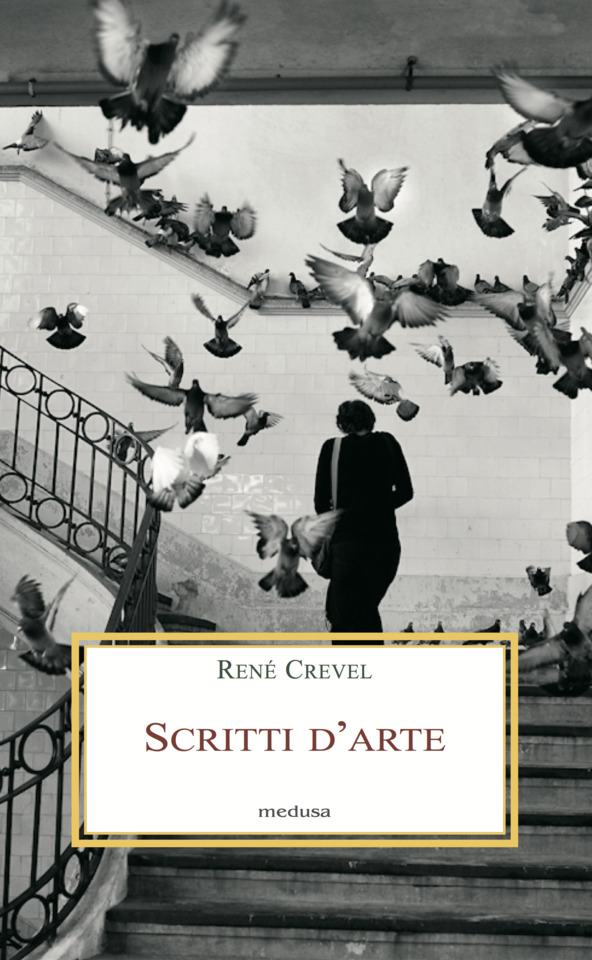

Due libri importanti dell’autore della Morte difficile, pubblicato nel 1997 da Einaudi. Raccolgono gli scritti d’arte e altri interventi di questa notevole figura del surrealismo francese. Sempre in precario bilico tra dissoluzione e catarsi espressiva queste pagine riportano l’attenzione del lettore italiano sulla personalità di uno dei più fedeli seguaci della poetica surrealista.
0 notes
Text

Human
6K notes
·
View notes