#4 settembre 1914
Photo

Torino, 11-13 marzo 1945
Gaspare Arduino
(29 aprile 1901 – 11/12 marzo 1945)
operaio, organizzatore SAP 4° settore
Vera Arduino
(15 gennaio 1926 – 12/13 marzo 1945)
operaia, appartenente ai Gruppi di Difesa della Donna
XX Brigata Garibaldi SAP
Libera Arduino
(13 settembre 1929 – 12/13 marzo 1945)
operaia, appartenente ai Gruppi di Difesa della Donna
XX Brigata Garibaldi SAP
Rosa Ghizzoni Montarolo, "Gina"
(12 maggio 1920 – 8 maggio 1946)
appartenente ai Gruppi di Difesa della Donna
XX Brigata Garibaldi SAP
Pierino Montarolo
(6 agosto 1914 – 11/13 marzo 1945)
appartenente alla XX Brigata Garibaldi SAP
Aldo De Carli
(29 maggio 1922 – 11/13 marzo 1945)
appartenente ai GAP, Brigata "Dante Di Nanni"
«Alla vigilia del funerale delle Arduino alla sera alle cinque siamo state convocate in corso Oporto, dicendo: – Raggruppate più donne possibile, domani mattina alle dieci ci sono i funerali delle sorelle Arduino. [...] E noi ci eravamo trovate ed eravamo in tante, forse la riunione più numerosa che c'è stata. C'erano moltissimi giovani e moltissime donne; c'eravamo trovate lì ed eravamo sparse per il piazzale davanti all'ingresso principale. Abbiamo aspettato molto a lungo. Tutti avevamo qualcosa di rosso, chi un fazzolettino rosso nel taschino e l'ha tirato fuori all'occasione, chi aveva la cravattina, ma tutti avevano qualcosa di rosso e tutti avevamo i fiori, perché ci avevano detto di trovarci coi fiori. La maggior parte ci eravamo procurati uno o due garofani rossi, ognuno di noi ce l'aveva.» (Giuseppina Scotti vedova Valsasna)
– in Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile, Vol. I, «Gli Struzzi» 150, Einaudi, Torino, 1977
«Il processo è stato fatto... due o tre anni dopo... C’era ancora la pena di morte. Di fatti il tenente che comandava questa gente è stato condannato alla pena di morte, si chiamava Aldo De Chiffre. Gli altri non ricordo... È stato condannato alla pena di morte, questa pena è stata tramutata in ergastolo, l’ergastolo in venticinque anni e dopo venti anni io l’ho visto fuori per un caso molto particolare.
Questo giovane, aveva ventun anni allora, studiava da dottore. All’interno del carcere ha continuato gli studi; uscito fuori si è laureato. Era dottore al Mauriziano quando l’ho conosciuto. Ero andato al Mauriziano a fare una trasfusione di sangue e... in quel momento il dottore si presenta e io ho riconosciuto il nome. E allora ho detto alla suora: – Guardi che io faccio la trasfusione di sangue, però non da questo dottore.
– Perché? – mi fa.
Ho preso il tesserino l’ho messo davanti al dottore e ho detto: — Si ricorda di questo nome?
È diventato rosso ed è andato via. Allora ho detto alla suora perché non mi lasciavo togliere il sangue da quel dottore...»
– 'Vera e Libera Arduino, trucidate dai fascisti nella notte tra il 12 e il 13 marzo 1945. Ne parla il fratello Antonio', in Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile, Vol. I, «Gli Struzzi» 150, Einaudi, Torino, 1977
#book#gaspare arduino#vera arduino#libera arduino#rosa ghizzoni#rosa ghizzoni montarolo#pierino montarolo#aldo de carli#bianca guidetti serra#giuseppina scotti#antonio arduino#gli struzzi#einaudi#1900s#1910s#1920s#1940s#1970s
11 notes
·
View notes
Text
I grandi marchi: Elsa Schiaparelli

La stilista più eccentrica del primo Novecento…
Elsa Luisa Maria Schiaparelli nacque a Roma, a Palazzo Corsini, il 10 settembre 1890 in una famiglia di intellettuali piemontesi, dove la madre, Giuseppa Maria de Dominicis, era di origini napoletane mentre il padre, Celestino fu il primo bibliotecario dell’Accademia dei Lince, una delle istituzioni scientifiche più antiche d’Europa, suo zio Giovanni fu un famoso astronomo e suo cugino Ernesto era un noto egittologo e senatore.
La giovane Elsa studiò filosofia e sognava di diventare una poetessa ma la famiglia la mandò in un convento Svizzero, poi a Londra, durante una conferenza della Società Teosofica, conobbe Wilhel de Wendt, un conte appassionato di filosofia.
Elsa sposò il conte nel 1914 e si trasferirono a New York dove nacque Maria Luisa Yvonne Radha detta “Gogo” nel 1920 e dove la giovane conobbe personalità come Marcel Duchamp e Man Ray.
Il matrimonio finì con il divorzio nel 1922, a causa dei tradimenti del marito, ed Elsa rimase da sola con Gogo.
Tornata in Europa e stabilitasi a Parigi la contessa conobbe il noto stilista Paul Poiret durante una passeggiata, e in poco tempo divenne una sua allieva.
I primi lavori di Elsa come disegnatrice di modelli non ebbero molto successo, dato che le aziende con le quali lavorava non volevano avere a che fare con una debuttante, ma decise che non si sarebbe arresa e nel 1927 aprì il suo atelier al 4 di Rue de la Paix a Parigi.
Le sue creazioni furono incredibili, come il maglione completamente nero e con un grande fiocco bianco trompe-l’oeil, oltre ai temi dei suoi capi come i cuori trafitti, i tatuaggi tipici dei marinai, i pullover ai raggi X, che ripercorrevano le ossa del corpo; il cappello matto in maglia, che poteva assumere qualsiasi tipo di forma e i suoi primi abiti da sera.
La popolarità di Elsa crebbe a dismisura tanto che il 13 agosto del 1934 il Time la mise in copertina, ed era la prima stilista donna, descrivendola come “più folle e originale della maggior parte delle sue contemporanee”.
L’arte ebbe da subito un ruolo fondamentale nell’atto creativo per la Schiaparelli e infatti, dal 1935 iniziò le collaborazioni con Christian Bérard, Léonor Fini, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Mere Oppenheim��e Pablo Picasso.
Le sue presentazioni non erano delle sfilate, ma spettacoli a tutti gli effetti con al centro il tema della maschera e del gioco.
Elsa fu anche la prima stilista a ideare collezioni a tema come Papillon del 1937, Cirque del 1938 e Pagana della Fall del 1938, ispirata ai dipinti del Botticelli.
La seconda guerra mondiale spinse la Schiaparelli a trasferirsi negli Stati Uniti, dove viveva la figlia Gogo, continuando però a mantenere aperto il suo atelier parigino, ora al numero 21 di Palace Vendôme.
Il grande successo di Christian Dior e del suo New Look e la fine della Seconda guerra mondiale segnarono le fine dell’incredibile carriera di Elsa Schiaparelli.
Nonostante Hubert de Givenchy avesse iniziato a lavorare nel suo atelier, la fama del brand si affievolì a causa della lontananza di Elsa, che aveva deciso di passare la sua vita tra ala Tunisia e Parigi sempre più lontana dalla moda.
Elsa Schiaparelli morì il 13 novembre 1973, a 83 anni, lasciando un’eredità che ha ispirato nomi come Yves Saint Laurent, John Galliano, Alexander McQueen, Miuccia Prada e Rei Kawakubo.
Read the full article
0 notes
Text
“Da bambino divoravo gli atlanti”. Fosco Maraini, dalle segrete del Tibet al mignolo mozzato
Siamo un paese di avventurieri – che trovano scrittura nell’avventatezza. Mi è capitato un libro di spudorata bellezza, Afghanistan, ultimo silenzio. Lo firma Riccardo Varvelli per De Donato nel 1966: stile schietto ma con il gusto per il dettaglio, fotografie magnetiche, il viaggio come eccidio del sé, intrusione in una saggezza pietrificata. “È l’enigma dell’alpinismo. Si soffre, si rischia la vita per un risultato di cui, appena acquisito, ci si sente incapaci di gioire”; “Se sapere di vivere è più importante che vivere bisogna ogni tanto fermarsi. Stare con il cuore seduto di fronte a un paese silenzioso per misurare se stessi in rapporto a una realtà sconosciuta. Raccogliere il nan e la luce, la fatica e la neve, il deserto e la folla, ma senza mai perdere il filo. Perché esistere vuol dire tornare”. Perché non si stampano più questi libri, che consentono alla mente – quindi, al corpo – di andare in terre incognite? La letteratura italiana nasce raccontando i viaggi di questo – Marco Polo – e altri – Dante – mondi: perché ci siamo ridotti a narrare la periferia del nostro io?
*
Un giorno dovrò filare la storia di Giovanni Battista Cerruti, “l’uomo che era diventato re dei terribili Sakai”, morto nel 1914 “in un piccolo ospedale di Penang, in Malesia, per una banale appendicite… il capitano che nell’illusione di compiere l’impresa risolutiva della propria esistenza aveva solcato mari, esplorato foreste, raccolto esemplari sconosciuti di fauna e flora per i musei, fondato imprese commerciali fallimentari, scoperto miniere”, questa specie di incrocio tra il Kurtz di Conrad e il Fitzcarraldo di Herzog, di cui l’editore Ecig, tre decenni fa, ripropose il leggendario romanzo-reportage, Tra i cacciatori di teste. Ecco: tre quarti di narrativa attuale andrebbe decapitata, in virtù di questi scoordinati, scriteriati, sgrammaticati, straordinari narratori di viaggio.
*
Torno in me. Nella stessa collana De Donato in cui è pubblico Varvelli, “All’insegna dell’orizzonte”, ci sono i libri di Ettore Biocca – Yonoama, sugli indios dell’Amazzonia – di Gianni Roghi – I selvaggi – di Folco Quilici – I mille fuochi, Sesto continente. Li ristamperei tutti, sono più utili di un documentario – gli occhi si accontentano di guardare ciò che trasmette la superficie dello schermo, le parole portano nella quarta dimensione dell’immaginare. De Donato – già Leonardo da Vinci – pubblicava i grandi libri di Fosco Maraini. Nel libro che possiedo ne promuovono quattro: G 4. Baltoro Karaorum, Ore giapponesi, Paropàmiso, Segreto Tibet. Nel ‘Meridiano’ Mondadori, Pellegrino in Asia (2007; a cura di Franco Marcoaldi), si riproducono i libri maggiori – Segreto Tibet, Ore giapponesi – e una manciata di “Scritti scelti”; La Nave di Teseo ha ripubblicato, lo scorso anno, Case, amori, universi e Gnosi delle fànfole. Qualche anno fa l’istrione Claudio Cardelli, presidente dell’Associazione Italia-Tibet, passionaccia per i Beatles, amico di Maraini, mi ha concesso l’edizione Dren-Giong, “il primo libro di Fosco Maraini” (il primissimo è la Guida dell’Abetone per lo sciatore del 1934), nell’edizione Corbaccio del 2012, con “i ricordi dei suoi amici”.
*
Fosco Maraini unisce diversi talenti: la rapacità linguistica – pari a un Gianni Brera per estro –, l’istinto narrativo, la sapienza da “etnologo poeta”. Si diceva Clituvit, “Cittadino-Luna-Visita-Istruzione-Terra”, era qualcosa tra Indiana Jones e Jack London – in realtà, deve l’amore per l’Asia a due libri particolari: Three Years in Tibet del monaco giapponese Ekai Kawagchi e With Bayonets to Lhasa dell’ufficiale inglese Sir Francis Younghusband. Era un estraneo che incontrava dei diversi, studiandoli con il rigore dello scienziato e la curiosità dello scrittore: questo lo rende, ai miei occhi, più accattivante, più spigliato di Bruce Chatwin, impegnato nella bizantina narrazione del proprio io.
*
Un paio di eventi su tutti. Il viaggio come esito del fantasticare. Il viaggio, prima di tutto, lo si custodisce, lo si prepara, lo si ama nella testa, nell’ardore metafisico dell’impossibile. “Ero un adoratore, un divoratore e naturalmente un distruttore di atlanti… Isole, penisole, continenti, laghi, bracci di mare suggerivano coi loro profili personaggi, cose, favole”, ricorda Maraini. Il mondo va divorato immaginando il seguente, incendiando mappe. Il tormento enigmatico di una carta geografica è proprio quello: alla foce di un nome si elevano fiabe, sotto una macchia marrone s’ipotizzano civiltà, lotte, eresie, si vede perfino quel piccolo volto che sporge da un castello sui giunchi.
*
Secondo episodio. Fosco Maraini è in Giappone. È nata da poco l’ultima figlia, Antonella. È da poco uscito il primo studio sugli Ainu. La Seconda guerra impedisce allo studioso il ritorno in Italia; dopo l’Otto settembre, l’arresto. “Rifiutandosi di aderire alla Repubblica di Salò, Fosco e Topazia, dopo un breve periodo di arresti domiciliari a Kyoto, vengono trasferiti insieme alle figlie nel campo di internamento Tempaku a Nagoya” (Marcoaldi). “Tolte alcune piccolezze, l’inizio parve buono”, attacca Fosco. Le cose procedettero in modo meno buono. Il 18 luglio del 1944, vista la scarsità di cibo, i prigionieri iniziano uno sciopero della fame. Il capo dei poliziotti accusa di tradimento i prigionieri. Fosco – così nel racconto della moglie, Topazia Alliata – “afferra l’accetta (della cucina), si taglia il dito mignolo della mano sinistra, lo raccatta e lo getta al terrorizzato Kasuja gridando… gli italiani non sono dei bugiardi. Tutti fuori di sé: terribile impressione”. Iosif Brodskij direbbe, “La più sicura difesa contro il Male è un individualismo estremo, l’originalità di pensiero, la bizzarria, perfino – se volete – l’eccentricità”. Cioè: sorprendere con una scelta superiore; capire il nemico, essere spietati con ciò che si ha – la presa psichica.
*
L’effetto che ti fa leggere Maraini: partire! Segui il primo sfarfallio azzurro all’orizzonte, piglialo per l’Himalaya, parti! Ogni tigre, sembra dire l’infaticabile Fosco, in fondo, giace nella gabbia delle tue costole. Segreto Tibet è il suo libro più sgargiante, forse è uno dei romanzi più belli del Novecento italiano. Qui un cammeo che ritrae Giuseppe Tucci: “Non so perché, Tucci d’un tratto s’è immusonito. Ha l’aria di cercare qualcosa che non trova. Osserva, annota, torna sui suoi passi, ma non parla più… Ormai so che in simili frangenti occorre tacere, possibilmente cancellarsi per un poco dal paesaggio. Ho per compagno un uomo dalla mente eccelsa, ma dal carattere d’infinita complessità, tutto trabocchetti e botole nascoste. Del resto lo ripete sovente lui stesso: ‘Odio gli uomini, amo invece gli animali! Mi piacciono i puniti dal karma, non i premiati! Magari i Budda fanno eccezione… Ma noi li vediamo solo in arte’. Tucci ha in sé qualcosa di notturno, di felino, di tantrico della mano sinistra. Ed è gelosissimo della propria cittadella interiore!”.
*
Uno dei libri remoti di Maraini: Gli ultimi pagani (l’ho in edizione Bur 2001). Raccoglie alcuni studi straordinari di Fosco: quello sugli Ainu, gli indigeni giapponesi, di cui racconta lo iyomande, l’uccisione rituale dell’orso; quello sui Cafiri, “gli infedeli, cioè non-cristiani e non-ebrei, in pratica i pagani, i primitivi rimasti ancora fuori dal campo dell’azione missionaria islamica”, tra i picchi di Pakistan e Afghanistan. Maraini sonda le stirpi estirpate, gli ultimi sussulti di culture travolte dal sopruso, dalle avversità della storia, dalla sfortuna; censisce le patrie perdute, gli dèi al tramonto, col cranio mozzo, l’eroismo degli inflessibili – altro che infedeli.
*
A una delle sue spedizioni himalayane, sul Saraghrar, cima dell’Hindu Kush, fino ad allora inviolata, è il 1959, Maraini dedica Paropàmiso (1963). La spedizione, coordinata dalla sezione CAI di Roma, conta anche Franco Alletto e Giancarlo Castelli Gattinara. Quest’ultimo, nel 2007, con Marietti, pubblica la sua versione dell’impresa, Viaggio in Himalaya, che nel sottotitolo (“Un agnostico, un comunista, un cattolico discutono durante un’ascensione nelle montagne dell’Hindu Kush”) tradisce lo stile: è una specie di libro ‘platonico’, dove l’ascesa coincide con la disciplina del capire. Maraini, in questo concerto di voci, è l’agnostico; e dice, tra l’altro. “È l’uomo l’eterno soggetto, il centro da cui tutto parte e il nucleo in cui tutto si risolve. L’altro termine è il Mistero, la comoedia della vita e della morte. Le religioni sono la somma dei messaggi che l’uomo legge in questo Mistero… Le religioni servono all’uomo, non viceversa. Il cristianesimo ha percorso il suo arco naturale di secoli, forse è tempo di riporlo, con tutto il rispetto per le grandi cose del passato, in un museo. Quante religioni non ha creato e lasciato lungo la sua strada, l’uomo!”. In montagna per sfracellare le idee di Dio.
*
Se nel 1937 Maraini ha il fegato e il sale di proporsi a Tucci, in preparazione per l’ennesimo viaggio verso il Tibet, “come fotografo”; se alla fine della sua vita – nel 2004 – confessa, “ho optato per la Rivelazione Perenne, cioè il regime religioso in cui Dio parla, per chi vuole ascoltarlo, non attraverso messaggi singolari concessi in punti particolari dello spazio e in momenti particolari del tempo (Rivelazione Puntuale), bensì sempre e ovunque, nella natura e nella vita umana intorno a noi”, sarà anche perché nella villa di famiglia a Poggio Imperiale passeggiavano Bernard Berenson e D.H. Lawrence, H.G. Wells e Aldous Huxley (quello della Filosofia Perenne), Ardengo Soffici e Norman Douglas. Certo, Fosco era piccino e scatenato, me certe cose restano, tra le ciglia e sotto le unghie. Tutto, d’altronde, è letteratura, parola che fonda sedie e tavoli. (d.b.)
*In copertina: una fotografia “giapponese” di Fosco Maraini
L'articolo “Da bambino divoravo gli atlanti”. Fosco Maraini, dalle segrete del Tibet al mignolo mozzato proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2XJoyml
11 notes
·
View notes
Text
accadde...oggi: nel 1914 nasce Lina Volonghi, di Federica Marengo
accadde…oggi: nel 1914 nasce Lina Volonghi, di Federica Marengo
Inverno 1933. Quarto, quartiere di Genova affacciato sul marLigure . Mentre in città fervono i preparativi per il Carnevale e nelle strade , profumate dagli effluvi salmastri , artigiani nerboruti allestiscono come da tradizione il carro con a bordo un enorme spaventapasseri , rappresentante il gramo inverno , nel modesto rustico abitato dalla famiglia Volonghi , la ventenne Lina , ultima di sei…
View On WordPress
0 notes
Text
Le prime disposizioni authoritative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica regularizing
contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate") e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l'art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in by means of provvisoria il requisito una specifica competenza professionale, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica della figura

] in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art.
222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività demonstrate nell'art. 327 bis del medesimo codice".
Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in information 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti.
Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.
La figura dell'investigatore privato investigatore privato a roma è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.
Il regolamento del 1940 demanda inoltre promotion apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del Ministero dell'Interno, l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.
Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:
«Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.
In ottemperanza alle disposizioni del TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di cui sopra.
Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
• investigatore privato titolare d'istituto;
• informatore commerciale titolare d'istituto;
• investigatore autorizzato dipendente;
• informatore autorizzato dipendente.
• Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
• la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);
• la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.
Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell'interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti I bilanci, I debitori protestati, I riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni agent.
0 notes
Text
MILLE MILIARDI DI VOLTE
New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/mille-miliardi-di-volte/
MILLE MILIARDI DI VOLTE
L’iperinflazione nella Germania di Weimar
Tra il 1914 ed il 1923 i prezzi in Germania aumentarono nella misura di oltre mille miliardi di volte. Nel dopoguerra molti paesi conobbero il flagello dell’inflazione: in Austria i prezzi aumentarono di 14 mila volte, in Ungheria di 23 mila volte, in Polonia di 2,5 milioni di volte, nella Russia bolscevia di 4 miliardi di volte. Solo in Germania però l’inflazione fu così vorticosa da privare il denaro di ogni valore e di ogni significato, facendo regredire al baratto quella che prima della guerra era stata l’economia più sviluppata d’Europa.
Un intero popolo sprofondò nella più cupa disperazione. Soprattutto per impiegati, operai e pensionati, i cui redditi furono adeguati lentamente e parzialmente all’aumento dei prezzi, la vita quotidiana si trasformò in una angosciante lotta per la sopravvivenza. I risparmi di una vita svanirono, divorati dalla crescita inarrestabile e repentina del prezzo dei beni di prima necessità. Per conservare un qualche poter d’acquisto i salari dovevano essere spesi interamente nello stesso istante in cui venivano percepiti, anche un solo giorno di esitazione era suficiente a condannare una famiglia all’indigenza. Era imperativo trasformare il più rapidamente possibile le sporte di carta moneta ricevute in pagamento in beni da consumare o da barattare.
Il giornalista Raimund Pretzel, noto al pubblico, soprattutto inglese e tedesco, con lo pesudonimo di Sebastian Haffner, rievocando la sua adolescenza durante la grande inflazione racconta che suo padre, un funzionario pubblico di grado elevato, dopo aver incassato lo stipendio si precipitava a comprare l’abbonamento ferroviario per potersi recare al lavoro il mese successivo, saldava le spese correnti, portava l’intera famiglia a tagliarsi i capelli e quindi consegnava ciò che restava alla moglie. La moglie, a sua volta, si recava al più vicino mercato ed acquistava scorte di generi alimentari non deperibili che sarebbero dovuti durare fino allo stipendio successivo. Per il resto del mese la famiglia non disponeva di contanti.
Il filologo Victor Klemperer riferisce nel suo diario che anche i più piccoli piaceri quotidiani potevano diventare da un giorno all’altro un lusso inaccessibile anche per chi come lui aveva un buon impiego presso il Politecnico di Dresda ed una pensione di guerra: per consumare al bar un caffè ed un dolce occorrevano 12 mila Marchi il 24 luglio 1923 e 104 mila il 3 agosto. Un biglietto del cinema poteva schizzare nell’arco di qualche giorno da 10 mila a 200 mila Marchi. Nelle vetrine dei negozi i cartellini dei prezzi venivano aggiornati di ora in ora. Per avere la certezza che la posta giungesse regolarmente al destinatario era necessario spillare sulle buste delle banconote di taglio elevato come affrancatura, dal momento che i francobolli stentavano a tenere il passo con l’aumento dei prezzi.
Nel periodo di picco dell’iperinflazione oltre il 90% della spesa domestica era destinata al cibo. A fluttuare più impetuosamente erano infatti i prezzi dei generi alimentari. Nel 1923, l’anno più nero della crisi, un chilo di pane di segale costava 163 Marchi il 3 gennaio, 10 volte tanto in luglio, 9 milioni di Marchi il 1° ottobre, 78 miliardi il 5 novembre e 233 miliardi di Marchi due settimane più tardi.
La domenica i cittadini a reddito fisso di ogni condizione sociale si riversavano nelle campagne nella speranza, spesso vana, di poter scambiare il denaro senza valore stipato nei loro zaini con dei viveri. Nelle città, i negozianti per anticipare i futuri aumenti dei prezzi spesso non esitavano ad accaparrare le merci, generando una penuria degli alimenti di più largo consumo. Non mancarono episodi di assalti e di saccheggi degli empori a cui le autorità risposero con l’impiego dell’esercito. Nelle campagne si formarono bande armate che razziavano le fattorie. Sulle banchine del porto di Amburgo i portuali più che scaricare le navi le depredavano, soprattutto se contenevano merci introvabili come farina, zucchero, pancetta o caffè. I dati sulla criminalità registrarono un incremento impressionante: le condanne per furto che ammontavano a 115 mila nel 1913 divennero 365 mila nel 1923.
L’ amoralità dell’ intrallazzo penetrò ampiamente anche in quei ceti sociali che nel periodo guglielmino erano stati orgogliosi custodi dei principi di onore ed onestà. Spesso per chi non cedeva alla tentazione del furto e dell’intrallazzo, oppure non era nelle condizioni di intrallazzare o di rubare qualcosa che potesse essere scambiato, non vi erano alternative alla fame. La malnutrizione dilagante provocò una impennata dei casi di morte per tubercolosi.
Il crollo del Marco sui mercati internazionali rese impossibile l’importazione di alimenti con cui scongiurare la carestia determinata dall’accaparramento messo in atto dai produttori e dai commercianti all’ingrosso. Nel 1914 erano sufficienti poco più di 4 Marchi per acquistare un Dollaro, nel gennaio 1923 ne occorrevano 17 mila, in aprile 24 mila, in luglio 353 mila. Nei mesi seguenti per esprimere il tasso di cambio tra Marco e Dollaro si dovette fare ricorso a numeri a 7 cifre in agosto, a 8 in settembre, ad 11 in ottobre, a 13 in novembre ed in dicembre.
Alla rovina di intere classi sociali corrispose il repentino e smodato arricchimento dei grandi proprietari terrieri, degli industriali, e di riflesso degli speculatori di borsa, degli esportatori che potevano vendere sui mercati esteri prodotti di altissima qualità a prezzi resi imbattibili dall’inflazione, ricevendo in pagamento valuta pregiata. Dall’inflazione trassero enorme vantaggio tutti i debitori, poiché titoli, obbligazioni ed ipoteche andarono in fumo. Le somme che la Reichsbank aveva prestato ad industriali ed agrari per ammodernare e potenziare le loro imprese al momento della restituzione avevano ormai perso gran parte del loro valore. Il tasso di rivalutazione del credito, fissato tardivamente nel 1924 dal governo al 15%, non fu certo sufficiente a cancellare gli effetti dell’iperinflazione. Pertanto le aziende più indebitate si trovarono improvvisamente non solo sollevate dai loro debiti, ma addirittura nelle condizioni di espandersi ed assorbire le piccole imprese che non avevano scommesso sul perdurare dell’inflazione ed avevano esitato a fare una coraggiosa politica di investimenti, sfruttando il credito che la Reichsbank, presieduta da Rudolf Havenstein, concedeva con una certa larghezza. Giganteschi gruppi industriali si consolidarono diversificando i loro interessi in molteplici settori. Uno dei capitani d’industria più spregiudicati di questo periodo fu Hugo Stinnes che dal settore carbonifero e metallurgico estese i suoi interessi alla navigazione, all’organizzazione alberghiera ed alla stampa.
La spirale inflazionisitica che investì la Germania fu generata dalla scelta della classe dirigente guglielmina di finanziare la guerra senza ricorrere né ad imposte straordianarie né ad inasprimenti della tassazione sui ceti più abbienti, ma aumentando invece il debito pubblico attraverso prestiti di guerra ed immettendo in circolazione un volume eccessivo di valuta.
Le spese mensili di guerra si aggiravano intorno ad 1 miliardo di Marchi nel 1914, a 2 nel 1915, si impennarono bruscamente nell’ottobre del 1916 a 3 Miliardi, poi continuarono a crescere, attestandosi a 4 miliardi nel 1917 e sfiorando i 5 miliardi nell’ottobre del 1918. Alla fine di maggio del 1916 la guerra, che lo Stato Maggiore si era illuso di poter concludere nell’arco di poche settimane, aveva inghiottito poco meno di 40 miliardi, di cui 36 erano stati coperti da quattro fortunate missioni di prestiti statali. Le cinque emissioni successive rimasero però molto al di sotto delle crescenti spese belliche, costringendo il governo a stampare moneta per far fronte alle sue necessità, generando di conseguenza inflazione. La penuria di beni di consumo e l’allentamento di qualsiasi freno sui prezzi delle merci destinate all’armamento portarono ad aumenti continui dei prezzi, alimentati a loro volta dalla crescente massa monetaria in circolazione.
Alla fine del conflitto le spese di guerra ammontarono a 160 miliardi di cui solo 97 erano stati coperti dai prestiti. Il potere d’acquisto del Marco risultò dimezzato rispetto al 1914.
La politica di inasprimento fiscale fu scartata dai cancellieri del Kaiser perché avrebbe imposto una revisione costituzionale dei rapporti tra il governo federale e gli stati. Le finanze del Reich poggiavano principalmente sulle entrate derivanti dai dazi doganali e dalle imposte indirette, mentre tutte le altre fonti rimanevano agli stati, che si opponevano tenacemente all’introduzione di un sistema fiscale federale diretto. Da un lato il veto dei socialdemocratici a nuove imposte sui consumi, dall’altro l’ostilità della destra e dei grandi interessi industriali a pesanti imposte sui profitti di guerra non lasciarono alternative rispetto all’emissione di moneta. Tanto più che a rassicurare il governo e l’opinione pubblica sul futuro delle finanze del Reich interveniva l’incrollabile fede nella vittoria finale che avrebbe consentito, attraverso le riparazioni di guerra imposte ai vinti, di superare qualsiasi difficoltà finanziaria.
La sconfitta aprì scenari finanziari che non erano stati previsti, e perciò furono affrontati senza alcuna lungimiranza.
Crollata la rassicurante illusione di poter scaricare sui vinti l’onere del costo della guerra, i governi repubblicani reagirono nel segno della continuità con il periodo monarchico. Non osarono cioè intraprendere una politica di austerità, risparmio e contrazione della quantità di moneta, anzi fronteggiarono gli enormi problemi del dopoguerra, che andavano dall’erogazione delle pensioni di guerra alla riconversione industriale per creare occupazione ai soldati smobilitati, ricorrendo al torchio ed incoraggiando una espansione del credito da parte della Reichsbank. Non potendo contare né su di un gettito fiscale adeguato alle difficoltà del momento, né sulla disponibilità di una opnione pubblica prostrata dalla sconfitta ad accettare ulteriori sacrifici, alimentarono l’inflazione, che nel 1919 ridusse ad un quarto il valore del Marco rispetto alla vigilia della guerra.
Nell’immediato tale politica inflazionistica produsse risultati positivi in tutti i settori economici interessati dalla smobilitazione e dalle sovvenzioni pubbliche. Mentre i vincitori precipitavano nella crisi generata dalla riconversione industriale post bellica, i vinti tedeschi raggiunsero rapidamente, sull’onda dell’inflazione, la piena occupazione e diedero un potente slancio alla loro economia. Sui mercati internazionali la caduta del Marco ebbe una accelerazione nel secondo semestre del 1919, nel febbraio del 1920 occorrevano 100 Marchi per acquistare un Dollaro, con consistenti benefici per le esportazioni tedesche.
La rapida ripresa dell’economia tedesca fece la fortuna degli imprenditori, che già si erano arricchiti durante il periodo bellico, senza tuttavia innalzare il tenore di vita della maggioranza della popolazione. Almeno sino al 1922 gli effetti negativi dell’inflazione su alcune fasce sociali furono stemperati dalla piena occupazione e dalle prestazioni assistenziali pubbliche. Invece i sottoscrittori dei debiti di guerra e tutti coloro che percepivano rendite finanziarie subirono di fatto una espropriazione, le cui proporzioni si accrebbero al ritmo dell’inflazione.
Difronte al generale inasprimento delle condizioni di vita larghissima parte dell’opinione pubblica, con il convinto sostegno della stampa e della classe politica, reagì attribuendo le cause dell’inflazione alle condizioni di pace imposte dal Trattato di Versailles e soprattutto alle riparazioni di guerra. La continuità tra la politica economico-finanziaria guglielmina e quella repubblicana svanì agli occhi di milioni di tedeschi per i quali la perdita del potere d’acquisto del Marco non era che una conseguenza della volontà dei vincitori di umiliare ed annientare quel popolo che non erano stati capaci di piegare sui campi di battaglia. Tale convinzione si impose non appena crollò l’ingenua illusione che fosse sufficiente l’abdicazione del Kaiser per garantire alla Germania democratica e repubblicana una pace mite, improntata ai principi wilsoniani.
Emblematico dell’indignazione tedesca difronte al diktat dei vincitori fu l’atteggiamento del Ministro degli Esteri Von Brockdorff-Rantzau alla conferenza di Versailles.
In origine il Presidente Wilson aveva pensato che i governi dell’Intesa dovessero redigere una bozza del trattato che fornisse una base per i negoziati con la Germania, poi i contrasti tra i vincitori, che portarono la delegazione italiana ad abbandoanre i lavori, consigliarono di considerare pressocché definitiva la formula comune faticosamente elaborata dopo cinque mesi di battaglie diplomatiche e di sottoporla ai tedeschi affinché ne prendessero atto e la sottoscrivessero. La riduzione dei margini di trattativa della Germania alla facoltà di presentare entro un termine molto ristretto delle controproposte alle clausole del trattato fu interpretata dall’opinione pubblica tedesca come una beffa umiliante. Il 7 maggio 1919 la delegazione tedesca guidata dal conte Von Brockdorff-Rantzau, un aristocratico proveniente dalla carriera diplomatica tardivamente convertitosi al regime democratico repubblicano, fu convocata a Versailles per partecipare alla presentazione del trattato. Ufficialmente nessuna indiscrezione sul contenuto delle clausole fu fatta trapelare, tuttavia i giornali francesi ed americani avevano fornito elementi sufficienti a prefigurare un quadro piuttosto fosco per la Germania. La stessa scelta come luogo della cerimonia del salone degli specchi della reggia di Versailles, dove il 18 gennaio 1871 era stata proclamata l’unificazione tedesca, suonò come una malvagia provocazione ai delegati di Berlino.
I lavori furono inaugurati da un breve discorso di Clemenceau sulle speranze di edificare una pace duratura. Mentre lo statista francese pronunciava i suoi auspici il grosso fascicolo contenente il progetto del trattato fu consegnato al Ministro degli Esteri tedesco che lo mise bruscamente da parte senza neppure sfogliarlo. Non appena gli fu data la parola Von Brockdorff-Rantzau rimase provocatoriamente seduto, leggendo un discorso dai toni duri e sprezzanti in cui Wilson, Lloyd George e Clemenceau credettero di riconoscere un rigurgito della tracotanza della Germania guglielmina. Rifiutò nettamente la tesi che la responsabilità della guerra fosse da attribuire esclusivamente alla Germania, rimproverò gli Alleati di aver atteso sei settimane prima di concedere l’armisitzio e sei mesi prima di elaborare unilateralmente le condizioni di pace, li accusò di aver ucciso con fredda premeditazione centinaia di migliaia di civili tedeschi con la prosecuzione del blocco navale dopo il novembre 1918. Il contegno provocatorio di Von Brockdorff-Rantzau, forse dettato da un consapevole disegno politico, forse da un puerile tentativo di mascherare la sua profonda agitazione nervosa e l’impossibilità di contestare le clausole con argomenti puntuali a precisi, fu comunque salutato con grande entusiasmo dall’opinione pubblica tedesca che lo interpretò come una estrema e coraggiosa difesa dell’orgoglio nazionale ferito. Ben magra consolazione che non contribuì per nulla a mitigare le severe condizioni di pace.
Le controproposte presentate dal governo tedesco entro il termine concesso di tre settimane furono accolte solo in minima parte, lasciando sostanzialmente immutato l’impianto elaborato dagli Alleati, che imponeva pesanti mutilazioni territoriali, pari a circa il 13% della superficie del Reich in Europa, oltre alla totalità dei possedimenti coloniali.
L’Alsazia e la Lorena, annesse da Bismarck nel 1871, ritornarono sotto la sovranità francese, la Saar venne affidata per quindici anni all’amministrazione della Società delle Nazioni, il gracile organismo sovranazionale ostinatamente voluto da Wison per garantire la pace mondiale. Un plebiscito avrebbe poi sancito il ritorno della Saar alla Germania oppure la sua annessione alla Francia. Temporaneamente i ricchi giacimenti carboniferi della regione furono assegnati alla Francia come risarcimento per le devastazioni subite dalle sue miniere nelle zone limitrofe al Belgio. Anche il destino dello Schleswig, conteso tra Berlino e Copenhagen, fu affidato ad un plebiscito. La riva sinistra del Reno fu destinata per un periodo di quindici anni a subire un regime di occupazione da parte delle truppe alleate. Entrambe le sponde del Reno furono inoltre dichiarate definitivamente smilitarizzate. Strettamente collegate all’occupazione della Renania furono le decisioni assunte dagli Alleati riguardo al disarmo tedesco. Fu abolito il servizio militare obbligatorio, l’esercito tedesco, su base volontaria, non avrebbe potuto superare le centomila unità, ufficiali inclusi. Il suo armamento non avrebbe potuto comprendere né velivoli, né carriarmati, né altri mezzi pesanti. Non senza ingenuità, ma con l’evidente scopo di menomare le capacità strategiche del corpo ufficiali, fu imposto lo scioglimento dello Stato Maggiore. La marina da guerra fu autorizzata a mantenere un organico di appena quindicimila uomini al servizio di una flotta composta da sei navi da battaglia ed alcune unità minori. I sommergibili, che erano stati una delle armi più temibili del Kaiser, furono interdetti. Le corazzate e gli incrociatori internati a Scapa Flow all’indomani dell’armistizio avrebbero dovuto essere ripartiti tra le potenze vincitrici.
La Germania dovette inoltre sopportare pesanti amputazioni ai suoi confini orientali. Alla Polonia furono annesse la maggior parte della Posnania, della Prussia occidentale nonché una provincia della Prussia orientale, il distretto di Hultschin fu invece assegnato alla Cecoslavacchia. La concessione più significativa degli Alleati alle controproposte tedesche riguardò l’Alta Slesia, nella prima stesura del trattato essa avrebbe dovuto essere annessa alla Polonia, nella stesura definitiva fu stabilito invece di affidare il destino della regione ad un plebiscito. Per concedere alla Polonia uno sbocco sul Baltico la città di Danzica, tedesca per lingua, cultura ed etnia, fu proclamata città libera sotto l’autorità della Società delle Nazioni, garantendo però a Varsavia importanti privilegi politici e commerciali. Anche il neonato stato lituano ottenne uno sbocco al mare a spese della Germania con l’annessione del distretto di Memel.
Il desiderio espresso dalla Germania di stabilire già nel testo del trattato l’ammontare delle riparazioni di guerra non fu esaudito. I contrasti tra gli Alleati e le difficoltà tecniche di determinare le capacità di pagamento tedesche consigliarono l’istituzione di una apposita commissione, composta esclusivamente da rappresentanti delle potenze vincitrici, incaricata di stabilire entro il 1° maggio 1921 il preciso importo delle riparazioni. In attesa della conclusione dei lavori della commissione avrebbero dovuto comunque continuare i pagamenti e le consegne di materiali in conto riparazioni. Tale frettolosa soluzione di compromesso impose alla Germania di firmare una cambiale in bianco. John Maynard Keynes fu tra i primi a denunciare, nell’opera Economic consequences of the Peace, pubblicata nel 1919, come le questioni economico-finanziarie irrisolte avrebbero potuto tradursi in una grave minaccia per la stabilità politica dell’Europa, ma il suo monito rimase inascoltato.
A suscitare l’indignazione tedesca non fu soltanto l’indeterminatezza del peso economico della sconfitta, ma anche l’affermazione, contenuta nell’articolo 231 del trattato, secondo cui le riparazioni erano dovute poiché gravava sulla Germania la responsabilità esclusiva della guerra. I vincitori non si accontentarono di un fondamento realpolitico per condannare la Germania alle riparazioni, ma per scrupolo giuridico vollero estendere al diritto internazionale un principio fondamentale del diritto civile in base al quale è obbligato a pagare il danno colui che lo abbia provocato dolosamente o colposamente. Pertanto la Germania fu obbligata a pagare non perché sconfitta, ma perché responsabile di una guerra di aggressione. L’articolo 231 fu interpretato a Berlino come un goffo tentativo di estorcere alla Germania una confessione di colpevolezza che assolvesse tutte le altre potenze europee.
A rafforzare sul piano guiridico e politico il principio dell’affermazione della responsabilità tedesca contribuì anche la richiesta alleata di estradizione degli accusati di crimini di guerra ed il progettato processo contro Guglielmo II. Per un popolo che aveva interpretato la mobilitazione del 1914 come una misura difensiva rispetto alla minaccia russa e non era certo disposto a considerare né il Kaiser né i suoi ufficiali alla stregua di criminali le argomentazioni giuridiche dei vincitori risultarono pretestuose ed offensive.
Gli alleati concessero alla Germania appena una settimana per sottoscrivere il testo definitivo del trattato. Se entro tale termine non fosse giunta una risposta affermativa, sarebbe cessato anche l’armisitizio e quindi le truppe dell’Intesa sarebbero state mobilitate. Il Maresciallo Foch aveva già predisposto i piani per questa eventualità.
Il Ministro degli Esteri Von Brockdorff-Rantzau, considerata la scarsa attenzione riservata alle controproposte presentate, chiese che il trattato fosse respinto. Anche il cancelliere Scheidemann, che già si era espresso contro la bozza del trattato, confermò il suo rifiuto al diktat di Versailles. Al contrario, altri esponenti di spicco del partito socialdemocratico come il Ministro della Difesa Noske ritenevano che il trattato, per quanto detestabile, dovesse essere firmato, dal momento che la Germania non aveva alcuna possibilità di resistere militarmente ed una nuova sconfitta avrebbe generato una pace peggiore di quella che gli Alleati ora erano disposti ad offrire. Il leader del partito di centro Erzberger, capo della delegazione armistiziale, mise in evidenza che in caso di rifiuto del trattato sarebbe stata a esposta a grave rischio la stessa unità della Germania e la sua capacità di arginare il bolscevismo. Il partito democratico, che tante speranze aveva riposto nei principi wilsoniani, si dichiarò invece in maggioranza recisamente contrario al trattato, in piena sintonia con l’opposizione nazionalista e conservatrice che rappresentava gli interessi della vecchia classe dirigente che aveva voluto la guerra ed ora rifiutava sdegnosamente la pace.
Dopo aver constatato l’impossibilità del suo governo di esprimere una posizione unitaria Scheidemann si dimise. La sua difficile eredità fu raccolta dal Ministro del Lavoro Gustav Bauer, che con il sostegno dell’estrema sinistra, del centro cattolico, di un piccolo gruppo di dissidenti democratici e della maggioranza del partito socialdemocratico riuscì a formare un nuovo esecutivo disposto ad accettare, seppur con alcune riserve, le condizioni di pace.
Bauer ottenne i suoi consensi attorno all’ipotesi di richiedere agli Alleati di eliminare dal testo del trattato l’articolo 231 e di rinunciare al processo sia a Guglielmo II, sia ai criminali di guerra. Il 21 giugno, proprio mentre il nuovo governo tentava di riaprire le trattative, giunse da Scapa Flow la notizia che la flotta tedesca al comando dell’Ammiraglio Von Reuter si era autoaffondata. Gli Alleati reaggirono imponendo alla Germania una accettazione immediata e senza condizioni del trattato di Versailles.
Posta difronte all’eventualità di una ripresa del conflitto, l’Assemblea nazionale, circa un’ora prima della scadenza dell’ultimatum, autorizzò, con 237 voti favorevoli contro 138, il governo a firmare la pace. Larga parte dell’opinione pubblica non apprezzò affatto il senso di responsabilità dei parlamentari, preferì inveire contro la vigliaccheria della classe dirigente repubblicana e contro la ferocia dei vincitori.
La pace offrì alle formazioni politiche di estrema destra nuovi e seducenti argomenti per radicalizzare le proprie posizioni e fomentare le ricorrenti tentazioni golpiste che caratterizzarono tutta la storia della repubblica di Weimar. In particolare la questione delle riparazioni rimasta irrisolta favorì la mobilitazione permanente della propaganda nazionalista, ostacolando la riconciliazione della Germania con le altre potenze.
Nel marzo del 1920, a seguito del rifiuto del Senato di ratificare il trattato di Versailles e quindi di sostenere tutta l’ambiziosa politica estera del Presidente Wilson, venne meno anche la preziosa mediazione degli Stati Uniti che soprattutto sul terreno economico-finanziario avrebbe potuto fornire un contributo determinante per la soluzione dei nodi irrisolti. Senza la delegazione americana la Commissione riparazione stentò infatti ad esprimere un approccio pragmatico e realistico nell’elaborazione del sistema di pagamenti a cui la Germania avrebbe dovuto sottostare. Per lungo tempo sembrò trionfare tra le potenze vincitrici europee la volontà di rivalsa sullo spirito di riconciliazione, esasperando entità, tempi e modi delle pur legittime richieste di risarcimento.
Il postulato da cui presero le mosse i funzionari francesi e britannici fu che la Germania dovesse rispondere non solo dei danni di guerra da essa direttamente causati, seguendo la consuetudine sancita dal diritto internazionale, ma di tutti i costi della guerra stessa. Ai sensi dell’allegato I all’articolo 232 del trattato, tra i danni di cui la Germania era considerata responsabile rientravano ad esempio tutte le pensioni ed analoghe indennità alle vittime militari della guerra ed alle persone che da queste vittime erano mantenute. Ne derivarono cifre esorbitanti che misero a dura prova gli strumenti economico-finanziari sino ad allora sperimentati. Nessuno negli anni ’20 aveva ancora una esperienza di transazioni finanziarie di importi così elevati distribuiti su di un arco temporale molto lungo.
Il punto centrale su cui si confrontarono gli esperti della Commissione riparazioni fu la determinazione della somma che la Germania sarebbe stata in grado di pagare. L’incognita con cui dovettero fare i conti riguardava la capacità di tenuta e di sviluppo dell’economia tedesca nell’arco di una generazione. La cifra di 100 miliardi di Marchi oro, da pagare in rate annuali infruttifere, proposta dai tecnici del governo tedesco, tra l’incredulità e lo sdegno dell’opposizione nazionalista ai Reichstag, fu giudicata del tutto inaccettabile dagli Alleati, che ambivano ad ottenere ben di più, senza tuttavia riuscire a definire un importo.
Preso atto che 100 miliardi di Marchi oro non erano sufficienti, la Germania si trovò in un vicolo cieco. Non poteva giocare al ribasso, ma non poteva nemmeno sfidare la vivace opposizione nazionalista e le grandi incertezze della congiuntura economica offrendosi di pagare cifre iperboliche, pur di chiarire una volta per tutte i suoi obblighi verso i vincitori. Non le restava che attendere e sperare.
Sul finire del 1920, dopo che alla conferenza di Spa i diktat sulle procedure di attuazione del disarmo e delle consegne di carbone si erano scontrati con l’orgoglio tedesco, si fece strada tra gli Alleati l’ipotesi che fosse più opportuno definire un piano provvisorio di pagamenti per i successivi cinque anni, in modo da avviare una soluzione della questione delle riparazioni, disponendo però di un tempo sufficientemente lungo per placare le tensioni politiche ed ottenere elementi economici più obiettivi ed affidabili su cui determinare l’ammontare complessivo del debito tedesco. Uno dei più convinti sostenitori di un approccio gradualistico fu il francese Seydoux, direttore del dipartimento del commercio del Ministero degli Esteri, che nel gennaio 1921 fece giungere a Berlino in via ufficiosa la proposta di fissare, per un quinquennio, in 3 miliardi di Marchi oro l’ammontare annuale delle riparazioni.
I circoli industriali tedeschi, influenzati dagli interessi di Stinnes, accolsero negativamente tale soluzione ritenendo che lasciando indefinito l’ammontare complessivo delle riparazioni la Germania avrebbe finito per pagare una somma ben più elevata non appena la sua economia e la sua valuta avessero ripreso vigore. Occorreva a loro avviso trarre il massimo vantaggio dall’inflazione che, oltre ad alleggerire sia il debito pubblico sia il debito dei grandi gruppi industriali, agiva come un velo rendendo difficoltoso agli esperti alleati valutare le reali condizioni dell’economia.
Sotto la pressione del parere negativo espresso dall’industria il fragile governo Fehrenbach esitò ad aderire al piano Seydoux. Solo le insistenze inglesi e francesi lo convinsero ad aprire le trattive subordinando però l’accettazione di una soluzione provvisoria del problema delle riparazioni alla permanenza dell’Alta Slesia, in cui era prevista ai sensi del trattato la celebrazione di un referendum per il marzo 1921, alla Germania. Il goffo tentativo di condizionare il destino dell’Alta Slesia irritò la Francia che era in procinto di concludere una alleanza con la Polonia, determinando l’accantonamento del piano Seydoux.
Alla conferenza alleata di Parigi del gennaio 1921 tornò ad imporsi l’idea di fissare in via definitiva l’ammontare complessivo delle riparazioni. Lloyd George finì per cedere agli intenti punitivi di Briand accettando l’ipotesi di imporre a Berlino il pagamento di 269 miliardi di Marchi oro in quarantadue anni. Il governo tedesco seppur sdegnato non poté esimersi dall’aprire le trattative.
Il Ministro degli Esteri Walter Simons, stretto tra l’opinione pubblica, tanto ostile al riconoscimento della responsabilità della guerra quanto alle riparazioni, e le richieste iperboliche formulate dagli Alleati, tentò una impossibile mediazione dichiarando nel marzo del 1921 che la Germania non era disposta a pagare più di 30 miliardi di Marchi oro in rate assai distanziate. Anche ammettendo che gli esperti di Simons avessero tentato di determinare il valore attuale del debito ignorando gli interessi che sarebbero maturati nell’arco dei decenni, la cifra di 30 miliardi era decisamente inferiore non solo alle aspettative alleate, ma perfino a quanto la Germania si era offerta di pagare nel 1919. Rispetto poi al pagamento, entro il 1° maggio 1921, dell’acconto di 20 miliardi fissato dall’articolo 235 del trattato di Versailles, gli stessi esperti elaborarono un calcolo capzioso teso a dimostrare che la Germania aveva già versato una cifra addirittura superiore con le prestazioni reali fornite fino a quel momento agli Alleati. Ebbero addirittura la sfacciataggine di conteggiare tra le riparazioni già saldate anche il valore della flotta che si era autoaffondata a Scapa Flow.
Gli Alleati non stentarono pertanto a trovare ulteriori argomenti per sostenere che la Germania stava adducendo pretesti per sottrarsi ai suoi impegni, come già dimostravano l’insabbiamento dei procedimenti a carico dei criminali di guerra e la mancata attuazione delle procedure di disarmo previste dal protocollo di Spa. Anche il premier inglese Lloyd George, che fino ad allora aveva più volte rimproverato al governo francese la sua eccessiva intransigenza verso la nuova Germania, si convinse che solo la minaccia militare avrebbe potuto evitare che il trattato di Versailles rimanesse lettera morta. Il 3 marzo annunciò a nome degli Alleati che se la Germania entro quattro giorni non avesse accettato le decisioni della conferenza di Parigi oppure non avesse presentato opportune controproposte le città renane di Dusseldorf, Duisburg e Ruhrort sarebbero state occupate.
Il governo Fehrenbach tergiversò, lasciò scadere il termine dell’ultimatum e ne subì le conseguenze.
Simons, salutato al suo ritorno in patria come un eroe nazionale, tentò di riaprire le trattative, facendo appello, senza successo, alla mediazione degli Stati Uniti. Nel frattempo a Londra, il 27 aprile, la Commissione riparazioni all’unanimità ridimensionava a 132 miliardi di Marchi oro l’ammontare complessivo del debito tedesco, allienandosi alla cifra che Keynes aveva indicato prima di dimettersi dalla delegazione britannica alla conferenza di Versailles. Pur dimezzata la richiesta dei vincitori rimaneva comunque imponente ed il governo Fehrenbach, che si reggeva sulla benevola neutralità del partito socialdemocratico senza una solida maggioranza parlamentare, fu costretto a dimettersi.
Gli Alleati ignorarono la cirisi di governo e perseverarono nella politica dei diktat: se entro il 12 maggio la Germania non si fosse impegnata ad attuare il disarmo, ad avviare i procedimenti contro i criminali di guerra e ad accettare il piano di pagamento delle riparazioni il territorio della Ruhr sarebbe stato occupato.
Le conseguenze catastrofiche per l’economia tedesca di una occupazione prolungata di una regione industriale come la Ruhr spinsero la classe politica ad un comportamento responsabile. Il 10 maggio 1921 l’ex Ministro delle Finanze Joseph Wirth formò un nuovo governo, sostenuto dal centro, dai democratici e dai socialdemocratici, che si proponeva una politica di adempimento, lasciando da parte ogni strategia dilatoria. A rafforzare la credibilità internazionale della compagine governativa contribuì anche il Ministro della Ricostruzione, l’industriale Walter Rathenau, che durante la guerra aveva coordinato con grande abilità la produzione bellica. Rathenau entrò nel governo con la covinzione che la Germania dovesse onestamente tentare l’adempimento, stemperando le tensioni politiche e ristabiliendo le relazioni economiche, soprattutto con la Francia. L’opposizione nazionalista assunse a pretesto la confessione ebraica di Rathenau per esecrare le sue buone intenzioni come una espressione di servilismo antipatriottico. Nel furore della propaganda l’antisemitismo, lo sdegno verso le clausole del trattato di Versailles e l’odio verso la persona di Rathenau divennero una cosa sola.
Il primo atto concreto della politica di adempimento inaugurata da Wirth fu il pagamento, nell’agosto del 1921, di un miliardo di Marchi oro in conto riparazioni. La Germania dimostrò la propria determinazione a mantenere gli impegni sottoscritti, ma in termini economici dovette pagare un prezzo molto elevato. Il Dollaro che fino a luglio era cambiato a 60 Marchi, schizzò a 100 in settembre, a 200 in novembre. Di riflesso l’inflazione riprese la sua corsa. Ad indebolire il Marco sui mercati internazionali contribuì non solo il pagamento delle riparazioni, che sollevava dubbi sulla tenuta stessa dell’economia tedesca, ma anche la speculazione. Il continuo bisogno di valute pregiate da parte del Reich garantiva infatti la certezza a chi possedesse divise di poter realizzare ingenti profitti nell’arco di poche settimane, creando un circolo vizioso tra svalutazione e speculazione.
Il governo di Berlino tentò di ottenere una proroga o una riduzione delle riparazioni facendo leva sul crollo della sua moneta, ma ottenne dai suoi creditori soltanto risposte sprezzanti. L’economia tedesca nel suo complesso appariva in crescita, la disoccupazione era molto contenuta, dunque la Germania non doveva fare altro che affrontare con coraggio e determinazione i sacrifici che le imponevano gli impegni internazionali che si era assunta. I rimproveri alleati riguardavano in particolare l’inadeguatezza del sistema fiscale, incapace di garantire un flusso di entrate sufficiente a far fronte al debito di guerra.
Tra il novembre ed il dicembre del 1921 Wirth varò, dopo una accesa battaglia parlamentare, un’ampia riforma tributaria nel segno del rigore. Tuttavia le casse statali non ne trasero benefici apprezzabili, poiché l’inflazione non risparmiò né le entrate fiscali, né le spese correnti del Reich.
Al sostanziale fallimento della riforma tributaria seguì la dichiarazione del governo Wirth di non essere in grado di effettuare i pagamenti in scadenza nei primi mesi del 1922. In considerazione della volontà di collaborazione dimostrata dalla Germania sino a quel momento, Lloyd George e Briand decisero di convocare a Cannes, il 6 gennaio 1922, una conferenza economica per ridefinire il piano dei pagamenti. Alle discusioni di Cannes prese parte anche una delegazione tedesca, guidata da Rathenau che seppe conquistarsi la stima ed il rispetto di Lloyd Geroge. Probabilmente se i lavori della conferenza non fossero stati turbati dall’improvvisa caduta del governo Briand, la Germania avrebbe potuto strappare qualche vantaggiosa concessione; invece l’intransigenza del nuovo governo francese, guidata da Raymond Poincaré, ex Presidente della Repubblica ed ex Presidente della Commissione riparazioni, fece sfumare ogni prospettiva di una soluzione negoziata del nodo del piano dei pagamenti.
Benché Poincaré fosse fermamente convinto che l’epoca della superiorità francese fosse limitata a pochi anni e pertanto occorresse imbrigliare lo sviluppo tedesco evitando ogni sconto o dilazione sul debito, non poté tuttavia sconfessare quanto Briand aveva già concesso, cioè un rinvio dei pagamenti in scadenza e la convocazione a Genova di una nuova conferenza a cui sarebbero state ammesse anche la Germania e l’Unione Sovietica. Era convinzione del governo inglese che la ricostruzione economica dell’Europa non potesse avvenire senza la collaborazione russa. L’orrore per le crudeltà commesse dal governo bolscevico doveva essere messo da parte per riallacciare relazioni economiche ed ottenere il rimborso, almeno parziale, dei prestiti contratti dallo zar, oltreché il risarcimento delle proprietà occidentali confiscate durante la rivoluzione.
Nonostante la dilazione concessa a Cannes, le pressioni della Commissione riparazioni sulla Germania non si affievolirono. Gli Alleati chiesero ulteriori e più severe riforme fiscali al fine di accordare per l’anno in corso una definitiva riduzione dei pagamenti monetari e delle prestazioni reali. Alla fine di marzo Wirth e Rathenau, nel frattempo divenuto Ministro degli Esteri, dopo aver inizialmente assecondato le richieste della Commissione in materia fiscale, denunciarono al Reichstag l’irrigidimento degli Alleati, attribuendone la responsabilità a Poincaré, intenzionato ad assumere un controllo diretto sulle finanze tedesche. Anche i rapporti tra Londra e Berlino si deteriorano; Lloyd George interpretò le parole di Rathenau come un tentativo di spaccare il fronte alleato e se ne risentì, facendo venir meno il suo benevolo atteggiamento verso la Germania.
Il voltafaccia politico dei principali alfieri della politica di adempimento creò le peggiori premesse diplomatiche per la conferenza di Genova fissata per il 10 aprile 1922. Fin dall’esordio dei lavori la delegazione tedesca, guidata dal Cancelliere Wirth, fu emarginata dai colloqui confidenziali. Tale esclusione fu intepretata dai tedeschi come una avvisaglia di un imminente accordo tra il Commissario agli Esteri Cicerin e Lloyd George ai danni della Germania. Parve concretizzarsi la prospettiva che gli Alleati fossero disposti a riconoscere all’Unione Sovietica il diritto di esigere dalla Germania il pagamento dei danni di guerra che, sommati ai 132 miliardi di Marchi oro da versare alle potenze occidentali, avrebbero potuto rendere assai ciritico il futuro dell’economia tedesca.
Cicerin non esitò a sfruttare i timori di Wirth e di Rathenau per spingerli, all’insaputa di Francia ed Inghilterra, a firmare a Rapallo, la domenica di Pasqua, un accordo che da un lato consolidava i rapporti tra Mosca e Berlino, dall’altro costituiva quasi una sfida alle potenze alleate. L’Unione Sovietica rinunciava ad ogni riparazione per i danni di guerra subiti, così come la Germania si impegnava a non pretendere risarcimenti per i danni derivanti ai suoi cittadini dalle espropriazioni operate dal governo bolscevico. Inoltre, sul terreno commerciale i contraenti si riconoscevano reciprocamente la clausola della nazione più favorita, di cui la ripresa delle relazioni diplomatiche e consolari era un corollario.
Il riavvicinamento tra Mosca e Berlino, che dal novembre 1918 avevano interrotto le relazioni diplomatiche ufficiali, non fu una trovata estemporanea, ma il risultato di una lenta e tortuosa evoluzione politica. Il più accesso sostenitore di una apertura verso l’Unione Sovietica era stato il comandante della Reichswehr, il Generale Hans Von Seeckt, che riteneva di poter aggirare almeno in parte le limitazioni militari imposte dal trattato di Versailles facendo leva sulla solidarietà tra i vinti. Già nel maggio 1921 era stato concluso un primo accordo commerciale russo-tedesco a cui erano seguite trattative militari segrete che avevano portato alla creazione sul suolo russo di fabbriche d’armi finanziate dalla Germania ed all’attuazione di programmi di addestramento per gli ufficiali della Reichswehr in quelle specialità, come l’aeronautica, espressamente proibite dalla clausole di Versailles.
Al di là dei contenuti, il trattato di Rapallo fu interpretato dagli Alleati come una manovra ordita alle loro spalle, come un accordo che delineava una pericolosa solidarietà tra gli esclusi dalla comunità internazionale al fine di contestarne l’autorità. Lloyd George accolse con grande disappunto l’intesa russo-tedesca che d’improvviso vanificava tutti i suoi sforzi per ottenere da Cicerin qualche concessione riguardo ai debiti contratti dalla Russia zarista ed al risarcimento degli interessi economici occidentali danneggiati dall’avvento del regime comunista. Anche il suo obiettivo di contenere l’intransigenza di Poincaré verso la Germania risutò vanificato, dal momento che la diplomazia segreta di Rapallo rappresentava per il governo e l’opinione pubblica francesi una prova irrefutabile della doppiezza tedesca.
Poincaré, che non aveva partecipato in prima persona alla conferenza di Genova per non compromettere la sua libertà d’azione politica, trovò nuovi argomenti, agitando lo spettro di una alleanza russo-tedesca, per invocare provvedimenti che imponessero a Berlino il puntuale rispetto delle clausole di Versailles. Contro gli espedienti dilatori e le trame diplomatiche della Germania Poincaré si spinse sino ad affermare il diritto per ciascuno degli stati vincitori di intraprendere singolarmente, qualora non fosse possibile raggiungere un’intesa fra gli Alleati, azioni politiche tese ad ottenere la soddisfazione dei propri diritti legittimi.
Dopo l’annuncio del trattato di Rapallo, nonostante il lodevole impegno di Lloyd Geroge nel tentativo di riaprire il dialogo, le riunioni di Genova si conclusero frettolosamente, senza aver prodotto idee costruttive per risolvere il problema delle riparazioni e senza aver migliorato le relazioni tra la Germania e gli Alleati. Nei mesi successivi quel poco che restava della credibilità internazionale del governo Wirth fu gravemente compromesso dall’assassinio, nel giugno del 1922, del Ministro Rathenau ad opera di un commando di estrema destra. Ad armare le mani che uccisero Rathenau non furono le passioni suscitate dal trattato di Rapallo, quanto piuttosto la sconsiderata campagna d’odio alimentata dall’antisemitismo. Il fatto che un ebreo parlasse a nome della Germania, ostentasse amor patrio ed al tempo stesso si dichiarasse disponibile ad adempiere alle clausole di Versailles rappresentava per i fanatici ultranazionalisti un’onta da cancellare con il sangue.
La reazione dei mercati internazionali all’assassinio di Rathenau fu immediata e, sommandosi allo scontento per le incertezze del governo Wirth, assunse proporzioni drammatiche. Il Dollaro che in giugno era quotato 350 Marchi salì in luglio a 670, in agosto sfiorò i 2000 ed alla fine di ottobre si attestò a 4500, testimoniando lo sfaldamento della fiducia nelle capacità di risanamento della Germania.
La scomparsa di Rathenau indebolì anche il governo Wirth che in novembre, dopo aver fallito ogni tentativo di aprire uno spiraglio sulla questione delle riparazioni strappando una moratoria dei pagamenti, fu costretto alle dimissioni. A rovesciare Wirth furono questa volta i socialdemocratici con l’appoggio del Presidente Ebert che auspicava la formazione di un esecutivo di larghe intese capace di fronteggiare una situazione economica sempre più critica.
La sua reputazione internazionale di esperto di questioni economiche, le sue ottime relazioni con gli ambienti industriali e finanziari americani favorirono l’ascesa di Wilhelm Cuno, esponente di secondo piano del partito del centro ed alto funzionario del Ministero del Tesoro già nel periodo guglielmino. Prevalse nel Reichstag la convinzione che un tecnico di fama, la cui firma era nel mondo degli affari garanzia di solvibilità, potesse ottenere dai creditori alleati ciò che i politici puri fino ad allora non erano riusciti a strappare. Il carattere tecnico del governo Cuno, sottolineato dalla presenza di personalità estranee al Parlamento, non convinse tuttavia i socialdemocratici che, pur avendo sfiduciato Wirth, preferirono non farne parte.
Cuno esordì nel segno della continuità rispetto al suo predecessore, presentando agli Alleati una nuova richiesta di moratoria dei pagamenti. Ripropose la nota sottoscritta da Wirth il 13 novembre 1922, in cui la stabilizzazione del Marco, indicata come indispensabile da una commissione indipendente di esperti internazionali, tra cui spiccavano le personalità di Keynes e dello svedese Cassel, era subordinata alla concessione di una sospensione delle riparazioni.
La nota tedesca, che conteneva anche una la proposta di un prestito internazionale in oro per far fronte alle riparazioni, fu discussa dagli Alleati a Londra nel dicembre 1922, contestualmente al dibattito sul pagamento dei debiti di Italia, Belgio e Francia verso l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Poincaré si mostrò inflessibile, respinse le richieste tedesche e le proposte di mediazione formulate da Italia ed Inghilterra, sottolineò l’impossibilità della Francia a pagare i suoi debiti fino a quando la Germania non avesse onorato i suoi impegni, accusando il governo di Berlino di svalutare deliberatamente la propria moneta. Ai suoi occhi la prosperità dell’industria tedesca era un affronto intollerabile alle potenze vincitrici, pertanto il governo francese era disposto a procedere anche da solo contro la Germania se avesse insistito nella sua subdola politica dilatoria.
La conferenza di Londra si concluse ancora una volta con un nulla di fatto rinviando ogni decisione ad un successivo vertice fissato a Parigi per il 2 gennaio 1923. Poicaré non attese i tempi della diplomazia per trovare un pretesto che lo autorizzasse a mettere in atto il suo disegno punitivo nei confronti della Germania.
La mancata consegna da parte tedesca di un certo quantitativo di carbone e di 200.000 pali telegrafici in conto riparazioni gli fu sufficiente per ordinare, nonostante il parere contrario del governo inglese, l’occupazione del distretto della Ruhr.
A nulla servirono le imbarazzate giusitificazioni del governo Cuno che imputò i ritardi nelle consegne ai Läder che erano proprietari dei boschi ed al crollo monetario che aveva bloccato le consegne dei legnami ai prezzi originariamente concordati. L’11 gennaio 1923 cinque divisioni francesi ed una belga penetrarono in territorio tedesco ed assunsero il controllo della più imporante area industriale della Germania, garantendo a Parigi non solo i “pegni produttivi” che da tempo reclamava, ma anche la prospettiva di rallentare la crescita dell’economia tedesca a tutto vantaggio di quella francese e di mettere in sicurezza, almeno nel medio periodo, i propri confini nazionali.
La Germania intera rispose all’invasione con un grido di indignazione. Lo spirito patriottico dell’agosto 1914 fu improvvissamente resuscitato dalla tracotanza di Poincaré. Le forze politiche e sindacali si strinsero attorno alle istituzioni ed incoraggiarono la resistenza passiva della popolazione renana. Perfino i comunisti si espressero con accesi toni nazionalistici incitando il proletariato alla difesa contro il capitalismo e l’imperialismo finanziario occidentale.
Tutte le consegne in conto riparazioni furono bloccate dal governo Cuno che invitò i pubblici funzionari, compresi i ferrovieri, a rifiutare qualsiasi forma di collaborazione con le forze occupanti. Non mancarono atti di sabotaggio né scontri cruenti tra le truppe occupanti e la popolazione, come quello verificatosi presso le officine Krupp di Essen in cui furono uccisi tredici lavoratori, ma in generale l’ostilità tedesca all’invasore si manifestò attraverso la resistenza passiva proclamata dal governo Cuno, a cui le autorità francesi risposero con l’espulsione di oltre 100.000 persone dalla Renania.
A rafforzare lo spirito di resistenza tedesco contribuì anche la frattura delineatasi tra gli Alleati nella conferenza di Parigi del 2 gennaio 1923. Mentre l’Italia ed il Belgio si erano schierati sulle posizioni intransigenti di Poincaré, il governo inglese aveva affermato la propria disapprovazione verso ogni azione di forza, alimentando a Berlino la speranza di poter volgere a proprio vantaggio tale profondo dissidio.
La resistenza passiva si rivelò non solo incapace di rompere la solidarietà di fondo tra Londra e Parigi, ma anche estremamente onerosa sotto il profilo economico e finanziario. La paralisi dell’economia della Ruhr finì per danneggiare più la Germania che le mire dell’occupante francese. Centinaia di migliaia di operai e di minatori dopo aver incrociato le braccia difronte agli invasori dovettero essere soccorsi con sovvenzioni statali che aggravarono il già disastrato bilancio tedesco. All’incremento delle spese corrispose, a causa dell’invasione, anche una contrazione delle entrate fiscali.
Il governo Cuno fece fronte alle nuove emergenze stampando ancora una volta moneta che impresse una spinta ulteriore all’inflazione. Sui mercati internazionali il Marco accelerò la sua caduta. Il giorno dell’invasione il Dollaro era quotato intorno ai 10.000 Marchi, a fine gennaio aveva raggiunto i 50.000, costringendo il Governatore della Reichsbank Havenstein ad un massiccio intervento. In assenza di una prospettiva politica che superasse la resistenza ad oltranza, larga parte delle riserve auree e valutarie tedesche fu sperperata. In aprile la Reichsbank dovette rassegnarsi a lasciar fluttuare il Marco che non tardò a precipitare nuovamente. Alla fine di luglio un Dollaro valeva un milione di Marchi. L’economia nel suo complesso appariva prossima al collasso, poiché il venir meno del carbone della Ruhr costringeva l’industria ad approvvigionarsi all’estero, dando fondo alle proprie riserve valutarie oppure subendo le conseguenze di un tasso di cambio assai svantaggioso.
Al protrarsi della resistenza passiva Poincaré rispose con spietata fermezza.
L’ordine impartito ai ferrovieri di non dare attuazione alle ordinanze francesi procurò inizialmente non poche difficoltà agli invasori, ma offrì loro il pretesto per l’usurpazione dell’intera rete ferroviaria delle Ruhr. La resistenza passiva opposta dai funzionari statali determinò la loro espulsione, privando il territorio degli organi amministrativi e lasciando la popolazione alla mercé dei tribunali di guerra francesi.
Poincaré non rinunciò né a provocare il ben noto orgoglio razziale tedesco facendo largo impiego di truppe coloniali, né ad estendere il territorio d’occupazione al di là dei confini originariamente previsti, né ad introdurre un confine doganale tra il territorio occupato e quello non occupato.
Il fallimento dei tentativi di mediazione inglesi, la disastrosa situazione economica e finanziaria, l’aggravarsi delle sofferenze della popolazione renana convinsero il governo Cuno a cercare una via d’uscita al vicolo cieco a cui lo aveva condotto la resistenza passiva. Il principale ostacolo ad una rinuncia al braccio di ferro con Poincaré era costituito dal timore delle reazioni dell’opposizione nazionalista e nazista che fin dall’inizio dell’invasione non aveva esitato a lanciare parole d’ordine rivoluzionarie. Da Monaco Adolf Hitler non smetteva di gridare le sue invettive contro i traditori di novembre, cioè contro l’intera classe politica che aveva generato la Repubblica di Weimar. Alle parole infuocate della propaganda rischiavano di seguire i fatti. Il 1° maggio Hitler raccolse in Baviera oltre cinquemila uomini armati che furono dispersi senza spargimenti di sangue solo grazie all’intervento della Reichswehr.
Logorato dal suo attendismo rispetto sia alle crescenti minacce all’ordine pubblico interno, sia alla questione della Ruhr, Cuno rassegnò le dimissioni nell’agosto del 1923. Le pressioni dell’opinione pubblica favorirono la designazione alla carica di Cancelliere del fondatore del partito popolare, Gustav Stresemann, che nei mesi precedenti si era segnalato per realismo ed equilibrio. La sua ispirazione liberale e monarchica offrì garanzie patriottiche all’elettorato moderato, il suo appello all’unità delle forze democratiche, emarginando gli eversori di destra e di sinistra, convinse il partito socialdemocratico.
Per enfatizzare la centralità nel suo programma della soluzione della questione della Ruhr Stresemann riservò per sé il Ministero degli Esteri. A conferma del suo rifiuto di ogni preclusione ideologica assegnò allo studioso socialdemocratico Rudolf Hilferding il Ministero delle Finanze.
Negli stessi giorni in cui la Germania si dava un nuovo esecutivo, l’Inghilterra lanciò una nuova offensiva diplomatica contro Poicaré. Il Ministro degli Esteri Lord Curzon diffuse una nota di ferma condanna dell’occupazione della Ruhr, giudicandola illeggittima ed incociliabile con le clausole del trattato di Versailles. La risposta francese respinse puntualmente le argomentazioni inglesi, ribadendo che solo l’immediata cessazione della resistenza passiva nella Ruhr avrebbe potuto consentire una riapertura delle trattative con la Germania. Stresemann ne prese atto ed accettò, nel settembre 1923, di piegarsi alle condizioni poste da Poincaré.
Gli spiragli di distensione nei rapporti franco-tedeschi non furono tuttavia sufficienti ad arrestare il crollo del Marco. Alla fine di settembre occorrevano 160 milioni di Marchi per acquistare un Dollaro.
Stresemann ed Hilferding non tardarono a rendersi conto che non era pensabile di risolvere i problemi di politica estera, risanare il bilancio dello stato e neutralizzare le spinte eversive interne senza procedere ad una stabilizzazione della moneta. Se l’emissione monetaria non era più praticabile, poiché il Marco aveva perso ogni valore abicando a favore del baratto, al tempo stesso la Reichsbank non disponeva neppure dell’oro sufficiente a garantire la copertura di un nuovo Marco. La teoria monetaria classica riconosceva soltanto l’oro come misura di valore costante su cui fondare la moneta, quindi solo una idea innovativa avrebbe potuto salvare la Germania dal più completo disastro.
Il merito di aver fornito una prima risposta al dilemma apparentemente insolubile in cui si dibatteva la finanza tedesca fu di Karl Helfferich, un nazionalista scalmanato, ma anche un tecnico di grande valore. Il suo progetto, presentato al Ministero delle Finanze, prevedeva al fondazione di una Rentenbank, una banca di credito agrario, la quale doveva avere diritto ad una obbligazione reale fruttifera su tutti i fondi del Reich sfruttati a scopo agricolo ed industriale. Tale obbligazione avendo la precedenza su tutti gli oneri che gravavano i fondi poteva essere considerata sicura come l’oro. Helfferich immaginò che la nuova moneta potesse essere espressione di un valore reale come il prezzo di una libbra di segala, il principale prodotto dell’agricoltura tedesca. Il Roggenmark, il Marco fondato sulla segala, avrebbe immediatamente incontrato la fiducia degli agricoltori ed allontanato lo spettro della carestia che ormai aleggiava sulla Germania.
Il Ministro Hilferding accolse con interesse il progetto Helfferich, ma non si decise ad attuarlo. Lo valutò, lo comparò con altri nel frattempo arrivati sulla sua scrivania, senza arrivare a maturare una precisa convinzione. I suoi tentennamenti irritarono i partiti della maggioranza che nell’ottobre del 1923 preferirono affidare il Ministero delle Finanza ad Hans Luther che, pur non essendo un grande esperto di questioni monetarie, appariva risoluto.
I problemi monetari non erano gli unici a preoccupare Stresemann. L’ingresso dei socialdemocratici nel suo governo aveva suscitato forsennati attacchi da parte dell’estrema destra che attribuiva al nefasto influsso marxista l’abbandono della resistenza passiva e la conseguente umiliazione della patria. In Baviera lo sdegno dei nazionalisti spinse il Presidente del Consiglio Von Knilling ad accordare i pieni poteri al prefetto Von Kahr, intenzionato a raggruppare intorno a sé le forze autonomiste e l’estrema destra nella confusa prospettiva di una restaurazione monarchica. L’ordine costituzionale e l’unità stessa del Reich parvero gravemente minacciate. In virtù dell’articolo 48 della costituzione di Weimar il Presidente Ebert proclamò lo stato di emergenza ed affidò i pieni poteri al governo.
L’agitazione nazionalista non risparmiò neppure le province più vicine a Berlino. All’inizio di ottobre Buchrucker, un ex ufficiale che aveva organizzato nel Brandeburgo, con il tacito appoggio delle autorità locali della Reichswehr, delle formazioni paramilitari, si apprestò a riunire nei pressi delle fortezze di Spandau e di Küstrin i suoi armati per marciare contro la capitale e quindi rovesciare le istituzioni legittime. I vertici della Reichswehr non assecondarono le ambizioni golpiste di Buchrucker che fu prontamente arrestato.
In Sassonia ed in Turingia furono invece i comunisti a tentare di sfruttare il caos politico seguito alla cessazione della resistenza passiva nella Ruhr. Ad Amburgo scoppiò una violenta insurrezione comunista che fu sedata nel sangue. In Turingia fu sufficiente dispiegare l’esercito lungo il confine settentrionale della Baviera per placare gli animi e reataurare l’ordine pubblico. Nella stessa Renania in cui la maggior parte della popolazione aveva sostenuto con tenacia la resistenza passiva si sviluppò, fomentato dalle truppe di occupazione, un movimento separatista. Si verificarono anche scontri molto cruenti. Nel novembre del 1923 nei pressi di Siebengebirge centottanta separatisti furono trucidati dalla popolazione.
Il dilagare dei focolai insurrezionali in tutto il paese convinse il governo Stresemann a temporeggiare nell’intervento nei confronti di Von Kahr, che in Baviera godeva di ampie simpatie anche all’interno della Reichswehr. A rompere gli indugi dettati dalla prudenza intervenne il putsch organizzato a Monaco dai nazisti. La sera dell’8 novembre 1923 Hitler alla testa di un manipolo di armati fece irruzione in una birreria in cui si stava svolgendo una riunione di sostenitori di Von Kahr. Sotto la minaccia delle armi Hitler ottenne da Von Kahr l’adesione al suo progetto rivoluzionario che da Monaco avrebbe dovuto estendersi a Berlino, sotto la guida del Generale Ludendorff, il comandante durante la guerra delle armate del Kaiser. Una volta liberato, l’astuto Von Kahr non mantenne la sua promessa e mobilitò polizia ed esercito contro le milizie naziste che furono disperse nei pressi della Feldherrnhalle in Odeonsplatz dopo uno scontro sanguinoso. Undici nazisti rimasero sul selciato, Hitler e Ludendorff furono arrestati, Hermann Göring, gravemente ferito, riuscì a mettersi in salvo.
Lo stato di emergenza proclamato dal presidente Ebert si rivelò provvidenziale, oltre a consentire la salvaguardia della legalità repubblicana, dotò il governo Stresemann degli strumenti normativi per affrontare rapidamente la stabilizzazione del Marco.
Il 15 novembre 1923, in virtù di un’ordinanza emessa un mese prima, entrò in funzione la Deutsche Rentenbank, così come l’aveva immaginata Helfferich nel suo progetto. Al fantasioso Roggenmark, Stresemann e Luther preferirono però il Rentenmark, fondato sul valore dell’oro, così come l’obbligazione reale sui fondi tedeschi, dai quali doveva essere garantita. L’ordinanza di ottobre aveva fissato anche i limiti di emissione ed il credito da concedere al Reich, fornendo in tal modo una effettiva garanzia sul valore della moneta. A partire dall’emissione del Rentenmark il Reich dovette rinunciare alla cessione dei suoi buoni del tesoro contro Marchi-carta presso la Reichsbank, avviando così il risanamento del bilancio statale.
Il diluvio di bilioni di carta moneta priva di valore che aveva sommerso la Germania si arrestò. Non appena comparvero i primi biglietti della Rentenbank il mondo degli affari e la gente comune si affrettarono a farne incetta, ansiosi di possedere finalmente una moneta capace di mantenere nel tempo il suo valore. Al fine di incidere con efficacia su inflazione e svalutazione fu stabilito il rapporto di scambio di un Rentenmark per mille miliardi di Marchi-carta.
Nonostante i suoi indubbi meriti il governo Stresemann non ebbe vita lunga. I socialdemocratici, mossi da calcoli elettoralistici, ritirarono il loro appoggio a Stresemann, rimproverandogli di essere intervenuto tempestivamente a sedare i disordini in Turingia ed in Sassonia e di aver invece mantenuto un cauto atteggiamento passivo nei confronti della politica eversiva della Baviera. Date le precarie condizioni dell’ordine pubblico in molte regioni ed il perdurare dell’occupazione in Renania, il Presidente Ebert rifiutò di indire nuove elezioni. Tale rifiuto costrinse i partiti a ricercare un nuovo equilibrio nel segno della continuità. Sostenuto dai partiti centristi, Wilhelm Marx, un alto magistrato su posizioni conservatrici, ma di sincera fede repubblicana, assunse la guida del governo, Stresemann divenne invece Ministro degli Esteri, carica che avrebbe ricoperto sino alla morte, nell’ottobre del 1929.
Grazie al voto favorevole del partito socialdemocratico, il governo Marx fu dotato, sino al febbraio 1924, del poter di adottare, senza la preventiva approvazione del Reichstag, quelle misure che ritenesse urgenti per fronteggiare le molteplici emergenze che minacciavano la Germania. Tali straordinaire attribuzioni furono limitate soltanto dal diritto riconosciuto al Reichstag ed al Reichsrat di chiedere successivamente l’abrogazione delle misure assunte dal governo.
Dotato di così vasti poteri Marx poté agevolmente aumentare la pressione fiscale e migliorare il sistema di riscossione delle imposte, al fine di garantire al Reich quelle risorse che dopo la riforma valutaria non poteva più sperare di reperire facendo semplicemente ricorso al credito della Reichsbank. L’incremento delle entrate fiscali ed il risanamento dei conti pubblici favorirono il successo della riforma valutaria, ristabilendo un clima di fiducia attorno all’economia tedesca. La nomina, nel dicembre del 1923, di Hjalmar Schacht, un tecnico di grande valore proveniente dalle file del partito democratico, alla guida della Reichsbank sancì la fine di una dissennata politica creditizia e la ripresa di proficue relazioni con gli ambienti finanziari inglesi e non solo.
Per superare del tutto uno dei periodi più turbolenti della storia dell’economia tedesca restavano da sciogliere il nodo dell’occupazione della Ruhr ed il nodo delle riparazioni che tanta parte aveva avuto nell’alimentare svalutazione ed inflazione oltreché un clima di forte tensione nelle relazioni internazionali.
Il Presidente americano Harding, che riteneva indispensabile per la stabilità mondiale porre termine alle estenuanti e sterili polemiche sul debito tedesco, avanzò l’ipotesi di formare una nuova commissione internazionale sulle riparazioni. Inizialmente il suo appello rimase inascoltato, poi, dopo la rinuncia da parte di Stresemann alla resistenza passiva, il governo inglese lo sostenne con convizione. Poincaré si dichiarò invece contrario, adducendo pretesti formali che impedivano la creazione di una nuova commissione. Come soluzione di compromesso gli Alleati giunsero a stabilire, il 30 novembre 1923, di affiancare alla Commissione riparazioni creata secondo la lettera del trattato di Versailles due comitati di esperti, incaricati di indagare uno sulle misure da adottare per riportare in equilibrio il bilancio del Reich e stabilizzare la valuta tedesca, e l’altro sulla fuga di capitali dalla Germania.
Per enfatizzare l’importanza del contributo degli Stati Uniti, la presidenza del primo comitato fu affidata, nel gennaio 1924, all’americano Charles Dawes, Presidente di una Trust Company con ottime relazioni a Washington. Americana fu anche la vicepresidenza, ricoperta da Owen Young, esperto di questioni finanziarie.
Dawes lavorò con grande energia, spingendosi ben oltre gli angusti compiti assegnati al suo comitato. Non si accontentò di visionare i conti, ma volle personalmente recarsi a Berlino. Non tardò a convincersi che il risanamento del bilancio tedesco e la stabilità della nuova valuta dipendevano dagli obblighi imposti dal trattato di Versailles. Occorreva dunque da un lato stabilire quanta parte delle sue entrate fiscali la Germania potesse destinare al debito senza generare effetti depressivi sulla sua economia e destabilizzanti per la sua valuta, dall’altro predisporre gli strumenti che concretamente garantissero ai creditori pagamenti regolari, al riparo dalle fluttuazioni politiche tedesche ed internazionali.
Il comitato Dawes esaminò meticolosamente l’ordinamento delle finanze tedesche e giunse a stabilire in 2,5 miliardi di Marchi oro la capacità di prestazione della Germania in un anno normale. Riconobbe tuttavia che nelle condizioni attuali tale somma era eccessivamente elevata, quindi suggerì un periodo di transizione di quattro anni con prestazioni minori, ma crescenti di anno in anno. Per evitare di rinfocolare polemiche politiche fomentate tanto dal revanchismo francese quanto dal nazionalismo tedesco, il comitato evitò di precisare l’ammontare complessivo delle riparazioni, si preoccupò invece di sottolineare come soltanto una ristabilita unità fiscale del Reich avrebbe consentito alla Germania di onorare i suoi debiti. In tal modo pose di fatto la cessazione dell’occupazione franco-belga della Ruhr come precondizione per il successo del piano di rientro del debito tedesco.
Il comitato Dawes offrì una soluzione anche al problema dei “pegni produttivi”, cioè le garanzie reali sul pagamento del debito a cui Poincaré non era assolutamente disposto a rinunciare. Le ferrovie tedesche, con il loro ingente patrimonio, sarebbero diventate un “pegno produttivo” attraverso il loro trasferimento ad una società con un consiglio di amministrazione nominato per una metà dal governo tedesco e per l’altra dai paesi creditori. Tale società avrebbe emesso undici milioni di obbligazioni che, garantite con una ipoteca sul patrimonio immobiliare delle ferrovie, avrebbero fruttato negli anni normali un 5% di interessi, da versare in conto riparazioni. Altri “pegni produttivi” ideati dal comitato Dawes furono cinque miliardi di obbligazioni industriali ed il riconoscimento ai paesi creditori di un certo controllo sulle entrate del Reich derivanti dalle imposte su tabacco, zucchero, birra ed alcolici.
Tali onerosi “pegni produttivi” furono intesi, in modo da apparire accettabili al governo tedesco, come garanzie ad un prestito internazionale di 800 milioni di Marchi oro concesso alla Germania, in primo luogo dagli Stati Uniti, per aiutarla a superare le difficoltà iniziali legate alla riforma valutaria.
Il governo Marx-Stresemann comprese che il lodo Dawes, seppur al prezzo di non trascurabili sacrifici, offriva alla Germania la possibilità di rientrare nella comunità internazionale, di superare l’isolamento e recuperare la Ruhr, perciò lo accolse con grande favore. L’opposizione nazionalista lo considerò invece uno strumento per imporre al popolo tedesco una perenne schiavitù, tuttavia non riuscì, nonostante l’incremento di consensi ottenuto in occasione delle elezioni del maggio 1924, a boicottarne l’attuazione.
Nella conferenza di Londra del luglio-agosto 1924 il piano Dawes fu accettato dai rappresentanti di tutti i governi. Sebbene il tema dell’evacuazione della Ruhr non fosse stato inserito, per volontà di Parigi, nell’elenco dei temi all’ordine dle giorno, il rappresentante francese Herriot, nel corso di un colloquio riservato con Stresemann, assunse l’impegno, poi lealmente mantenuto, di porre termine all’occupazione della Ruhr entro dodici mesi.
L’approvazione del piano Dawes segnò il tramonto della stagione dei diktat nelle relazioni tra la Germania e gli Alleati, pose le premesse per la riunificazione dei territori occupati, favorì la ripresa economica e la stabilizzazione del Marco, garantendo alla Repubblica di Weimar un breve periodo di relativa tranquillità. La quiete prima di una nuova e più furiosa tempes
Bibliografia
ERICH EYCH, Storia della Repubblica di Weimar (1918-1933), Torino, Einaudi, 1966.
HAJO HOLBORN, Storia della Germania moderna (1840-1945), Milano, Rizzoli, 1973.
RICHARD J. EVANS, La nascita del Terzo Reich, Milano, Mondadori, 2005.
DETLEV J. K. PEUKERT, La Repubblica di Weimar. Anni di crisi della modernità classica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996
WILLIAM L. SHIRER, Storia del Terzo Reich, Torino, Einuadi, 1962.
SEBASTIAN HAFFNER, Storia di un tedesco. Un ragazzo contro Hitler dalla Repubblica di Weimar all’avvento del Terzo Reich, Milano, Garzanti, 2003.
#crollo del marco#Germania di Weimar#iperinflazione#mille miliardi di volte#Raimund Pretzel#Reichsbank
0 notes
Link
COME OGNI ANNO DEVE ESSERE RICORDATA SEMPRE LA SCELLERATEZZA DELLA MONARCHIA ,DEI GOVERNANTI, DELLA BORGHESIA, CAPACI DI GETTARE MILIONI DI VITE UMANE DENTRO AD UNA TRAGEDIA DI INCALCOLABILE PORTATA PER LA LORO INSENSATA VOLONTA’ DI POTENZA, DOMINIO, SFRUTTAMENTO. NON DIMENTICARE MAI E RICORDARE SEMPRE DA CHE PARTE SI COLLOCANO GRAVISSIME RESPONSABILITA’ STORICHE. RICORDARE SEMPRE ANCHE SE SONO PASSATI PIU’ DI CENT’ANNI PERCHE’ L’ORRORE DELLA GUERRA, COME DIMOSTRANO LE CRONACHE DELL’ATTUALITA’, E’ SEMPRE IN AGGUATO AD OGNI TORNANTE DELLA STORIA. Gabriele D'Annunzio 24 Maggio 1915: “mormorò il Piave” e gli italiani furono gettati, grazie ad un vero colpo di stato militar-monarchico, nella fornace divoratrice della prima guerra mondiale. L’Italia non era obbligata a entrare in guerra. Sebbene la Triplice Alleanza (sottoscritta per la prima volta nel 1882) la legasse formalmente all’Austria e alla Germania, il fatto che l’Austria non l’avesse consultata prima di dichiarare guerra alla Serbia alla fine del luglio 1914 aveva significato che a rigore l’Italia era sciolta dai suoi obblighi. Così mentre l’Europa mobilitava i suoi eserciti e nel corso dell’Agosto 1914 prese a scivolare verso la catastrofe, l’Italia annunciò la sua neutralità. E molti, compresi Giolitti e una maggioranza di deputati, pensavano dovesse rimanere neutrale. Erano convinti che il Paese fosse economicamente troppo fragile per sopportare un conflitto di grandi dimensioni, tanto più a così breve distanza dall’invasione della Libia (1911). Giolitti suggerì che l’Italia aveva da guadagnare “parecchio” contrattando con entrambe le parti la sua rinuncia a combattere. Ma il Presidente del Consiglio del momento, Salandra, e il suo ministro degli Esteri, Sonnino, condussero negoziati segretissimi con i governi di Londra e Parigi da un lato e di Vienna e Berlino dall’altro (nello spirito di quello che Salandra chiamò “sacro egoismo”) con l’intenzione di accertare quale prezzo l’Italia poteva spuntare per il suo intervento nel conflitto. Gli interventisti costituivano un fascio di forze eterogenee che agivano per motivazioni diverse. C’era una minoranza di idealisti liberali. C’era il Re, che aveva ricevuto un’educazione militare e che voleva ridurre l’influenza di Giolitti, così come suo nonno aveva tentato di liberarsi di quella di Cavour. La maggior parte dei massoni e degli studenti universitari dotati di più viva coscienza politica erano interventisti, e gli irredentisti naturalmente lo erano “in toto”. Il partito nazionalista, non appena cominciò a svanire la sua originaria speranza di una guerra contro la Francia, fece fronte comune contro la Germania, dato che per esso una guerra qualsiasi era meglio che nessuna guerra. I futuristi pure erano decisamente per la guerra, vista come un rapido ed eroico mezzo per raggiungere potenza e ricchezza nazionale: nel settembre del 1914 interruppero a Roma un’opera di Puccini per bruciare sul palcoscenico una bandiera austriaca. Marinetti dichiarò che i futuristi avevano sempre considerato la guerra come l’unica fonte di ispirazione artistica e di purificazione morale e che essa avrebbe ringiovanito l’Italia, l’avrebbe arricchita di uomini d’azione e l’avrebbe infine costretta a non vivere più del suo passato, delle sue rovine e del suo clima. Strani compagni di viaggio di questi elementi d’avanguardia erano i conservatori che continuavano la tradizione francofila di Visconti Venosta e di Bonghi, ma anche Salvemini e i socialisti riformisti, i quali volevano una guerra condotta con generoso idealismo, nel nome della libertà e della democrazia, contro la Germania che aveva invaso il Belgio violandone la neutralità. I socialisti rivoluzionari con a capo Mussolini furono sorpresi di essersi venuti a trovare nello stesso campo neutralista in compagnia dei loro tre principali nemici, Giolitti, Turati e il Papa. Ma nell’ottobre 1914 Mussolini modificò il suo atteggiamento in “neutralità condizionata” per abbracciare infine nel novembre la tesi opposta dell’interventismo dichiarato. Può darsi che questo sconcertante cambiamento fosse dovuto al denaro francese, ma senza dubbio influì su Mussolini la convinzione che la guerra avrebbe potuto preparare il terreno alla rivoluzione e abituare le masse alla violenza e alle armi. De Ambris, Corridoni e gli altri superstiti del sindacalismo rivoluzionario aderirono a questa visione. Arrivarono poi, nella primavera del 1915, quelle poi definite “le radiose giornate di maggio”: il contributo offerto in quei giorni da D’Annunzio con i suoi infiammati discorsi di Genova e di Roma e da De Ambris e Corridoni con le agitazioni suscitate in quel centro nevralgico che era Milano risultavano decisive per il colpo pensato dalla minoranza interventista. Per la propaganda il governo fece ricorso ai fondi segreti, e la polizia aveva da lungo tempo imparato sotto Giolitti l’arte di organizzare “manifestazioni popolari spontanee”. Come poi osservò Salandra, queste manifestazioni erano guidati in massima parte da studenti universitari che, poi, nell’immediato dopoguerra tornati dal fronte come ufficiali avrebbero formato il nucleo più importante degli Arditi e delle squadre d’azione fasciste. D’Annunzio, tornato dalla Francia dove si era nascosto per sfuggire ai creditori, fu informato preventivamente del Trattato di Londra e adeguatamente retribuito per la sua opera di propaganda e concluse i suoi discorsi di Genova (4 Maggio, allo scoglio di Quarto) e di Roma (12 e 13 Maggio) con questa proclamazione: “O compagni, questa guerra che sembra opera di distruzione e di abominazione, è la più feconda matrice di bellezza e di virtù apparsa sulla terra”. Tale fu la carica emotiva di quel maggio 1915 che alcuni guardarono poi a esso come a un momento di rigenerazione, il momento nel quale l’Italia aveva deciso di combattere per la giustizia e di vincere per la democrazia. Un abbaglio colossale. Il 20 maggio la Camera concesse al Governo i pieni poteri con una maggioranza di 407 voti contro 74 (Giolitti era già rientrato in Piemonte). Il Partito Socialista votò contro, diventando l’unico partito europeo di estrema sinistra fuori dalla Russia a non dare il suo appoggio al conflitto. Il 24 Maggio l’Italia dichiarò guerra all’Austria. Una nazione lacerata nel suo tessuto morale si apprestava a sostenere uno scontro che sarebbe durato più di 3 anni lasciando sul terreno 650.000 morti e un milione di feriti. I fanti, che presto si sarebbero trovati a morire nelle trincee, non avrebbero certo potuto non sentire tutta la brutalità e tutto il cinismo di chi li aveva trascinati alla guerra attraverso una simile mistificante retorica. Una lezione della storia, da non dimenticare mai. Le porte ad una delle più grandi tragedie della storia erano ormai aperte e, alla fine, in fondo al tunnel non sarebbe rimasto altro da fare che imboccare il tunnel della dittatura fascista. Franco Astengo
0 notes
Text
sede: MAAB Gallery (Milano).
Attraverso una selezione di oltre venti opere realizzate tra gli anni Sessanta e Novanta del Novecento, l’esposizione ripercorre la lunga carriera dell’artista ceco (Protovín 1924 – Praga 2002).
Da sempre affascinato dai caratteri tipografici, autore di saggi e poesie, il poliedrico Jirí Kolár elegge il collage a una vera e propria scienza. Tecnica di origini antichissime, ma diffusa ampiamente in Europa solo dai primi decenni del XX secolo, quando venne praticata da cubisti, dadaisti e surrealisti, il collage trova nelle creazioni di Kolár un ampio spettro di possibili soluzioni, elencate dall’artista stesso nel Dictionnaire des méthodes, terminato nel 1983.
Rollages, come Senza titolo – Omaggio a Nefertiti (1987), in cui l’immagine della celebre regina egizia viene frammentata in una sequenza di strisce uguali poi ricomposte in un nuovo complesso figurativo, chiasmages, tra cui Preghiera per la misericordia (1984), ove si ritrovano tracce di un testo religioso in latino, lintons, come Il gioco celato (1974), e altre tipologie di collages rivelano allo spettatore l’universo creativo di Kolár, popolato da estratti di spartiti musicali e testi religiosi, lacerti di noti dipinti e sculture e tracce della quotidianità che ci raccontano, per immagini, la nostra storia.
Jirí Kolár nasce il 24 settembre 1914 a Protivín in Boemia. Nel 1922 la sua famiglia si trasferisce a Kladno, non lontano da Praga. Dopo un’adolescenza caratterizzata da lavori fortuiti, a 16 anni scopre l’edizione ceca di Les mots en libertéfuturistes di Filippo Tommaso Marinetti, che lo conduce nel mondo della poesia moderna. Grazie all’incontro con il Surrealismo inizia a lavorare con la tecnica del collage. Nel 1937 tiene la sua prima mostra personale al Mozarteum di Praga.
Nel 1941, durante l’occupazione tedesca, esce la sua prima raccolta di poesie e nel novembre del 1942 fonda il gruppo “Skupina 42” insieme ad altri poeti, pittori, studiosi di storia dell’arte, uno scultore e un fotografo. Tra il 1946 e il 1948 viaggia in Germania, a Parigi e in Gran Bretagna e nel 1952 pubblica Il Fegato di Prometeo nel quale, assemblando poesie, prosa e immagini, denuncia la drammatica situazione cecoslovacca dopo l’avvento del regime comunista; una dura verità che insieme ad altri scritti gli costa nove mesi di carcere e il divieto di pubblicare fino al 1964.
Verso la fine degli anni Sessanta espone in Germania e in Brasile dove, nel 1969, è premiato alla X Biennale di San Paolo; seguono esposizioni in Canada e in Giappone. Nel 1975, 1978 e nel 1985 il Guggenheim R. Solomon Museum di New York gli dedica tre personali. Nel 1991 riceve il Premio Seifert e viene nominato cittadino onorario di Praga. Nel 1999 per motivi di salute torna a Praga, lasciando definitivamente Parigi dove aveva vissuto dal 1980. Muore nell’agosto del 2002.
La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue (italiano-inglese) con saggio di Gianluca Ranzi.
#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Jirí Kolár, il Poeta del Collage sede: MAAB Gallery (Milano). Attraverso una selezione di oltre venti opere realizzate tra gli anni Sessanta e Novanta del Novecento, l'esposizione ripercorre la lunga carriera dell'artista ceco (Protovín 1924 – Praga 2002).
0 notes
Photo

Nuovo post su https://is.gd/osQ723
Il soldato ruffanese Rocco Gnoni e le fucilazioni sommarie nella Prima Guerra Mondiale
di Paolo Vincenti*
Giovani soldati che verranno cancellati dal tempo
e dimenticati come cenere dispersa nel vento
figli di una terra che non vuole più tenerseli accanto
cosa rimane dopo un sacrificio inutile
di questa vita già finita in un istante soltanto il mio onore
il bene più importante
(Enrico Ruggeri, Il mio onore)
Una dolorosa pagina di storia nazionale, una delle più inquietanti della Prima Guerra Mondiale, è quella delle fucilazioni sommarie, che vide alcune centinaia di soldati morti per repressione interna, ovvero uccisi sul fronte dallo stesso esercito italiano per episodi di insubordinazione o resistenza agli ordini, diserzione o altro ancora. Nella Prima Guerra Mondiale non si moriva solo di fame, di freddo, di stenti, di malattie contratte nelle trincee, o sotto i colpi dell’esercito nemico.
In migliaia di processi sommari a discapito di soldati italiani, mandati alla sbarra per futili motivi, molti di questi soldati con estrema superficialità vennero condannati. Soldati innocenti, con un banale pretesto, venivano accusati di gravi misfatti e passati alle armi, assolvendo alla funzione di capro espiatorio, secondo la più classica concezione di derivazione ebraica.
E anzi se la guerra stessa, secondo l’interpretazione antropologica abbondantemente sviluppata da Renè Girard della violenza fondatrice della nazione, sta alla base della odierna società[1], a maggior ragione, il sacrificio di un drappello di soldati, per giunta giovani, si presenta come una specie di macabra sineddoche, pars pro toto, cioè, della guerra, che è essa stessa sacrificio di massa, secondo Roger Caillois[2]. Le motivazioni spesso addotte dai tribunali erano del seguente tenore: «il tribunale non ritiene di dover concedere le attenuanti generiche nell’interesse della disciplina militare per la necessità che un salutare esempio neutralizzi i frutti della propaganda demoralizzatrice». Ossia, le condanne venivano comminate anche «in chiave di ammonimento e di prevenzione generale», fedelmente al motto di Mao Zedong “colpirne uno per educarne cento”, poi fatto proprio dalle Brigate Rosse italiane negli anni del terrorismo. L’arroganza del Generale Cadorna, il senso di sfiducia e di sospetto da parte del Comando Supremo nei confronti dei soldati, generato dalla consapevolezza della palese impreparazione del nostro esercito rispetto alle forze nemiche, portarono alle sanguinose repressioni di militari sui militari. Queste repressioni avvenivano per i più svariati motivi, quali diserzione, comportamenti indisciplinati, atti di autolesionismo. Quello che è peggio è che questi severi provvedimenti venivano lasciati all’arbitrio degli ufficiali sul campo, i quali erano costretti ad assumere delle decisioni fatali senza il giusto discernimento, turbati dalla grave tensione del momento o dal timore di essere essi stessi oggetto di provvedimenti disciplinari per mancato decisionismo. Il tragico conto finale delle fucilazioni è di 750 soldati con processi dei tribunali militari e oltre 300 vittime di giustizia sommaria, come approfondiremo in questa trattazione.
Il problema era anche dovuto alla vetustà della normativa militare italiana in vigore nella Prima Guerra Mondiale. Infatti, il codice penale militare risaliva al 15 febbraio 1870 e questo, a sua volta, riproduceva, con solo lievi modifiche, quello dell’esercito sardo dell’ottobre 1859. Dobbiamo le notizie che riportiamo in questo saggio a due libri fondamentali: Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, di Enzo Forcella e Alberto Montico ne[3], e Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale, di Marco Pluviano e Irene Guerrini[4].
«L’edizione del 1914 del codice penale per l’Esercito del Regno d’Italia prevedeva la pena di morte per un’ampia casistica di reati commessi in tempo di guerra, quali lo sbandamento o l’abbandono di posto in combattimento, il tradimento, la diserzione, lo spionaggio, la rivolta, le vie di fatto contro un superiore, l’insubordinazione in faccia al nemico, la mancata consegna o l’abbandono di posto da parte di vedetta o di sentinella di fronte al nemico; la sollevazione di grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o arrendersi; inoltre lo spargimento di notizie, lancio di urla per incutere spavento o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento. La pena capitale era riservata anche ai comandanti, per reati particolarmente gravi, quali ad esempio la resa di una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa e l’abbandono di comando in faccia al nemico»[5].
E l’Italia non era nemmeno la nazione ad avere il codice penale più obsoleto, in quanto, «ad esempio, l’esercito tedesco impiegò nella Grande Guerra il codice penale militare del 20 giugno 1872, mentre quello austro-ungarico risaliva al 1868 (modificato nel 1869 e nel 1873)»[6]. Agli ufficiali era conferito il potere di emanare dei bandi, in base all’articolo 251 del codice penale militare, ai quali tutti dovevano rigidamente attenersi. Tali bandi prevedevano delle norme di comportamento draconiane e delle pene durissime per i trasgressori. Queste pene, poi, data l’ampia facoltà discrezionale dei comminatori, si potevano trasformare in definitive, capitali. Gli inferiori erano tenuti ad ubbidire senza pensare, a dimostrarsi forti, coraggiosi, sprezzanti del pericolo in ogni circostanza.
Si può capire come questi episodi contribuiscano a smontare del tutto i luoghi comuni sulla “guerra gloriosa” che l’enfasi patriottarda ha stratificato per anni nell’immaginario collettivo che sempre si alimenta di esempi edificanti quanto edulcorati. La guerra perde così qualsiasi aura di “guerra giusta”, perde ogni legame con l’aggettivo “grande”, che la pubblicistica le ha cucito addosso, per rivelarsi ai nostri occhi per quello che essa è, cioè guerra, anzi «Guerra! Guerra!», come grida la Norma di Bellini (“guerra, strage, sterminio”), maledetta, come tutte le guerre.
La dura repressione partì da una Circolare del Generale Cadorna che nel maggio 2015 stabiliva: «Il Comando Supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l’esercito una ferrea disciplina». Per mantenerla, era scritto, «si prevenga con oculatezza e si reprima con inflessibile vigore»[7]. Nel settembre di quell’anno, venne emanata un’altra Circolare, col n. 3525, secondo la quale, al verificarsi di atti di «indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte», bisognava rispondere con un immediato intervento di repressione, che prevedeva anche la fucilazione, come giustizia sul campo, sommaria, se i sintomi di tale insubordinazione fossero stati gravi[8]. Si lasciava cioè ai militari superiori, ufficiali e Regi Carabinieri, una enorme discrezionalità nelle decisioni da adottare e, in buona sostanza, il diritto di vita e di morte sui loro sottoposti. Se poi non fosse stato il caso di intervenire immediatamente con la condanna capitale, questi atti di insubordinazione sarebbero stati giudicati dai tribunali militari e ad essi deferiti i soldati che se ne fossero resi colpevoli. «Il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari. Ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi. Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita»: così il testo della Circolare[9].
Facendosi più cruente le fasi della guerra, anche l’autorità statale diventava più stringente e pervasiva; di pari passo con i poteri speciali del Comandante di Stato Maggiore Cadorna, aumentava la severità delle sue disposizioni, mentre veniva quasi esautorato il ruolo del Parlamento. Tutte le funzioni ricaddero progressivamente nella competenza dei tribunali militari e le pratiche autoritarie imposte dalla legislazione di guerra si facevano aberranti. «Al culmine dello sforzo bellico funzionavano complessivamente 117 tribunali militari in Zona di Guerra, marittimi, nel Paese e in Colonia»[10]. Tutto ciò, oltre ad indebolire lo stato democratico, «era funzionale alle sempre più forti pulsioni autoritarie che percorrevano la nazione. Queste, sostenute da larga parte della stampa e in particolare dal Corriere della Sera trovavano nel Generale Cadorna uno dei punti di riferimento più autorevoli»[11]. E non solo gli ufficiali che dovevano mantenere la disciplina venivano costretti ad essere inflessibili con i loro sottoposti, ma anche i giudici dei tribunali militari erano continuamente richiamati ad una maggiore severità nella comminazione delle condanne; il Generale Cadorna riteneva che molti di essi fossero troppo teneri e che la procedura concedesse troppe garanzie ai processati[12]. Al tempo stesso, se gli atti di insubordinazione si erano resi così frequenti, Cadorna era convinto che ciò fosse dipeso proprio dalla debolezza degli ufficiali superiori e poi dei giudici e propose di istituire un maggior numero di tribunali militari con una distribuzione capillare sul territorio, sicché essi, come si può capire, finirono con l’avocare a sé anche le competenze di quelli civili. In pratica, nulla di minimamente rilevante, sia civilmente che penalmente, in Italia, soprattutto nelle zone di guerra, poteva sfuggire alla giustizia militare[13]. Per l’effetto contrario di ogni inasprimento legislativo, però, i reati che si volevano colpire aumentavano. «Dall’analisi di Giorgio Mortara sull’operato della giustizia militare risultò che i reati più frequenti furono: diserzione volontaria per 162.563 casi, indisciplina per 24.601, cupidigia per 16.522, mutilazione volontaria per 15.636, resa o sbandamento per 5.325 e violenza per 3.510»[14].
Anche Bruna Bianchi, nel suo libro La follia e la guerra, riporta i dati dell’Ufficio Statistico del Ministero della Guerra pubblicati da Giorgio Mortara nel 1927, dai quali si evince che «le denunce per renitenza dal 24 maggio 1915 al 2 settembre 1919 furono 470.000 (di cui 370.000 italiani residenti all’estero); le denunce per diserzione furono 189.425», ma indica che «nell’arco del conflitto si conclusero 162.563 processi e furono emesse 101.685 condanne»[15].
Leggere la pubblicistica sulla materia ci fa capire come ai concetti alla base dei reati sopradetti fosse data dai tribunali militari una interpretazione estensiva, su sollecitazione del Generale Cadorna, in modo da colpire quanti più soldati possibile.
Pluviano e Guerrini spiegano come, fra le carte d’archivio, sia avvenuto il fortunoso ritrovamento della Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la Prima Guerra Mondiale, redatta nel 1919 dall’Avvocato Generale Militare Donato Antonio Tommasi, sulla quale torneremo. Questa relazione, insieme agli Allegati, ritrovati da Giorgio Rochat (che firma la Prefazione del loro libro) il quale li ha messi a disposizione, hanno costituito la base del volume[16]. Nel mentre gli autori proseguivano nell’indefesso lavoro di ricerca negli archivi, essi hanno presentato una prima ricognizione del loro studio nella relazione Il memoriale Tommasi. Decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la Grande Guerra[17]. Prima di questi lavori, le cifre sui fucilati di guerra erano piuttosto vaghe, certamente discordanti. Gli studiosi si barcamenavano fra le cifre fornite dalla politica che indicavano le vittime della giustizia sommaria in poche centinaia e quelle fornite dal giornale socialista «L’Avanti» che parlava di più di 1000 morti. Pluviano e Guerrini si sono invece basati sulla Relazione del Generale Tommasi, integrandola con le risultanze della istituita Commissione d’inchiesta parlamentare del 1919[18], e poi con molte altre fonti emerse durante il lavoro di ricerca, fra queste anche le dichiarazioni dei parlamentari durante i lavori della Commissione.
Fra le varie fonti dirette, una delle più accreditate «è la relazione “Dati di statistica giudiziaria militare” del giugno 1925. Si tratta della statistica delle sentenze e dei procedimenti penali dei tribunali militari presso l’esercito operante e di quelli territoriali fuori e dentro la zona di guerra. Secondo questa relazione, furono comminate nel corso del conflitto 4.028 condanne a morte, delle quali 2.967 in contumacia, 311 non eseguite e 750 eseguite. Di queste ultime, 391 riguardarono il reato di diserzione, 5 la mutilazione volontaria, 164 la resa o sbandamento, 154 atti di indisciplina, 2 la cupidigia, 16 per violenza, 1 per reati sessuali, le rimanenti per reati diversi. Un’altra fonte importante ai fini della quantificazione è una tabella del Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo dal titolo “Specchio dei giudizi durante la campagna” datata 24 dicembre 1917 e relativa al periodo giugno 1915 – settembre 1917, conservata presso l’archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Tale tabella è importante perché è l’unica a contenere anche il dato dei giudizi sommari: 112, che coincidono in buona parte con quelli riportati da Forcella e Monticone, fino all’agosto 1917. Nel settembre 1919 il ministro della guerra Generale Albricci, in sede parlamentare, ammise 729 condanne a morte eseguite durante tutta la guerra, mentre “le tristi esecuzioni sommarie superano di poco il centinaio”»[19]. Nel maggio-giugno 1916, a seguito dell’offensiva austro-ungarica, il regime disciplinare fu inasprito con l’ordine di ricorrere alle fucilazioni sommarie con ampia libertà, fino a colpire anche gli ufficiali. Dopo lo sfondamento austro-ungarico della nostra resistenza, il Comando Supremo ordinò al comandante delle truppe operanti sull’altopiano di Asiago di prendere le più energiche ed estreme misure: «faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun procedimento, i colpevoli di così enormi scandali, a qualunque grado appartengano. […] L’altopiano di Asiago va mantenuto a qualunque prezzo. Si deve resistere o morire sul posto»[20]. Inoltre, di fronte «alle diserzioni, che sempre più numerose si manifestavano sia presso i reparti schierati in zona di guerra che all’interno, nel dicembre 1916 il Ministero della guerra decise di togliere il sussidio economico ai famigliari dei colpevoli del grave reato, i cui nomi furono pubblicati nei loro comuni natii»[21]. La pena capitale, specie per i soldati che si erano macchiati del reato più grave, la diserzione, avveniva con fucilazione alla schiena. «Altre norme legislative emanate durante la permanenza di Cadorna alla carica di capo di Stato Maggiore dell’Esercito furono il bando del 28 luglio 1915 del Comando Supremo contro la diffusione di notizie sulla guerra e la denigrazione dell’esercito o della guerra stessa ed il decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1916 n. 1417 per la repressione dell’autolesionismo»[22].
Di fronte al numero spropositato di esecuzioni, si avvertì l’esigenza di istituire una commissione interna che vagliasse le tante condanne comminate ed i metodi usati nella spregiudicata gestione Cadorna. Questa commissione venne affidata all’Avvocato Generale dello Stato Donato Tommasi, sul modello della già costituita “Commissione d’inchiesta sugli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento al Piave”, comunemente definita “Commissione d’inchiesta su Caporetto”, di nomina regia, istituita nel 1918, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che era nata in seguito all’ondata di paura e malcontento generatasi dopo la clamorosa sconfitta di Caporetto[23]. Già dalla Commissione d’inchiesta «il ricorso alla decimazione[24] fu stigmatizzato … e definito “provvedimento selvaggio, che nulla può giustificare” tra l’altro per via della pena di morte così ingiustamente comminata a numerosi innocenti»[25].
Il Generale Tommasi[26] stilò una Relazione, in base alla quale i fatti vennero così suddivisi: Esecuzioni sommarie che appaiono giustificate; esecuzioni sommarie che appaiono ingiustificate; esecuzioni sommarie per le quali l’azione penale è improcedibile; esecuzioni sommarie per le quali manca nei rapporti ogni elemento di giudizio[27]. Dei vari tipi, riportiamo alcuni esempi.
Per le esecuzioni sommarie giustificate: Brigata Messina, 93°reggimento, 30 giugno 1915, numero imprecisato di vittime, diserzione in complotto al nemico; Brigata Verona, 85° reggimento, 31 ottobre 1915. 1 fucilato. Abbandono del posto in faccia al nemico; Brigata Acqui, 18° reggimento, 22 aprile 1916. 3 fucilati, rivolta; Brigata Ancona, 69° reggimento, 13 giugno 1916. 3 fucilati. Sbandamento e mancata possibile difesa: Brigata Pavia, 27° reggimento, 11 novembre 1916. 1 fucilato. Insubordinazione e omicidio; Brigata Verona, 85° reggimento, 6 agosto 1916. 1 fucilato. Abbandono del posto e rifiuto di obbedienza in presenza del nemico: Brigata Catanzaro, 141° e 142° reggimento, 16 luglio 1917, 28 fucilati, rivolta. Per le esecuzioni sommarie ingiustificate: Brigata Ravenna, 38° reggimento, 21- 22 marzo 1917, 7 fucilati, rivolta. Per le esecuzioni sommarie per le quali l’azione penale è improcedibile: Brigata Salerno, 89° reggimento, 2 luglio 1916, numero imprecisato di morti. Diserzione al nemico, 3 luglio 1916, 8 fucilati, istigazione alla diserzione. Per le esecuzioni sommarie per le quali manca ogni elemento di giudizio nei rapporti e documenti esaminati: Brigata Catanzaro, 141°reggimento, 27 maggio 1916, Altipiano d’Asiago, 12 fucilati, sbandamento di fronte al nemico; Brigata Lazio, 131° reggimento, 15 giugno 1916, basso Isonzo, 1 fucilato, minacce e vie di fatto o rifiuto di obbedienza; 14° reggimento Bersaglieri, XL battaglione,16 giugno 1916, Altipiano d’Asiago, 4 fucilati, sbandamento; 5° reggimento Genio, 31°compagnia minatori, 26 luglio 1916, luogo imprecisato, 1 fucilato, vie di fatto a mano armata contro superiore; XLVII battaglione Bersaglieri, 5 agosto 1916, quota 85 Monfalcone, 3 fucilati, diserzione; Brigata Regina, 9° e 10° reggimento, 13 maggio 1917, vallone di Doberdò, 6 fucilazioni non confermate, diserzione; Brigata Toscana, 77° reggimento, 23 giugno 1917, retrovie di Monfalcone, 2 fucilati, rivolta. Alla fine, “caddero vittime della giustizia sommaria 262.481 soldati e di essi 170.064, cioè il 62%, subirono una condanna. Furono comminati 15.345 ergastoli, dei quali 15.096 per diserzione. Le percentuali sono impressionanti: il 6% dei mobilitati fu rinviato a giudizio e quasi il 4% subì una condanna penale. Dei 262.481 processati, 177.648 passarono dai tribunali dell’esercito operante, mentre gli altri 84.883 furono giudicati dai tribunali territoriali. Sebbene i primi fossero più severi (ritennero colpevole il 66,3% dei processati), anche i tribunali territoriali condannarono il 61,8% dei giudicati”[28].
Fra le vittime della giustizia sommaria, anche un soldato salentino. E veniamo così all’oggetto della nostra trattazione.
Rocco Gnoni, questo il suo nome, era nato a Torrepaduli, frazione di Ruffano, il 6 agosto 1888. Figlio di contadini, Rocco aveva sposato una sua compaesana di nome Giovanna Crudo; il matrimonio fu celebrato l’11 gennaio 1915. Pochi mesi dopo, il 29 maggio 1915, Rocco partì per la guerra, come riportato sul suo foglio matricolare n.31904. Dal foglio matricolare apprendiamo che Rocco Gnoni, di professione contadino, già ritenuto «rivedibile» a causa della «debole costituzione fisica», viene poi arruolato nell’11 Compagnia di Sanità (44° Divisione Sanità) e viene considerato «disperso nel fatto d’armi dell’ottobre 1917»[29].
Dopo quasi due anni di servizio al fronte, Rocco ottenne con ogni probabilità una licenza, durante la quale lui e sua moglie concepirono l’unico figlio, Donato, che venne alla luce il 19 novembre 1917. Gnoni però non poté mai conoscere il bambino, perché morì pochi giorni prima della sua nascita.
Pluviano-Guerrini riportano nel Capitolo «La Relazione Tommasi. Esecuzioni sommarie per le quali manca ogni elemento di giudizio nei rapporti e documenti esaminati»[30], un corpus molto più consistente di esempi. Fra questi, oltre a quelli sopra elencati: Brigata Ivrea, 162° reggimento, 21 febbraio 1917. 2 fucilati. Diserzione; Brigata Palermo, battaglione complementare, 20 maggio 1917. 3 fucilati. Rivolta; e poi 44° sezione di sanità, 4 novembre 1917. 1 fucilato. Accusa sconosciuta. Quest’ultima è quella che a noi interessa, perché il soldato fucilato per motivi sconosciuti è Rocco Gnoni, «un ventinovenne nato a Ruffano, provincia di Lecce. L’ordine di fucilazione fu impartito dal comando della 2°armata il 3 novembre 1917, mentre la ritirata era ancora in corso. L’esecuzione sommaria avvenne presso il Cimitero di Porcia, nel Pordenonese, alle 6.15 del 4 novembre 1917, quando i reparti italiani si apprestavano ad abbandonare la zona. Il plotone di esecuzione era composto da dodici carabinieri della 128° sezione, addetta al comando della 2° armata. La scheda compilata da Tommasi e i documenti allegati non riportano la ragione della condanna, e questo è un fatto di particolare gravità perché la fucilazione avvenne per ordine di un comando d’armata»[31]. Gli autori inoltre riportano in nota che nell’Allegato 40 sono contenute «la lettera di trasmissione del comandante dei carabinieri dell’armata al comando della 2°armata, il processo verbale dell’esecuzione sommaria, a firma del tenente dei carabinieri Nicola Crocesi, comandante del plotone di esecuzione, e l’atto di morte del soldato Gnoni, redatto dal capitano medico Ario Airaghi, sempre il 4 novembre 1917»[32]. Si apre allora una incongruenza nella ricostruzione della vita di Gnoni. L’Albo d’Oro dei caduti della Grande Guerra, infatti, dice di lui che fu disperso in battaglia il 30 ottobre, «nel ripiegamento al Piave», dopo la tragica sconfitta di Caporetto[33]. E anche il foglio matricolare, come già detto, annota «disperso» e «rilasciata dichiarazione di irreperibilità»[34]. Come tale viene ricordato nella targa commemorativa del Monumento ai Caduti del suo paese, la piccola frazione di Torrepaduli. In realtà, egli fu fucilato, come dimostrano inconfutabilmente Pluviano e Guerrini sulla base dei documenti ufficiali. Fu vittima della repressione interna, uno di quei capri espiatori, di cui si diceva all’inizio.
La storia ci insegna che la guerra, come evento straordinario, che sconvolge cioè il regolare procedere del tempo ordinario, frange prassi, codici, norme di comportamento e garanzie. Ogni guerra porta esecuzioni sommarie, decimazioni, pene di morte, e non solo scombina le regole del vivere civile ma sovente calpesta la stessa etica militare. La Prima Guerra Mondiale non fa eccezione: questa fu la grande delusione che già nel 1916 si impossessò dei ragazzi che con entusiasmo e fiducia erano partiti per il fronte. Nihil novi sub sole è il motto tragicamente fatalistico che si potrebbe trarre. E non meno che appropriato ci appare l’aggettivo fatalistico, se pensiamo che ad una vera e propria roulette russa era affidata la vita di questi soldati, nelle parole del Generale Cadorna: «non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l’accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte»[35].
Subito dopo la guerra, ci fu molta confusione sul numero esatto delle vittime di esecuzioni sommarie. Questo numero oscillava fra 109, indicato dall’On. Vito Luciano alla Camera dei Deputati il 19 settembre 1919[36], 152, il numero avanzato dall’Avvocatura generale militare, e più di 1000, come sosteneva il giornale del Partito Socialista «L’Avanti». Come già detto, Pluviano e Guerrini, utilizzando le due fonti di segno opposto, ossia quella ufficiale della Relazione sulle esecuzioni sommarie del Generale Tommasi e quella non ufficiale e antimilitarista dell’Avanti, integrandole con i tanti documenti rinvenuti nell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (USSME) e dalla memorialistica e dai resoconti di guerra, hanno calcolato questo numero in 750 fucilati[37].
Dopo il conflitto, la Relazione del Generale Tommasi restava la fonte più credibile sui fucilati di guerra, anche se il numero che presenta è in difetto e tende a colpevolizzare esclusivamente il Generale Cadorna facendo credere che col Generale Diaz la situazione fosse cambiata e le esecuzioni del tutto cessate (è invece dimostrato che vi fossero ancora dei casi), ma queste erano le pressioni che Tommasi aveva ricevuto dall’alto. In effetti, il Generale Cadorna nel frattempo era stato sostituito da Diaz.
Tuttavia, il destino della Commissione fu di essere insabbiata, analogamente a quella su Caporetto. Le sue risultanze vennero dimenticate e nessuno degli ufficiali colpevoli fu processato per i delitti commessi.
La linea del Parlamento italiano divenne quella di elogiare e ringraziare l’esercito e i suoi vertici per l’alto eroismo (dando avvio alla magniloquenza propagandistica che caratterizzerà tutto il dopoguerra fascista) e sostanzialmente perdonare i responsabili della carneficina, considerando quanto avvenuto come un male necessario, nonostante l’unica voce dissonante in Parlamento, quella del Partito Socialista, si alzasse contro simile conclusione. Di conseguenza, siffatti crimini contro l’umanità rimasero impuniti e un velo di oblio cadde sulla triste vicenda fino quasi ai giorni nostri[38]. Bisognerà attendere la pubblicazione dei libri di Forcella e Monticone del 1968[39] e di Procacci del 1993[40], basati sull’inchiesta del Generale Tommasi del 1919 fino ad allora segretata, per avere chiarezza. Queste ricerche hanno permesso anche di venire a conoscenza della vera fine del soldato Rocco Gnoni.
Nel 2016 è stato anche organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Ruffano un incontro dal titolo “I fucilati per mano amica nella Grande Guerra: verità e riabilitazione. La storia del soldato ruffanese Rocco Gnoni”. Gli organizzatori di quell’incontro, in primis il prof. Roberto Molentino, referente del progetto “Cento anni fa… la Grande Guerra”, ed i docenti coinvolti, hanno voluto far luce sulle vere cause della morte di questo concittadino. Hanno ricercato il Verbale di esecuzione sommaria del soldato Gnoni Rocco, dal quale risulta che «detto militare venne fucilato il 3 novembre 1917 in Porcia per ordine del Comando della 2° Armata. Non vi è alcun accenno ai fatti che determinarono detto giudizio sommario e pertanto occorrerebbero nuove indagini per poter esaminare se l’ordine del detto Comando fu conforme alla legge». La fucilazione dunque avvenne nei pressi del cimitero di Porcia, paesino in provincia di Pordenone. «Al soldato Rocco Gnoni furono sparati in due riprese complessivamente 12 colpi di moschetto M.1891, che lo resero all’istante cadavere»[41]. Sempre secondo il verbale, il cadavere del soldato fu seppellito all’interno del Cimitero di Porcia.
Per saperne di più, gli studenti del progetto scolastico coordinati da Molentino hanno intervistato il nipote del soldato, Gino Gnoni, il quale ha detto di essere a conoscenza del fatto, anche se non in grado di provarlo.
Gino ha sostenuto che suo padre, Donato, non voleva ricordare e non parlava mai di ciò che era accaduto a Rocco, anche se provò per tutta la vita sentimenti ostili nei confronti dell’arma dei Carabinieri[42]. Nonna Giovanna, vedova di Rocco, raccontava invece che un reduce le aveva riferito quanto accaduto al marito: sembra che mentre si trovava in un’osteria a rifocillarsi dopo le dure battaglie delle settimane precedenti, fosse stato redarguito da un superiore a cui, forse, rispose in modo irrispettoso. Questo segnò il suo destino.
Quanto scoperto trova un riscontro anche nel libro Nel vortice della grande guerra. Porcia nell’anno dell’invasione di Sergio Bigatton e Angelo Tonizzo, pubblicato dal Comune di Porcia nel 2010[43]. Il volume, incentrato sulla partecipazione della cittadina del Pordenonese alla Prima Guerra Mondiale, riporta nella seconda parte il Discorso pronunciato dal generale Umberto Pastore a Palse per l’inaugurazione del mausoleo ai Caduti in guerra, l’opera di don Francesco Cum Le memorie di un parroco dell’anno dell’invasione, e gli scritti di Antonio Forniz La prima guerra mondiale nei piccoli ricordi di un friulano adolescente. Sono riprodotti inoltre alcuni passi del diario del pittore futurista e scrittore Ardengo Soffici, scritti dal Castello di Porcia, dove soggiornò durante la ritirata di Caporetto. Infine, alcune memorie di Pietro Masutti e di Luigi Del Ben. In Appendice, sono riportati i nomi dei caduti di Porcia. Fra questi caduti non figura Rocco Gnoni, ma gli autori riferiscono un episodio che a Porcia era ben conosciuto e che ci fa chiaramente pensare al Nostro. Parlano della storia-leggenda di un povero soldato giustiziato di cui a Porcia girava insistente la voce, un «soldato italiano fucilato dai suoi al cimitero di Porcia durante la ritirata», individuato dagli autori grazie al ritrovamento di una planimetria del cimitero dove, fra i morti sepolti, viene ricordato anche un «Italiano fucilato»[44]. Ne parla con un fugace cenno il religioso Don Francesco Cum nel suo discorso (stampato a Udine nel 1920), che gli autori riportano nella seconda parte del libro[45]. Uno degli autori, Sergio Bigatton, contattato dagli organizzatori della manifestazione ruffanese, ha affermato che il soldato cui si accenna nel libro è senz’altro Rocco Gnoni. A maggior conferma, l’episodio dell’uccisione di Gnoni si potrebbe ricavare da un’altra fonte, che è il libro di Ardengo Soffici, La ritirata del Friuli. Note di un ufficiale della Seconda Armata[46], in cui il pittore e poeta futurista narra la sua esperienza nella prima guerra mondiale. Nella notte fra il 3 e il 4 novembre, scrive che, mentre era uscito con alcuni compagni a fare due passi nel paese, nel buio più fitto, avvertì dei rumori nei pressi del cimitero e fu attirato dalla luce di una lanterna. Incontrò alcuni uomini, dei carabinieri, e ai loro piedi un uomo morto, che Soffici ed i compagni scambiarono per una donna, in quanto l’uomo era acconciato in abiti femminili, probabilmente per sfuggire ai suoi assalitori. I carabinieri riferirono a Soffici e compagni che il loro superiore aveva ordinato di ammazzare sul posto quell’uomo, e loro avevano eseguito immantinente l’ordine, fucilando il malcapitato. Si trattava di una punizione esemplare. Anche se Soffici non fa il nome di Gnoni, è facile supporre che si tratti di lui[47].
Non sorprenderebbe che il soldato ruffanese si trovasse in un’osteria a sbronzarsi. Il vino e la prostituzione erano fin dall’inizio della guerra i soli due svaghi consentiti ai soldati nella terribilità del momento. Si trattava di svaghi autorizzati o meglio “istituzionalizzati” dalle autorità[48]. Il vino in trincea era un farmaco potentissimo, ne parla anche Emilio Lussu in Un anno sull’altopiano[49]. Utilizzato in quantità massicce dai soldati per fare fronte alla drammaticità della situazione, esso dava loro sollievo, potenziandone l’audacia e la bellicosità in alcuni casi, fungendo da oppiaceo e quindi anestetizzando la paura e il dolore in altri. Comunque, sia che lo usassero come coadiuvante per darsi forza e coraggio, sia come tranquillante per attutire nei fumi dell’alcol lo shock di un impatto emotivo devastante, tutti i soldati ne diventavano dipendenti. Tanto vero che anche nelle cosiddette Case del soldato[50], circoli ricreativi religiosi, creati dalla chiesa per contrastare le case di tolleranza (e fu una battaglia persa fin dall’inizio di fronte al proliferare delle case chiuse e al massiccio ricorso dei militari al sesso a pagamento), i soldati bevevano[51]. Anzi, una delle voci di spesa più alte negli acquisti delle Case del soldato era proprio quella per il vino, poiché i preti ritenevano che un consumo, sia pure moderato, della bevanda alcolica dovesse comunque essere permesso, anche per contrastare il ricorso alla prostituzione: come dire, si sceglieva il male minore[52]. Mons. Giuseppe Pellizzo, Vescovo di Padova, in una lettera affermava che avevano come unico pensiero quello di svuotare le cantine nei paesi abbandonati ed erano talmente attaccati alla bottiglia che se le montagne fossero state damigiane i soldati le avrebbero custodite meglio, essendo sempre aggrappati ad esse[53]. Questo scritto è anche più importante per quanto il prelato sostiene dopo[54], cioè che proprio a causa dell’ubriachezza, alcuni giorni prima un battaglione aveva rifiutato di andare avanti ed era stata sorteggiata una compagnia e decimata. Importante dappiù, questa lettera di Mons. Pellizzo, per la data in cui viene inviata, ossia il 31 maggio 1916, in un periodo in cui nessuno dei soldati dal fronte osava confessare tale pratica aberrante. L’alcol, dunque, veniva largamente usato nelle trincee e finanche incoraggiato dal Comando supremo. Esso costituiva proprio la benzina dei soldati, come dice Emilio Lussu.Ma poi, fuori dalle trincee, per somma incoerenza, specie con la gestione Cadorna, esso veniva proscritto, quasi demonizzato nelle Circolari del Generale che imponevano ai soldati, negli ambienti civili, assoluta sobrietà ed un severo contegno in ogni circostanza. Gnoni pagò con la vita la sua mancanza di contegno.
Nel 2015, gli Onorevoli Giorgio Zanin e Gian Piero Scanu hanno voluto proporre una legge sulla riabilitazione di questi caduti della prima guerra mondiale. In effetti, nel 2014, nell’ambito delle celebrazioni in occasione del centenario della Grande Guerra, si segnalava l’iniziativa di un gruppo di 50 intellettuali che inviavano un appello al Presidente della Repubblica per la riabilitazione dei soldati fucilati. Essi si costituirono in un Comitato nell’ambito del Ministero della Difesa. All’iniziativa di questo Comitato si unirono i deputati Gian Piero Scanu e Giorgio Zanin, rispettivamente primo firmatario e relatore alla Camera dei Deputati della proposta di legge n. 2741 finalizzata «ad attivare il procedimento per la riabilitazione dei soldati italiani condannati alla pena capitale nel triennio 1915-18, nonché per restituire l’onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le armi senza processo con la brutale pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori. Verrà così restituito l’onore militare e la dignità di vittime della guerra a quanti vennero fucilati. Infatti, una volta approvata la legge verranno inseriti nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze I caduti»[55]. Giorgio Zanin venne anche invitato a Ruffano nel già citato Convegno del 2016 e in quell’occasione si è soffermato su questa triste vicenda e ha sottolineato l’alto dovere morale e civile di riaprire una delle pagine più nere della storia d’Italia.
Nella maggior parte dei casi, i sospetti e le accuse di delazione, spionaggio, intelligenza col nemico, diserzione, di cui erano fatti oggetto taluni soldati, rimasero tali, solo frutto di menti paranoiche o soggiogate. Le fucilazioni che ne seguirono furono invece reali, come molta memorialistica conferma e certa stampa dell’epoca andava denunciando. Soprattutto nelle interviste ai reduci, nelle testimonianze orali e in tanti diari pubblicati dopo la guerra, molto vivi e brucianti i ricordi delle esecuzioni sommarie[56]. Non così invece nelle lettere, quelle inviate dal fronte, che erano sottoposte a censura[57].
Alle esecuzioni dei militari, bisogna aggiungere quelle dei civili. Le fonti dimostrano che fin dai primi giorni del conflitto il nostro esercito si macchiò di vari delitti perpetrati a danno delle popolazioni di confine, uccidendo tantissimi abitanti dei territori occupati, con esecuzioni sommarie[58].
Una certa pubblicistica antimilitarista sostiene senza indugio che i veri eroi furono proprio questi, i disertori, i ribelli, i fuoriusciti. Questa pubblicistica porta a sostegno della propria posizione un abolito articolo della Costituzione, per l’esattezza l’articolo 50, poi divenuto articolo 54 che, al secondo comma, poi cassato, recitava: «Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino»[59]. Ma al di là delle posizioni di un certo pacifismo radicale, tutto l’orientamento dell’opinione pubblica in questi ultimi anni in Italia è stato quello di riabilitare non solo i fucilati di guerra ma anche i renitenti e i disertori, considerati anch’essi vittime della sofferenza procurata dalla guerra. Un articolo pubblicato su «La Repubblica» nel 2014 dà voce al Vescovo Santo Marcianò, Ordinario Militare, il quale parla delle diserzioni come di «un fenomeno che coinvolse tutte le forze in campo, alimentato non tanto dalla paura quanto dalla nostalgia per la famiglia e odio per l’ingiustizia delle autorità militari. Le condanne furono circa centomila. Impossibile sapere con esattezza i fucilati, almeno un migliaio»[60].
Come non vedere, in questi soldati ingiustamente massacrati, come Rocco Gnoni di Ruffano, dei martiri laici? Eroi minori di una beffarda tragicommedia.
Per concludere con le parole di Ardengo Soffici: «sono forse costoro dei vinti, dei disertori, dei rivoltosi, dei traditori? O sono, diciamo la parola, dei vigliacchi? No. Basta vederli. Basta lasciare entrare la loro anima nella nostra. Sono delle vittime. Sono degli incoscienti. Sono degli illusi – e il male non è qui. … il male è nelle radici – il male è laggiù sotto di noi: nell’ignominia di chi divide, di chi baratta, di chi mente, di chi mercanteggia. Di chi abbandona. Il male è dappertutto; ma non è qui. Qui si soffre soltanto. Non è la via dell’infamia, qui. È la via della croce»[61].
* Società di Storia Patria per la Puglia, [email protected]
Vivamente ringrazio gli amici Francesco Frisullo, che per primo ha fatto luce sulla storia del soldato Rocco Gnoni, e Roberto Molentino, che mi ha messo a disposizione alcune fonti documentarie.
Note
[1] R. Girard, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980.
[2] R. Caillois, L’uomo e il sacro, Torino, Bollati-Boringhieri, 2001.
[3] E. Forcella – A. Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Bari, Laterza,1968, 2° ed. , 2014.
[4] M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale, Udine, Gaspari, 2004, p.12.
[5] F. Cappellano, Cadorna e le fucilazioni nell’esercito italiano (1915-1917), p.1, in www.museodellaguerra.it/wp-content/…/09/annali_23_Cadorna-e-le-fucilazioni.pdf. L’autore si rifà al libro di Forcella e Monticone, Plotone di esecuzione cit.
[6] Ivi, p.36.
[7] Circolare n. 1 Disciplina di Guerra in data 24 maggio 1915, conservato presso l’archivio dell’USSME (Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito), repertorio L3, b. 141, fasc. 3, riportato in M. Pluviano e I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., p.36.
[8] Circolare n. 3525 in data 28 settembre 1915, Disciplina di guerra, USSME, Ivi, p.36.
[9] Ibidem.
[10] Ivi, p.14.
[11] Ivi, p.15.
[12] Ivi, p.20.
[13] Ivi, p.21.
[14] Ivi, p.23.
[15] Ministero della Guerra, Ufficio Statistico, Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale. Dati sulla giustizia e disciplina militare, a cura di G. Mortara, Roma, 1927, in B. Bianchi, La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza nell’esercito italiano 1915-1918, Roma, Bulzoni, 2001,
[16] Ivi, pp.1-6. Sulla copertina del libro è raffigurata un’immagine tratta dal film di Francesco Rosi Uomini contro, del 1970, ispirato al romanzo di Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano.
[17] Letta al convegno “Scampare la guerra”, tenuto a Fogliano Redipuglia nel 1990. Questa relazione è poi confluita nel libro con cui si pubblicarono gli atti: 1914-1918 scampare la guerra : renitenza, autolesionismo, comportamenti individuali e collettivi di fuga e la giustizia militare nella Grande Guerra, a cura di L. Fabi, Ronchi dei Legionari, Centro culturale pubblico polivalente, 1994, pp.63-75. Guerrini – Pluviano sono anche autori di La giustizia militare, in Dizionario storico della Prima Guerra Mondiale, a cura di N. Labanca, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 137-146.
[18] Commissione d’inchiesta Dall’Isonzo al Piave. 24 ottobre-9 novembre 1917, Roma, Stabilimenti tipografici per l’amministrazione della guerra, 1919. Istituita con R.D.12 gennaio 1918, n.35.
[19] Atti parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura XXIV, 1ª sessione, discussioni, tornata del 12 settembre 1919, in F. Cappellano, Cadorna e le fucilazioni nell’esercito italiano cit., p.12.
[20] Lettera in data 26 maggio 1916 del capo di Stato Maggiore dell’Esercito al Generale Clemente Lequio – USSME, in Filippo Cappellano, op. cit., p.6.
[21] Circolare n. 32800 in data 28 dicembre 1916, Conseguenze del reato di diserzione, Comando 3ª Armata. Altre conseguenze di legge del reato di diserzione erano: interdizione perpetua dei pubblici uffici, interdizione legale con la perdita di amministrazione dei propri beni, patria podestà, autorità maritale e capacità di fare testamento: fonte USSME, in F. Cappellano, op. cit., p.7.
[22] Ivi, p.11.
[23] M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., p.41.
[24] La decimazione, che consisteva nel tirare a sorte il nome dei fucilati,come esempio di estrema disciplina militare inflitta ai soldati era una pratica già conosciuta dai Romani ma fu nella Prima Guerra Mondiale che se ne fece largo uso.
[25] Relazione della Commissione d’inchiesta, Dall’Isonzo al Piave 24 ottobre – 9 novembre 1917, vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti, 1919, in F. Cappellano, op. cit., p.7.
[26] Il giurista Donato Antonio Tommasi (1867-1949), tarantino di nascita, era leccese. Stimato magistrato, durante la guerra ricoprì il ruolo di Avvocato Generale presso il Tribunale supremo di Guerra e di Marina e poi dell’Esercito. Fu parlamentare, eletto nelle file del Partito Popolare, negli anni Venti. Strenuo oppositore del Fascismo, in occasione della Marcia su Roma, redasse il decreto per lo stato d’assedio per conto del Presidente del Consiglio Luigi Facta che venne respinto dal Re Vittorio Emanuele III. Per questo, fu ostracizzato dal regime. Partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e venne ferito dallo scoppio di una bomba lanciata sul centro militare clandestino che dirigeva a Roma, e fu onorato della medaglia d’argento al valor militare: M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., p.48.
[27] Ivi, Le fucilazioni sommarie cit., p.47.
[28] Ivi, p.19.
[29]Archivio di Stato di Lecce, Vol. 194, Ruoli matricolari soldati appartenenti alla classe 1890.
[30] M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., pp.113-130.
[31] Ivi,p.125.
[32]Ivi, p.129.
[33] Albo d’Oro, Volume XVIII, Puglie, N. 902. Nell’Albo d’Oro, giusta circolare del Ministero della Guerra, 8 giugno 1926, sono inclusi tutti i militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Guardia di Finanza, il cui decesso o scomparsa sia avvenuta per causa di guerra dal 24 maggio 1915 al 20 ottobre 1920, data di pubblicazione della pace.
[34] Archivio di Stato di Lecce Vol. 194, Ruoli matricolari soldati appartenenti alla classe 1890. La dichiarazione di irreperibilità veniva rilasciata dal CIFAG (Centro interministeriale per la formazione degli atti giuridici) di Roma, ora soppresso.
[35] Telegramma circolare nr. 2910 del 1 novembre 1916 del Comando Supremo, in Filippo Cappellano, op.cit., p.7.
[36] M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., p.2.
[37] Ivi, pp.2-3.
[38] Ivi,pp.5-6.
[39] E. Forcella- A. Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Bari, Laterza, 1968 (poi 2014).
[40] G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, Roma, Editori Riuniti, 1993. Sulle punizioni esemplari e le fucilazioni anche: A. Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, Milano, Mondadori, 2014, p. 24.
[41] Si veda il Verbale della fucilazione allegato.
[42] Sul ruolo dei Regi Carabinieri: F. Angeletti, Il ruolo dell’arma dei carabinieri durante il primo conflitto mondiale: il fronte interno, in «Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali», a. IV, n. 2, 2015, pp.371-386.
[43] Nel vortice della grande guerra. Porcia nell’anno dell’invasione. Documenti e memorie sulla prima Guerra mondiale, a cura di S. Bigatton e A. Tonizzo, Pordenone, Sage Print, 2010.
[44] Ivi, pp.39-40.
[45] Ivi, pp.81-107.
[46] A. Soffici, La ritirata del Friuli. Note di un ufficiale della Seconda Armata, Firenze, Vallecchi, 1919.
[47]Ivi, pp.192-193.
[48] Sulle case di tolleranza, si veda E. Franzina, I casini di guerra, Udine, Gaspari, 1999.
[49] E. Lussu, Un anno sull’altopiano,Torino, Einaudi, 1964.
[50] Don G. Minozzi, Ricordi di guerra, Amatrice, Vol. I, 1956.
[51] E. Franzina, I casini di guerra cit., p. 192. Sull’argomento, anche P. Vincenti, Tra vergogna e onore: le prostitute di guerra, in L’officina del sentimento. Voci gesti segni femminili in Terra d’Otranto davanti alla Grande Guerra (1915-1924), a cura di G. Caramuscio, in corso di stampa.
[52] M. Pluviano, Le case del soldato, in «Notiziario dell’Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia», n.36, dicembre 1989, pp.5-88.
[53]I vescovi veneti e la Santa Sede nella guerra 1915-1918, a cura di A. Sciottà, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1991, p.73. Mons. Pellizzo, fondatore del giornale cattolico «La difesa del popolo», scrive tra il 1915 e il 1918 ben centocinquantasei lettere a Papa Benedetto XV per informarlo sul drammatico andamento della prima guerra mondiale.
[54] Pubblicato da I. Guerrini – M. Pluviano, in Il memoriale Tommasi. Decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la grande guerra, in 1914-1918 scampare la guerra cit., pp.63-75.
[55] Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la Prima guerra mondiale https://www.camera.it › leg18
[56] M. Pluviano – I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie cit., p. 239.
[57]Ivi, p. 240. Le lettere dal fronte avevano degli speciali censori che erano spesso gli ufficiali austriaci e tedeschi, incaricati di leggerle, allo scopo di emendarle da eventuali informazioni poco opportune e pericolose. Fra questi ufficiali, Leo Spitzer, il filologo austriaco al quale si deve il primo studio organico di carattere linguistico sulle lettere dei soldati dal fronte. Leo Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani: 1915–1918, a cura di L. Renzi, Torino 1976, nuova ed., Milano 2016. Si veda anche D. Octavian Cepraga, Scritture contadine e censori d’eccezione: le lettere versificate dei soldati romeni della Grande Guerra, in Memorialistica e letteratura della Grande Guerra. Parallelismi e dissonanze Atti del Convegno di studi italo-romeno Padova–Venezia, 8–9 ottobre 2015,a cura di D. Octavian Cepraga, R. Dinu e A. Firţa, Quaderni della Casa Romena di Venezia, XI-2016, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 2016, p.189.
[58] Ivi, pp. 196 -197.
[59] https://www.nascitacostituzione.it/02p1/04t4/054/art054-011.htm
[60] P. Gallori, Grande guerra, l’ordinario Militare: “Riabilitare i disertori come Caduti”, in «La Repubblica», 6 novembre 2014
[61] A. Soffici, op. cit.,p.202.
Ringrazio gli amici Francesco Frisullo, che per primo ha fatto luce sulla storia del soldato Rocco Gnoni, e Roberto Molentino che ha messo a disposizione alcune fonti documentarie.
#fucilazioni sommarie#Paolo Vincenti#prima guerra mondiale#Rocco Gnoni#Miscellanea#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine
1 note
·
View note
Photo
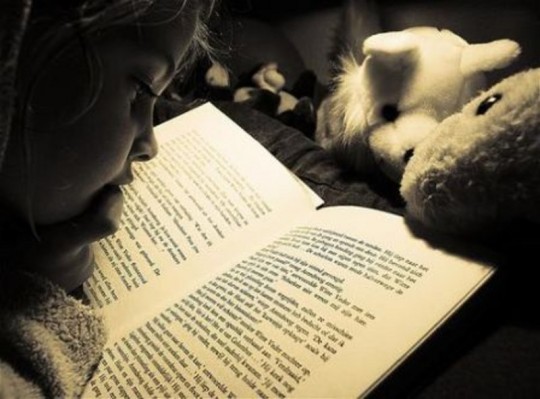
Nuovo post su https://is.gd/Sh0bDV
Quando i concorsi di poesia erano una cosa seria e non un affare
di Armando Polito
Non bastavano i maghi e gli indovini ad approfittare della credulità popolare ed ecco farsi avanti persuasori più sofisticati a sfruttare il narcisismo di persone che, consapevoli di non potersi collocare nella categoria dei santi e dei navigatori, presumono di essere poeti. In fondo cosa costa mettersi in gioco quando la posta potrebbe essere la celebrità e il costo corrisponde solo alla cifra, non certo astronomica, richiesta per partecipare? E cosa costa comporre una commissione di sedicenti esperti che, bene che vada, sono autori di una sola pubblicazione per la quale si sono dissanguati e che nessuno ha letto e mai leggerà? Ecco, così, da qualche decennio a questa parte imperversare concorsi letterari in un paese in cui gran parte della popolazione non sa esprimersi correttamente e non capisce neppure il significato letterale di ciò che legge, ammesso che sia in grado di compiere correttamente pure tale operazione. Per me è un’attività ai limiti del lecito, come tutte quelle (alle quali non sono estranee banche, compagnie telefoniche, etc. etc.) che giocano sui grandi numeri. Nella fattispecie supponendo, al ribasso, una quota minima di partecipazione pari a 20 euro e 200 partecipanti, s’incassano già 4000 euro, più che sufficienti a coprire tutte le spese di organizzazione. Con la cultura autentica non si mangerà, ma con quella fasulla si sbafa …
Non vorrei apparire come un laudator temporis acti, un nostalgico (aggettivo pericoloso …, comunque da me distante anni luce) del tempo che fu, ma come non trarre le dovute conclusioni dal documento presentato nell’immagine di testa e tratto da Rassegna pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, Anno XXX, novembre-dicembre 1913, vol. XXVIII, nn. 11-12, p. 479?
Il lettore che voglia approfondire troverà al link https://books.google.it/books?id=B08osAbEIb4C&pg=PA479&dq=non+credo+che+alcuno+dei+componimenti&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi-5-79mNHqAhWR16YKHb3lAncQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=non%20credo%20che%20alcuno%20dei%20componimenti&f=false i dettagli del concorso, compresi tutti i 21 titoli delle poesie partecipanti, con motivazione per due di esse dell’esclusione e per le rimanenti del giudizio, che nei casi migliori è sempre parzialmente negativo. Ne ricordo di seguito il nome degli estensori, tutti personaggi di spicco, come, fra l’altro, dimostrano le loro pubblicazioni: Pasquale De Lorentiis1, appassionato paleontologo, nonché padre di Decio, fondatore nel 1960 del Museo Paleontologico di Maglie; Arturo Tafuri2, Giuseppe Macario3, Umberto Bozzini4, Nicola Serena Di Lapigio5.
Il loro giudizi negativi sono confermati da quello conclusivo e decisivo del presidente della commissione esaminatrice, Armando Perotti6, personalità di certo non da meno delle altre appena nominate, la cui fama dovrebbe andare ben al di là di ciò che possono evocare toponimi come Punta Perotti a Bari con il suo ecomostro rimasto in vita per troppo tempo o, in questo caso senza superfetazioni mostruose, Piazza Perotti a Castro.
______________
1 Commemorazione dei caduti supersanesi nella guerra d’Italia del 1915-1918, Diena, Matino, 1920
Discorso funebre per armando Perotti, in Per Armando Perotti: onoranze rese in Castro il 7 settembre 1924, Raeli, Tricase, 1924
Grotta Romanelli: stazione paleolitica in Terra d’Otranto, Tipografia La modernissima, Lecce, 1933
2
Parva favilla, La tipografia cooperativa, Lecce, 1899
Sebetia Venus: poema lirico, Treves, Milano, 1900
Poema della folla: lirica nova, Nerbini, Firenze, 1904
Luci ed ombre : poesie, Giannotta, Catania, 1911
Ortiche: 1908-1914, Editoriale italiana contemporanea, Arezzo, 1928
Stelle cadenti: nuove liriche, Contemporanea, Arezzo, 1930
Ave, Salento, Quaderni di poesia di Emo Cavalleri, Milano- Como, 1932
l pellegrinaggio di un’anima: poema eroico, Cavalieri, Como, 1935
Odi bizantine : Napoli 1888-1893, Tipografia Sorace e Siracusa, Catania, 1937
Scrasce e paparine te la serra, Editrice salentina, 1968
3
L’amante: romanzo, Pierro e Veraldi, Napoli, 1902
Al lavoro: ode, Pierro e Veraldi, Napoli, 1902
Per la guarigione della mia bambina: ode, Stabilimento tipografico vesuviano, Napoli, 1902
Ode al suicida, Società editrice Meridionale, Napoli, 1904
L’offerta: versi, Società Editrice Meridionale, Napoli, 1905
4
Fedra: tragedia in quattro atti, Mancino, Lucera, 1910
Manfredi: poema drammatico in un prologo e tre episodi, Mancino, Lucera, 1911
ll cuore di Rosaura: capriccio comico in 3 atti in versi, Lapi, Città di Castello, 1914
Ritmo antico, Cappetta, Lucera, 1922
5
Piccole anime e piccole cose: novelle, Cogliati, Milano, 1909
Le isole Tremiti, Frattarolo, Lucera, 1915
Panorami garganici, s.n., s.l., 1933
Vecchi motivi: racconti, Il solco, Città di Castello, 1933
6
Sul Trasimeno: 15 sonetti, Vecchi, Trani, 1887
Il libro dei canti, Vecchi, Trani, 1890
Castro: terze rime, Tipografia Alighieri, 1904
Giorgio Antonio Paladini : uomo d’arme nel secolo XVII, Stabilimento tipografico Giurdignano, Lecce, 1905
Ricerche etimologiche sui nomi diversi in Terra d’Otranto, Stabilimento tipografico Giurdignano, Lecce, 1905 (Estratto dalla Rivista Storica Salentina, n. 9 e 10).
Tricase : note e documenti, Stabilimento tipografico Giurdignano, Lecce, 1906
Bari ignota : curiosità e documenti di storia locale, Vecchi, Trani, 1907
Da Le Nereidi : nuovi canti del mare (estratto dalla Rassegna Pugliese, v. 23, 1907, n. 5-8).
Bari ignota: curiosità e documenti di storia locale, Vecchi e C., tRANI, 1908
Bari 1813-1913, Laterza, Bari, 1913
Onoranze al barone di Castiglione d. Filippo Bacile in Spongano il 14 settembre 1913: discorso commemorativo, Lecce, Martello, 1913
Il coro della Cattedrale di Bisceglie, in Napoli nobilissima, v. I (1920), pp. 97-100
Bibliografia storica della Terra di Bari per gli anni dal 1915 al 1920, Società tipografica editrice barese, 1921
Storie e storielle di Puglia, Laterza, Bari, 1923
#Armando Polito#Decio de Lorentiis#Pasquale De Lorentiis#Libri Di Puglia#Miscellanea#Spigolature Salentine
0 notes
Text
Nella notte tra la notte dell’8 e 9 agosto 1918, il Tenente degli Arditi Alessandro Tandura veniva lanciato da 1.600 piedi da un aereo Savoia-Pomilio SP.4 del Gruppo speciale Aviazione I, rabberciato in tutta fretta sostituendo i pezzi più importanti dopo un grave danneggiamento a seguito di un violento temporale, pilotato dal Maggiore canadese William George Barker e dal Capitano inglese William Wedgwood Benn (entrambi piloti della Royal Air Force), deputato alla Camera dei Comuni.
Alessandro Tandura nacque il 17 settembre 1893 a Serravalle di Vittorio Veneto. A 21 anni si arruola volontario nel Regio Esercito e viene assegnato al 1º Reggimento Fanteria “Re”, di stanza a Sacile (PN) il 14 settembre 1914 e in soli quattro mesi, il 31 gennaio 1915 si guadagna i gradi di caporale. Il 24 maggio 1915 il Regno d’Italia dichiara guerra all’Impero austro-ungarico e come altri valorosi soldati, il Caporale Tandura rimedia una grave ferita all’avambraccio sinistro durante un aspro combattimento sul monte Podgora. Il 6 luglio viene ricoverato all’ospedale di Legnago e inviato in licenza di convalescenza il 19 agosto, per quattro mesi.
Rientra al Corpo il 9 ottobre e, successivamente alla rassegna medica, viene nuovamente inviato in licenza di convalescenza per altri quattro mesi. Il 23 febbraio del 1916 viene ricoverato all’ospedale di riserva di Bologna per i postumi della ferita e l’8 marzo è trasferito all’Ospedale Militare di Campobasso. Il 16 maggio 1916 il caporale veneto, finalmente, poté ritornare dai suoi uomini e, nel settembre dello stesso mese, venne trasferito al Deposito del 77° Reggimento Fanteria “Toscana”.
Nei mesi a seguire, Tandura venne affidato alla custodia dei depositi di mitragliatrici del Reggimento “Brescia” finché, nell’ottobre 1917, non ottenne la nomina a sottotenente di complemento. Tandura, però, ricadde nei dolori della malattia che lo costrinsero ad allontanarsi dal fronte fino al dicembre dello stesso anno.
Il 27 dello stesso mese, il giovane soldato chiese insistentemente, malgrado il non totale recupero fisico, di entrare a far parte del 20° Reggimento d’Assalto delle “Fiamme Nere” che diverrà famoso con il nome di “Arditi”. Con loro, Tandura combatterà in tutti gli scontri del Basso Piave e, il 28 aprile 1918, ottenne la promozione a tenente di complemento. Nell’estate del 1918, l’ardito partecipò alla vittoriosa Battaglia del Solstizio finché, dopo pochi giorni, non venne contattato dal tenente colonnello Dupont.
Gli viene chiesto senza giri di parole se si senta di offrirsi per una missione segreta oltre il Piave, in territorio nemico, per raccogliere informazioni e Tandura che non vede l’ora di tornare in azione, accetta senza esitazioni. L’azione che lo avrebbe consegnato alla storia, si sarebbe dovuta svolgere nella notte fra il 8 e 9 agosto e quella notte il meteo non fu dalla parte dei protagonisti della pericolosa missione, Tandura e i due piloti della Royal Air Force, l’asso canadese Barker e il capitano inglese Benn.
Un violento temporale si abbatté sul nord-est ma, dimentichi della paura, i tre partirono comunque e il nostro eroe venne lanciato, come da manuale, in territorio nemico nella zona di Sarmede. Era il primo uomo paracadutato in azione di guerra, si apriva una nuova era nella storia delle guerre. Tandura secondo i piani appena atterrato avrebbe dovuto raggiungere il Col Visentin, e li stabilire la base operativa per poi mischiarsi con la popolazione e iniziare la sua pericolosissima missione di spionaggio (se dovesse essere catturato e riconosciuto come spia, il suo destino sarebbe la fucilazione).
Atterrato parecchio distante dal punto di arrivo, mentre l’aereo prosegue il suo volo, bombardando alcuni obiettivi, così da dissimulare il reale scopo della missione, il soldato non si diede per vinto; raccolse alcuni soldati e rivoltosi e boicottò gli Austriaci rallentandoli ed impedendoli nella loro avanzata verso il sud Italia. Tandura fu costretto a vivere in una grotta alcuni giorni ma, alla fine, i nemici lo catturarono. Il soldato riuscì a scappare una volta ma, catturato nuovamente, venne posto su di un treno diretto ad un campo di lavoro in Serbia, ma la fortuna aiutò il nostro valoroso ufficiale.
Il convoglio si dovette fermare a causa di un guasto tecnico, a quel punto l’ardito riusci nuovamente a fuggire scivolando dal finestrino e nascondendosi tra la boscaglia. Salvatosi per puro miracolo, Tandura non aspettò un secondo e si ricongiunse con i suoi compagni nella sua Vittorio Veneto, pronto a sferrare il colpo finale ai nemici. Dopo la Vittoria e la conclusione della guerra farà ritorno al suo comando, dove il Tenente Colonnello Dupont, lo proporrà per la Medaglia d’Oro. Questo il testo della sua richiesta.
«Ha fatto oggi ritorno dalla conquistata regione di Vittorio, ove si trovava in missione speciale da circa tre mesi, e si è presentato a questo Ufficio il Tenente Tandura Alessandro delle truppe d’assalto.
Ubbidendo ad uno spontaneo e generoso slancio dell’animo, spinto unicamente da un sentimento di amor patrio, assalito da un magnanimo desiderio di compiere opera utile alla Patria, sia pure coll’olocausto di sé medesimo, in sui primi del decorso mese di agosto, il Tenente Tandura accettava di sua libera elezione di esprimere un nuovo sistema di discesa dall’alto, e a mezzo di paracadute si faceva lanciare da un apparecchio in volo nella zona di Vittorio, ove atterrava mettendosi all’opera alacremente per raccogliere dati e notizie sui movimenti, le dislocazioni, le intenzioni del nemico e per entrare in contatto coi vari nuclei di soldati ed Ufficiali nostri sottrattisi con la fuga alla prigionia e in massima dispersi e sbandati nelle terre invase durante il ripiegamento dell’Ottobre 1917.
Non arrestò, nell’audace divisamento, il pensiero delle enormi difficoltà da superare, dei pericoli estremi da vincere; ché anzi di questi ebbe ragione con indomita costanza e intrepida fede, quelli affrontò con serena baldanza ed ammirevole slancio sfuggendo a ricerche, insidie e inseguimenti.
Tratto in arresto per ben due volte, si pose in salvo, riacquistò la libertà e perseverando la sua opera riuscì non solo a creare al di là delle linee nemiche un importante centro d’informazioni per le truppe operanti ed inviare a mezzo piccioni viaggiatori notizie precise e preziose sul nemico, ma a porsi in pari tempo, con pronta ed inesauribile arditezza a contatto coi vari nuclei di Ufficiali e soldati nostri dispersi per la regione, a riunirli, a riaccendere la fede e l’entusiasmo, portando loro la parola di solidarietà della Patria vigile ed amorosa, riorganizzare le file a preparare gli animi ai supremi cimenti.
È da ascrivere in modo particolare a suo merito se l’Armata poté entrare in azione con la piena coscienza delle Unità che aveva di fronte e della loro dislocazione.
Tale feconda ed avveduta opera di preparazione egli seppe integrare mercé la più ardita ed oculata delle azioni, unendosi, quando il movimento di ritirata delle truppe nemiche si fu delineato ad apparve in vista l’Esercito liberatore, alla testa delle schiere di ribelli, con essi insorgendo ed assalendo il nemico per poi offrire, infine, i suoi servigi ai vari Comandi, fornire tutte le informazioni preziose che possedeva, agevolare ed assecondare le loro azioni.
Le vicende del Tenente Tandura svoltesi in condizioni di estreme difficoltà, attraverso una lunga serie di sofferenze, di privazioni, di disagi, affrontati serenamente, con virile forza d’animo, senza iattanza, nel tripudio spirituale, che deriva a colui che ha conoscenza di offrire tutto sé stesso al Paese, ben a ragione possono paragonarsi ad una epopea, in cui la figura dell’eroico Ufficiale trasfigurata dalle stigmate degli stenti patiti, rifulge di vivida luce.
Ritiene pertanto lo scrivente abbia il Tenente Tandura ben meritato dalla Patria. Questa, impersonata nel più puro dei suoi simboli, l’Esercito, in niun’altra più degna guisa potrebbe onorarlo, che tributandogli la massima, più ambita delle onorificenze, la medaglia d’oro, colla seguente motivazione:
“Animato dal più ardente amor di patria, si offriva per compiere una missione estremamente rischiosa: da un aeroplano in volo, si faceva lanciare con un paracadute al di là delle linee nemiche nel Veneto invaso, dove, con alacre intelligenza e indomito sprezzo di ogni pericolo, raccoglieva nuclei di Ufficiali e soldati nostri dispersi, e, animandoli con il proprio coraggio e con la propria fede, costituiva con essi un servizio d’informazioni che riuscì di preziosissimo ausilio alle operazioni. Due volte arrestato e due volte sfuggito, dopo tre mesi di audacie leggendarie, integrava l’avveduta e feconda opera sua, ponendosi arditamente alla testa delle sue schiere di ribelli e con esse insorgendo nel movimento cui si delineava la ritirata nemica, ed agevolando così l’avanzata vittoriosa delle nostre truppe. Fulgido esempio di abnegazione, di cosciente coraggio e di generosa intera dedizione di tutto sé stesso alla Patria”. Piave – Vittorio Veneto, agosto – Ottobre 1918.
Propone inoltre che l’altissima ricompensa gli venga conferita per concessione immediata sul campo.
Il Tenente Colonnello di S.M. – Capo dell’Ufficio Informazioni
Dupont»
La massima onorificenza verrà immediatamente concessa e andrà a coronare un già folto e incredibile medagliere personale, su cui facevano bella mostra ben 5 Croci al Merito di Guerra, 3 Medaglie di Bronzo, 4 Medaglie d’Argento, Medaglia d’Oro al Valor Civico e Croix de Guerre 14-18 belga.
Il soldato di Vittorio Veneto difenderà e libererà la sua città natale ma questo non lo porterà via dal mondo della divisa. Sempre da militare, infatti, cadrà in Somalia, a Mogadiscio, il 29 dicembre 1937. Di lui parlerà così il capitano Wedgwood: “Non ho mai visto un uomo più coraggioso di questo Piccolo soldato italiano, il più valoroso soldato del mondo”.
Conclusa la Grande Guerra, la vita da soldato di Alessandro Tandura proseguirà senza sosta fino alla sua morte. Nel 1922 è nominato nel servizio permanente effettivo, viene trasferito in forza al 7º Rgt. Alpini e nel 1924 parte volontario per la Libia in forza al 21° Btg. Indigeni eritreo-misto. Al termine delle guerre coloniali si trasferirà in Somalia ed Eritrea. Nei territori dell’Impero, racconterà le sue avventure in due avvincenti e autoironiche opere autobiografiche, “Tre mesi di spionaggio oltre il Piave“ e “Due centimetri Più alto del Re“. Cadrà in Somalia, a Mogadiscio, il 29 dicembre 1937.
Il destino gli impedirà di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, come avrebbe certamente fatto, ma non impedirà alla Famiglia Tandura di donare alla Patria altro sangue e altro eroismo, dal momento che l’unico figlio di Alessandro Tandura e di Emma Petterle, Luigino Tandura, partigiano nella Brigata Osoppo, cadrà in combattimento il 28 giugno 1944 e verrà anch’egli decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Prima di chiudere il nostro post, vogliamo ricordare le parole di ammirazione che ebbe per lui il Capitano Wedgwood nel suo libro di memorie di guerra:
“Non ho mai visto un uomo più coraggioso di questo Piccolo soldato italiano, il Più valoroso soldato del mondo”.
Grazie per aver letto con tanta pazienza il nostro post, con la speranza che vogliate continuare a seguirci anche in futuro Vi salutiamo e diamo appuntamento al prossimo.
Il primo paracadutista al mondo in azione di guerra Nella notte tra la notte dell'8 e 9 agosto 1918, il Tenente degli Arditi Alessandro Tandura veniva lanciato da 1.600 piedi da un aereo Savoia-Pomilio SP.4 del Gruppo speciale Aviazione I, rabberciato in tutta fretta sostituendo i pezzi più importanti dopo un grave danneggiamento a seguito di un violento temporale, pilotato dal Maggiore canadese William George Barker e dal Capitano inglese William Wedgwood Benn (entrambi piloti della Royal Air Force), deputato alla Camera dei Comuni.
#Alessandro Tandura#Arditi#La Grande Guerra#Paracadutisti#Piave#William George Barker#William Wedgwood Benn
0 notes
Text
LA GUERRA DI CHARLOT
New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/la-guerra-di-charlot/
LA GUERRA DI CHARLOT

Il 9 agosto 1914, su carta intestata dell’esclusivo Athletic Club di Los Angeles, Charlie Chaplin scrisse al fratello Sydney a Londra per informarlo sugli ultimi sviluppi della sua folgorante carriera nel mondo del cinema. Da alcuni giorni la guerra divampava nella vecchia Europa ed i fanti di tutti gli eserciti appena mobilitati si illudevano di poter ritornare alle proprie case entro Natale. Dall’assolata California i primi bagliori della guerra apparivano lontanissimi, soprattutto a chi era impegnato a scalare rapidamente la vetta del successo: “Tutto il mio tempo se lo prende il cinema. Scrivo, dirigo, recito, e ti posso assicurare che è un grosso lavoro. Tutti i teatri scrivono il mio nome a lettere cubitali, tipo ‘Oggi Chas Chaplin’ e ti dico che in questo paese ho un grande successo al botteghino. I proprietari di sale mi dicono che ricevono almeno cinquanta lettere la settimana da uomini e donne in tutti i paesi del mondo. E’ magnifico se pensi che sono diventato popolare in poco tempo, e l’anno prossimo conto proprio di fare un mucchio di quattrini. Ho avuto un sacco di offerte a 500 la settimana con il 40% degli incassi, il che significa almeno mille dollari la settimana.”
La popolarità in ascesa, i favolosi incassi al botteghino, il moltiplicarsi di generose offere da parte degli uomini più potenti di Hollywood non lo distoglievano comunque dall’obiettivo di mettersi in proprio e di conquistare la propria indipendenza artistica oltreché guadagni ancora più grandi. In California c’era addirittura posto per un altro Chaplin che dopo una breve scrittura come attore avrebbe potuto sostenere il fratello minore nei suoi ambiziosi progetti: “Ti troverai bene qui, è un bel paese e l’aria è fresca mi fa un gran bene, ho un sacco di amici e vado a tutte le feste eccetera, e sto in uno dei migliori club della città dove vanno tutti i milionari, in poche parole me la passo proprio bene e passo il tempo in modo sano e piacevole e poi ho persino il mio maggiordomo, non c’è male eh? Però sto ancora risparmiando e da quando sono qui ho messo 4000 dollari in una banca 1200 in un’altra e 1500 a Londra, non male per avere venticinque anni e buona salute grazie a Dio. Sid fra poco saremo milionari. La salute va bene e sto persino acquistando un po’ di peso. (…) Spero non ti facciano combattere laggiù. Questa guerra è orribile. Bene, mi pare sia tutto. Ho appena finito un film di sei rulli con Marie Dressler, la grande star americana, e con me. E’ costato 50.000 dollari e io ci sono in tutto il film. E’ la cosa migliore che abbia fatto. Devo smettere adesso, comincio ad avere fame e proprio in questo secondo il mio maggiordomo mi dice che ci sono degli amici che sono venuti a prendermi in automobile per portarmi a mangiare sulla spiaggia. Buona notte Sid, un abbraccio a Minnie, il tuo affezionatissimo fratello Charlie.”
L’euforia per l’agiatezza appena raggiunta, dopo un’infanzia trascorsa nella miseria più nera, le brillanti prospettive di carriera, il sogno dell’indipendenza artisitica a portata di mano relegano ad una riga la più grande tragedia europea dall’età napoleonica: “Questa guerra è orribile.” E nulla più. Dopo appena cinque giorni dall’inizio del duello mortale tra le potenze europee era impossibile immaginare quanto grande sarebbe diventato quell’orrore, soprattutto per un giovane attore londinese che aveva appena fatto fortuna nella mecca del cinema.
Charles Spencer Chaplin era sbarcato sul nuovo continente alla fine di settembre del 1910 al seguito della compagnia teatrale di Fred Karno, il celebre impresario londinese di music hall. Aveva debuttato al Colonial Theatre di New York con una pantomima dal titolo The Wow-wows or a night in a London Secret Society . La critica ed il pubblico, pur apprezzando la vis comica del giovane Chaplin, nel ruolo di un elegante ubriaco capace di irresistibili capitomboli, avevano giudicato nel complesso piuttosto debole lo spettacolo. Tra alti e bassi la tournée era comunque proseguita per 21 mesi attraversando gli Stati Uniti, da Chicago a St. Louis, da Minneapolis a Kansas City, da Denver a Seattle, da Portland a San Francisco e Los Angeles. Nel giungo del 1912 la compagnia, di cui faceva parte anche un altro promettente giovane attore, Arthur Stanley Jefferson, destinato a grande fortuna con il nome d’arte di Stan Laurel (Stanlio), aveva fatto ritorno a Londra per poi riattraversare l’oceano nell’ottobre dello stesso anno. Nella seconda tournée americana la compagnia Karno aveva riproposto lo stesso spettacolo e l’accoglienza del pubblico non era stata affatto entusiastica. Soprattutto nelle città di provincia le situazioni paradossali che costituivano il meccanismo comico della pantomima lasciavano talvolta disorientato o indifferente il pubblico. Soltanto l’abilità acrobatica di Chaplin riusciva immancabilmente a strappare fragorose risate alla platea. Forse a New York, forse a Los Angeles, numerose e discordanti sono le ricostruzioni in proposito, tra il pubblico che si sbellicava non appena appariva in scena “l’ubriaco” aveva trovato posto un dirigente della New York Motion Pictures, forse Mack Sennet, forse Adam Kessel oppure suo fratello Charles. Chiunque avesse assistito alle risate in platea non aveva esitato un attimo prima di proporre una scrittura a quel buffissimo attore mingherlino. Il 4 agosto 1913, Chaplin aveva preso la penna per comunicare al fratello Syd che finalmente la sua carriera era giunta ad una svolta: “Oh, Syd, mi sembra di vederti! il tuo viso che si illumina mentre leggi, quei tuoi occhi scintillanti mentre decifri i miei scarabocchi che cosa mai sto per annunciarti! Ti dirò come stanno le cose. Ho avuto un’offerta da una casa di produzione cinematografica per un lungo periodo … (…) Si tratta della New York Motion Pictures Co, una delle ditte più serie ed affidabili degli Stati Uniti, hanno circa quattro compagnie, la Kay Bee, la Broncho e la Keystone per cui dovrei lavorare io. La Keystone è la compagnia comica. Io dovrei prendere il posto di Fred Mace, un nome molto importante nel cinema. Così ci puoi scommettere che hanno un’opinione piuttosto buona di me… . (…) Bene, abbiamo contrattato a lungo e poi ho dovuto condurre l’affare per iscritto e con l’aiuto di un dizionario ho redatto una bella lettera d’affari. Alla fine siamo giunti a questo accordo: un contratto di un anno con uno stipendio iniziale di 150 la settimana che dopo tre mesi, se me la cavo bene, diventeranno 175 e spesato di tutto a Los Angeles per l’intero periodo. Non so se tu abbia visto qualche film della Keystone, ma sono molto divertenti e hanno anche belle ragazze e così via. (…) Pensa, Syd, 35 sterline la settimana sono da prendere in seria considerazione, se solo ci lavoro per circa cinque anni saremo indipendenti per tutta la vita. Risparmierò fino all’osso.”
Senza intoppi il contratto era stato firmato nel settembre del 1913, in dicembre, dopo l’ultima rappresentazione con la compagnia Karno a Kansas city, Chaplin aveva raggiunto Los Angeles per iniziare il suo nuovo lavoro. Ad accoglierlo presso gli studi di Edendale aveva trovato Mack Sennett, un canadese oriundo irlandese che aveva assunto, in qualità di produttore, sceneggiatore e regista, la guida della Keystone fin dalla sua fondazione nell’estate del 1912. Dopo vari sfortunati tentativi di sfondare nel mondo del teatro e della commedia musicale, Sennett era approdato al cinema presso la casa di produzione Biograph, dove aveva potuto apprendere le tecniche della regia da un grande mestro come David Wark Griffith. Passato alla Keystone aveva sviluppato il suo gusto istintivo per le situazioni farsesche ed iperboliche, diventando in breve tempo uno dei padri dello slapstick, la comicità, che affondava le sue origini nella commedia dell’arte, basata sul linguaggio del corpo e sul moto perpetuo dei personaggi, come in un balletto sfrenato. Baruffe, capitomboli, pedate, martellate, torte in faccia e soprattutto inseguimenti, tra dame impennacchiate e monelli dispettosi, tra cani randagi ed azzimati gentiluomini in redingote, tra baffuti poliziotti che brandivano nodosi manganelli e sciagurati pasticcioni vittime del caso e della loro goffagine, erano diventati i tratti inconfondibili dei suoi film. Non esisteva una sceneggiatura, ma una situazione su cui si esercitava l’inesauribile improvvisazione degli attori che in un crescendo, capace di lasciare lo spettatore senza fiato, doveva sfociare nel catastrofico inseguimento finale. Nelle comiche, prodotte al ritmo forsennato di due la settimana, ricorrevano sempre le stesse location che fornivano innumerevoli variazioni alla stessa esile storia. I “park film”, i più economici e rapidi da girare, erano ambientati nel parco Westlake, nei pressi degli studi di Edendale, al centro della scena vi era una coppia di innamorati infastidita ora da un rivale geloso, ora da un monello, ora da un occhiuto poliziotto. Sennett amava anche inserire le sue comiche sullo sfondo di manifestazioni pubbliche, parate, gare sportive, corse di cavalli, in modo da poter sfruttare gratuitamente una folla di involontarie comparse. Più strutturati si presentavano invece i film girati in studio su di un set permanente: una grande stanza centrale con una camera a destra ed una sinistra che all’occorrenza potevano essere trasformate negli ambienti di una casa borghese, in un ufficio pubblico, in un ambulatorio medico, nella hall di un albergo ecc.. . La quarta tipologia di film era una combinazione di riprese esterne e di interni riprodotti in studio. Ovviamente era il prodotto più sofisticato che richiedeva i tempi di lavorazione più lunghi, cioè qualche giorno. Nel gennaio 1914, dopo alcune settimane di intenso apprendistato sui metodi di lavoro della Keystone, Chaplin aveva esordito proprio in un film della tipologia più elaborata, Making a living (Per guadagnarsi la vita), sotto la direzione di Henry Lehrman, un assistente di Sennett di origine viennese. Nessuno degli elementi che avrebbero costituito la maschera di Charlot aveva fatto la sua comparsa, la vis comica di Chaplin era risultata appena intuibile in qualche rapido gesto.
Deluso dalla sua prima prova davanti alla macchina da presa, Chaplin aveva deciso di costruirsi un personaggio dalle caratteristiche comiche più esasperate. Per farlo aveva incominciato a lavorare sul trucco e sul costume. Secondo la versione più accreditata, in un pomeriggio di pioggia nei camerini degli studi di Edendale avrebbe messo assieme alcuni indumenti abbandonati dai suoi colleghi, giocando sul contrasto tra ciò che si presentava troppo attillato e pretenzioso e ciò che era goffo ed informe: i pantaloni cascanti del pingue “Fatty” Arbuckle, la giacchetta del minuscolo Charles Avery, gli enormi scarponi di Ford Sterling, una minuscola bombetta del suocero di Arbuckle, una paio di baffi destinati a Mack Swain, ridotti alla dimensione di uno spazzolino da denti. Certamente l’esperienza maturata con la compagnia Karno gli era stata preziosa nell’accostare indumenti tanto grottescamente mal assortiti. Per mettere a punto la sua esilarante andatura Chaplin aveva fatto invece ricorso ai ricordi di infanzia, imitando un certo “Rummy” Binks, un disgraziato vecchietto afflitto da terribili reumatismi che accudiva i cavalli nel posteggio di carrozze situato nei pressi del pub gestito da un suo zio.
Nel febbraio 1914 in poco più di mezz’ora era stato girato Kid auto races at Venice (Charlot si distingue) in cui per la prima volta il buffo vagabondo destinato a far parlare di sé il mondo intero compariva impegnato a molestare una troupe intenta riprendere una gara di bambini su carrettini a rotelle. Già in aprile Chaplin aveva acquisito una tale padronanza della tecnica cinematografica da curare personalmente la regia dei suoi film, dando prova di una grande abilità nell’arte di raccontare per immagini. Dopo quel fortunato esordio erano seguite al ritmo serrato imposto da Sennett trentacinque pellicole in cui il vagabondo aveva man mano assunto tutti i suoi attributi comici, conquistando il pubblico americano. A poche settimane dalla prima apparizione di Chaplin sullo schermo i distributori avevano tempestato di ordini la Keystone. Nel giugno del 1914, mentre a Sarajevo Gavrilo Princip ed i suoi complici mettevano a punto i dettagli dell’attentato destinato a spingere l’Europa nel baratro della guerra, i suoi primi sette film erano giunti in Inghilterra, ottenendo una accoglienza trionfale. La stampa specializzata aveva giudicato Kid auto races at Venice il film più comico mai realizzato.
Chaplin, ormai noto da una sponda all’altra dell’oceano con il diminutivo ideato da Sennett di Chas Chaplin, non aveva tardato a rendersi conto del proprio valore commerciale. All’approssimarsi della scadenza del suo contratto aveva incominciato a guardarsi attorno nell’eventualità che la Keystone non fosse disposta a riconoscergli condizioni economiche ben più vantaggiose ed una maggiore indipendenza artistica.
La lettera indirizzata a Sid il 9 agosto 1914 fu scritta con ogni probabilità proprio all’indomani del rifiuto da parte della New York Motion Pictures di concedere condizioni più generose. Nei mesi successivi Sennett fu irremovibile sull’offerta di 400 dollari a settimana, pertanto nel novembre del 1914 Chaplin passò senza rimpianti alla Essanay, una compagnia di Chicago, di proprietà della star del cinema western “Boncho Billy” Anderson, disposta a riconoscergli la ragguardevole somma di 1250 dollari a settimana per quindici film da realizzare nel corso dell’anno. I dirigenti della Essanay non si mostrarono più sensibili alla qualità di quelli della Motion, i ritmi di lavoro rimasero convulsi ed i set essenziali come quelli degli studi di Edendale. A fare la differenza fu invece la crescita artistica di Chaplin che, pur accettando di girare le solite esili storielle, seppe moltiplicare le trovate comiche ed arricchire il suo personaggio di una dimensione patetica, malinconica e romantica destinata ad incantare il pubblico. Dopo l’esordio con His new job (Charlot principiante), realizzato nel febbraio del 1915 a Chicago, ottenne di poter lavorare negli studi californiani di Niles nei pressi di San Francisco, dove il clima mite era più favorevole alle riprese. Da Chicago portò con sé alcuni attori di cui apprezzava le caratteristiche comiche: lo strabico e baffuto Ben Turpin, Leo Whithe, specializzato nella caratterizzazione dell’elegantone sciocco, Bud Jamison, un colosso alto un metro ed ottanta per 120 chili di peso con cui creare grotteschi contrasti. Non tardò neppure a trovare in Edna Purviance, una giovane e bella segretaria notata per caso in un bar di San Francisco, una prima donna capace di non far rimpiangere al pubblico l’affascinante Mabel Normand con cui aveva recitato alla Keystone. Il sodalizio con Edna, con cui avrebbe girato trentacinque film nei successivi otto anni, non fu soltanto artistico, ma anche sentimentale.
Negli stessi mesi in cui Chaplin scopriva l’amore per Edna e regalava al pubblico momenti di puro divertimento con pellicole come The Champion (Charlot boxeur) in cui si improvvisava pugile, A nigth out (Charlot nottambulo) in cui riproponeva, in coppia con Turpin, il suo celebre numero dell’ubriaco, The tramp (Charlot vagabondo), in cui faceva la sua comparsa il finale malinconico sull’omino solitario che si allontana su di una strada polverosa, in Europa l’illusione di una guerra breve svaniva. Il piano Schlieffen si era impantanato, sul fronte occidentale un reticolo quasi ininterotto di trinceee si snodava ormai dalle Fiandre alla Svizzera; su quello orientale la situazione non si era cristallizzata, ma si combatteva accanitamente dal Mar Baltico ai Carpazi. Un corpo di spedizione alleato si preparava a sbarcare sulla penisola di Gallipoli, con l’obiettivo, sostenuto con convinzione dal Primo Lord dell’Ammiragliato britannico, Sir Winston Churchill, di fiaccare la resistenza degli imperi centrali attaccando il loro alleato più debole: l’impero ottomano. L’Italia dopo nove mesi di neutralità si accingeva a rompere gli indugi ed a scendere in campo a fianco di Francia, Gran Bretagna e Russia per completare il suo processo di unificazione nazionale e conquistarsi finalmente un posto tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti nel frattempo stavano a guardare, chiusi nel loro prudente isolazionismo, godendo dell’avvio di una fase di intenso sviluppo economico, oltreché della travolgente comicità di Chaplin.
La generosità americana a sostegno dell’Europa minacciata dal Kaiser e dai suoi alleati non si limitò alla fornitura di derrate alimentari, prestiti, materie prime, armi e munizioni, ma si estese anche alle risate. Le comiche di Chaplin una volta sbarcate in Inghilterra nel 1914 si diffusero in Francia ed in Italia come un potente antitodo agli orrori della guerra. Gli imperi centrali non poterono invece godere della corroborante comicità chapliniana, si rassegnarono ad affrontare il conflitto dilapidando tutte le loro riserve interne di risate. Intorno alla metà del 1915, il vagabondo fu ribattezzato Charlot dal distributore francese Jacques Haïk per renderlo ancor più familiare al grande pubblico. Al di là dei nomi, il personaggio ideato da Chaplin riusciva, da una parte all’altra dell’oceano, tra i reduci delle trincee come tra i lavoratori nel loro giorno di riposo, a strappare ben più di una risata, a fare breccia nei cuori con la sua romantica malinconia, addirittura a sollevare, quasi inconsapevolmente, temi sociali con una pungente ironia. Ad esempio in Work (Charlot apprendista), vestendo i panni di uno svagato decoratore vessato da un tirannico datore di lavoro, Chaplin offrì una rappresentazione dello sfruttamento del lavoro. Memorabili le sequenze iniziali in cui l’apprendista Charlot arranca su di una ripida salita, trascinando un traballante carretto ingombro di materiali, scale, pennelli, bidoni di vernice e quant’altro su cui troneggia il suo terribile boss munito di una frusta che non esita ad usare.
Nell’ultimo periodo della sua collaborazione con la Essanay Chaplin accarezzò l’idea di sviluppare questo filone sociale, sfruttando l’estremo realismo per dare corpo ad una comicità che fosse quanto più vicina possibile al suo pubblico. Lavorò al progetto di un lungometraggio intitolato Life, ma ben presto abbandonò le riprese, forse temendo di eccedere con i toni cupi. Non rinunciò comunque ad un certo dissacrante cinismo in Police (Charlot ladro). Il film si apre con Charlot che esce di prigione, una didascalia spiega il contesto: “ancora una volta in balia della infinita crudeltà del mondo”.
Sul finire del 1915, mentre sul fronte italiano si esaurivano senza alcun esito la terza e la quarta offensiva del generale Cadorna sull’Isonzo, le preoccupazioni artistiche di Chaplin si intrecciarono con quelle economiche. I 350.000 dollari offerti dalla Essanay per un rinnovo contrattuale di un anno esprimevano realisticamente il valore raggiunto dalla sua popolarità oppure rappresentavano poco più di una mancia in confronto alle dimensioni del suo successo? Trovò la risposta definitiva all’interrogativo che lo tormentava attraversando in treno gli Stati Uniti, ad ogni stazione tra Los Angeles e New York folle in tripudio erano assiepate ad accoglierlo. L’amore del pubblico per il suo personaggio appariva assoluto ed incondizionato. Il vagabondo era già diventato un’icona, i suoi tratti distintivi: bombetta, baffetti, bastoncino, scarponi, silhouette, andatura, ispiravano, nel vecchio e nel nuovo continente, canzoni, balli, cartoline, fumetti, spille, cartoni animati, bambolotti, giochi e persino dolciumi; un merchandising smisurato su cui i fratelli Chaplin tentarono, senza troppa fortuna, di affermare un diritto di sfruttamento in esclusiva.
Le grandi case di produzione, Universal, Famous Players, Vitagraph, Fox, Triangle, ovviamente non rimasero indifferenti, si affrettarono a contendersi il re Mida della celluloide, tempestandolo di offerte, una più generosa dell’altra. In questo gioco al rialzo si impose una compagnia fondata appena tre anni prima, la Mutual Film Corporation, con un’offerta di 670.000 dollari. Chaplin si dichiarò finalmente soddisfatto accettando la cifra più alta mai concessa fino ad allora ad una singola star.
Il contratto fu perfezionato il 26 febbraio 1916, cinque giorni prima, a Verdun, sulle sponde della Mosa, a circa 250 chilometri ad ovest di Parigi, le artiglierie tedesche avevano incominciato a martellare le posizioni francesi, annunciando una massiccia offensiva. Le sorti della battaglia oltreché della guerra apparivano quanto mai incerte. Fort Douamont, uno dei baluardi del sistema difensivo francese, era appena stato espuganto dalle truppe al comando del Kronprinz Guglielmo.
La Francia gettava nella mischia tutte le sue residue risorse e lottava per la vita, intanto i giornali americani, nelle pagine interne, si ingegnavano a proporre i più disparati termini di paragone per esprimere l’entità del compenso ottenuto da Chaplin. Secondo il Globe Commercial Advertiser di New York il comico inglese possedeva ormai “…tanto denaro da permettergli di comprare le uniformi nuove per tutto l’esercito alleato …” se solo l’avesse voluto. Il Picture-Play Magazine si avventurava in un calcolo ancora più ardito: “Se un uomo riesce a percepire un compenso annuo tanto al di sopra del mezzo milione di dollari che con quello che avanza potrebbe pagare lo stipendio al Segretario di stato per quattordici anni, vivere felice con quello che rimane per dodici mesi …, quell’uomo merita tutta la nostra fiducia.” La stessa Mutual si preoccupava di diffondere a scopo pubblicitario un curioso conteggio: “Ogni ora che passa fa cadere nelle tasche di Chaplin settansette dollari e cinquanta centesimi; e se gli servisse un nickelino per il tram, ci metterebbe solo due secondi per guadagnarlo.”
Tanto improvviso interesse per i guadagni di Chaplin finì per alimentare la leggenda della sua avarizia. A nulla servirono i suoi generosi assegni versati per opere di beneficienza. Un giornalista scrisse: “La sua unica stravaganza è un’auto a 12 cilindri: non si concede nemmeno il lusso di una moglie. Gioielli, cavalli di razza, compagnie rumorose, case di campagna, objects d’art e le altre costose manie dei ricchi più aggressivi non interessano questo giovane attore magrolino che in meno di 5 anni è passto dall’oscurità al rango del salariato più pagato del mondo… . Le sue spese lo scorso anno sono state notevolmente inferiori a 500 dollari e non ci sono indicazioni che il nuovo contratto gli abbia fatto girare la testa: caso mai lo ha spinto ad essere più parsimonioso. La sua teoria può non essere quella di vivere semplicemente e nutrire elevati pensieri, ma rimane il fatto che vive semplicemente, a meno che non sia qualcun altro a pagare il conto.”
Una volta raggiunta la ricchezza lo stile di vita di Chaplin non era poi così spartano, soprattutto a confronto di quello dei suoi coetani europei costretti a vestire l’uniforme ed a soffrire il freddo e la fame in trincea in attesa che un assalto decidesse della loro sorte, amava il lusso, ma non l’ostentazione, odiava lo sperpero, ma vestiva con ricercatezza, offriva di rado dei ricevimenti, ma non per questo rinunciava né alle comodità di una grande casa, né alle cure di un maggiordomo, né ad pittoresco chauffeur giapponese a cui affidare le sue fuori serie.
Le insinuazioni circa la sua avarizia accesero a loro volta l’interesse del pubblico sulle sue origini razziali. Già nel 1915 alla domanda di un giornalista a proposito della sua presunta ascendenza ebraica Chaplin aveva risposto cortesemente: “Non ho questa fortuna”. Non aveva mentito per opportunismo. Effettivamente, come ha dimostrato David Robinson dopo un’attenta analisi, anche risalendo di quattro generazioni tra i suoi antenati Chaplin non avrebbe potuto trovare legami con l’ebraismo. Tale smentita non era stata certo sufficiente a fugare ogni dubbio. Soprattutto dopo la firma del principesco contratto con la Mutual, i suoi capelli ricciuti, la fama di essere parsimonioso, di avere un gran fiuto per gli affari e la sua indubbia genialità convinsero una parte del pubblico e della critica ad attribuirgli un’origine ebraica. Ancora negli anni ’50 un autorevole storico del cinema come Georges Sadoul considerava l’origine ebraica di Chaplin come un dato assolutamente certo. Persino Hannah Arendt, in un saggio edito in Italia nel 1981 con il titolo “Il futuro alle spalle”, si è avventurata ad enfatizzare il profondo legame tra Chaplin e la cultura ebraica.
Anche la clausola sui rischi bellici prudentemente inserita dalla Mutual nel contratto ebbe pesanti ripercussioni sull’immagine pubblica di Chaplin. Tale clausola, corredata da un’assicurazione sulla vita del comico del valore di 250.000 dollari, prevedeva che Chaplin non potesse lasciare gli Stati Uniti senza l’autorizzazione della compagnia prima della scadenza del contratto annuale, in modo tale da evitare un eventuale arruolamento nell’esercito britannico. Nel gennaio del 1916 la Gran Bretagna aveva infatti introdotto la coscrizione obbligatoria per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 41 anni, cessando di affidare le sue sorti unicamente all’arruolamento volontario che pure aveva fornito un consistente afflusso di uomini nelle file dell’esercito. Fin dall’agosto del 1914 il ministro della Guerra, il generale Kitchener, aveva promosso un’efficacissima campagna di stampa, di cui la sua stessa effigie era diventata il simbolo, che aveva portato alla costituzione in tutto l’impero dei Pals battalions, reparti costituiti da gruppi di amici, di compagni di scuola e di club, di colleghi d’ufficio o di fabbrica che avevano lasciato volontariamente le loro case per combattere fianco a fianco. Pertanto, ancor prima dell’introduzione della leva obbligatoria la posizione del comico rispetto alla guerra poteva apparire quanto meno sospetta all’opinione pubblica inglese, abituata a considerare come un imperativo morale la spontanea mobilitazione di tutti i giovani in età militare.
Lo sdegno manifestato, nel marzo del 1916, dall’influente quotidiano londinese Daily Mail per la clausola sui rischi bellici amareggiò profondamente Chaplin, ma non compromise la sua creatività artisitica. Non appena si insediò nel modernissmo studio Lone Star, messogli a completa disposizione dalla Mutual nel quartiere di Colegrave a Los Angeles, si immerse nuovamente in un lavoro frenetico e dimenticò, almeno per qualche tempo, maldicenze, accuse e polemiche. Con il primo film, The Floorwalker (Charlot commesso), mise insieme uno staff tecnico di prim’ordine, in cui spiccava l’ingegnoso operatore Roland Totheroh, ed una valida compagnia di interpreti. Edna Purviance rimase l’indiscussa prima donna, Leo White, lasciata la Essanay, tornò a vestire i panni del nobil uomo dai modi raffinati, Eric Campbell sostituì Bud Jameson nella parte del gigante dalla faccia feroce, Albert Austin, un vecchio routinier della Karno, arricchì con il suo volto patibolare la galleria dei possibili contrasti comici con il sorriso ineffabile di Charlot. L’ampia autonomia concessagli dalla Mutual gli consentì di adottare un metodo di lavoro scrupoloso, assolutamente rivoluzionario rispetto agli standard qualitativi della cinematografia dell’epoca. La scelta dell’ambientazione delle sue comiche non fu mai casuale, ma mirata ad ottenere precisi effetti comici. In un’intervista rilasciata al Los Angeles Sunday Times dichiarò: ”E’ facile … ambientare una gag esilarante in una sala da biliardo o in una panetteria; una stanza da bagno possiede un umorismo implicito; al solo pensiero di una bottega di un impagliatore di animali viene da ridacchiare; un taxi, ribattezzato per scherzo ‘la delizia del mariolo’, è potenzialmente buffo… .” Poteva far costruire, smontare, modificare e rimontare un set decine di volte prima di decidersi a girare e una volta realizzate le riprese poteva sperimentare infinite varianti della stessa scena finché non maturava la convinzione di aver raggiunto la perfezione. Tanta attenzione ai dettagli ed alle sfumature espressive sarebbe stata considerata dalla Essanay ed ancor più dalla Keystone un inutile spreco di pellicola e di dollari, al contrario Chaplin ne fece la sua cifra artistica.
Dopo aver costruito The Floorwalker intorno al potenziale comico della scala mobile di un grande magazzino, dopo aver sfruttato in The fireman (Charlot pompiere) pertiche, veicoli ed attrezzature antincendio per ricavarne irresistibili gag, Chaplin tornò in The vagabond (Il Vagabondo) a mettere in risalto gli aspetti romantici del suo personaggio. La sapiente miscela tra risate e sentimentalismo, tra realismo e trasposizione della realtà continuava ad incantare il pubblico, anche in Europa, dove la guerra aveva ormai assunto le proporzioni di una inutile strage di cui nessuno era più in grado di prevedere la fine. Nel tentativo di alleggerire la pressione tedesca su Verdun l’alto comando alleato aveva lanciato un’offensiva lungo il fiume Somme, in Piccardia. La prima giornata di battaglia, il 1° luglio 1916, era costata all’esercito britannico circa 20.000 morti ed oltre 40.000 feriti.
L’estrema cura produttiva di Chaplin non pregiudicò gli impegni assunti con la Mutual: a ritmo mensile nuove comiche affluirono alle sale. Il personaggio di Charlot venne declinato in tutte le sue sfaccettature, offrendo nuove occasioni di espressione al virtuosismo comico di Chaplin ora nelle vesti del solito ubriaco in One A.M. (Charlot rientra tardi), ora in quelle di un impiegato del banco dei pegni che ausculta una sveglia come se fosse un paziente in The Pawnshop (Charlot usuraio), oppure in quelle di un flessuoso pattinatore in The rink (Charlot pattinatore).
Nell’autunno del 1916, quando il bilancio finale dell’offensiva sulla Somme registrava per gli anglo-francesi circa 620.000 perdite tra morti e feriti, nella valanga di ringraziamenti, lodi, dichiarazioni d’amore, richieste di denaro e proposte di matrimonio che ogni giorno intasava la casella postale di Chaplin incominciarono a comparire anonimi insulti e piume bianche, simbolo di codardia. Prima dell’istituzione della coscrizione obbligatoria per le strade di Londra si aggiravano gruppi di zelanti fanciulle pronte a consegnare una piuma bianca a tutti i giovani che ancora non si fossero arruolati.
L’atteggiamento ostile di una parte del pubblico inglese crebbe nel corso del 1917, fomentato dalla stampa, in particolare dal Daily Mail, di proprietà di Lord Northcliffe, probabilmente animato da un rancore personale nei confronti del comico. Il gruppo editoriale a cui faceva capo il Daily Mail aveva infatti incautamente acquistato i diritti per la pubblicazione in Gran Bretagna di una biografia non autorizzata di Chaplin. L’opera, che si annunciava come un best seller, era stata ricavata mescolando elementi di pura invenzione, come ad esempio la nascita di Charlie in territorio francese, con dichiarazioni autentiche rilasciate da Chaplin nel corso di una lunga intervista ad un giornale di San Francisco. Messo a conoscenza della pubblicazione di un’opera che giudicava lesiva della sua immagine ed offensiva per la sua famiglia, Chaplin diede immediatamente mandato ai suoi legali di intervenire. La sentenza di un giudice di New York pose termine alla questione, condannando la casa editrice americana per calunnia e diffamazione a mezzo stampa. Lord Northcliffe si trovò quindi proprietario dei diritti di un libro che non poteva dare alle stampe e non esitò a vendicarsi, dipingendo Chaplin come un vigliacco che accumulava immense ricchezze mentre il suo paese si stava dissanguando sul fronte occidentale.
Nel giugno del 1917, quando ormai gli Stati Uniti avevano messo da parte il loro tradizionale isolazionismo per schierarsi contro la Germania, Lord Northcliffe dalle colonne di uno dei suoi giornali lanciò un velenoso attacco: “Anche se di esile corporatura, Charles Chaplin è ben saldo sulle gambe, come dimostrano le sue acrobazie sullo schermo; e il modo con cui corre su e giù per le scale fa pensare che sarebbe bravissimo ad arrampicarsi sull’albero maestro al fischio del nostromo. Nei trentaquattro mesi di guerra, pare che Chaplin abbia guadagnato molto più di 125.000 sterline…(…) E’ stato affermato che Chaplin ha investito 25.000 sterline nel prestito di guerra britannico, ma la voce non ha avuto conferma. Del resto come può Chaplin negare al suo paese il suo denaro e i suoi servigi? Se Charlie si arruolerà, com’è suo dovere, almeno altri trenta cittadini britannici di età adeguata che stanno ora lavorando come artisiti negli Stati Uniti non avranno più scuse per starsene lontani dall’esercito del loro paese. Nessuno vuole che Chaplin si arruoli se i medici militari lo troveranno inabile al servizio, ma fino a che non si sottopone alla visita rimarrà il sospetto che si consideri dotato di speciali privilegi e autorizzato ad eludere le responsabilità dei comuni cittadini britannici. Forse il noto attore dello schermo non avrà avuto il tempo di pensarci, e sarà dunque grato che una simile occasione si sia presentata per ricordarglielo. Charlie con l’uniforme kaki sarebbe senza dubbio una delle figure più popolari dell’esercito… . E se risultasse inabile al servizio in trincea, potrebbe fare un ammirevole lavoro nell’intrattenere le truppe. In ogni caso, è dovere di Charlie Chaplin quello di arruolarsi e di mostrarsi fiero delle sue origini britanniche. Pensiamo naturalmente alla forza del suo esempio, non al valore intrinseco del suo eventuale contributo. Vinceremo anche se senza Charlie, ma, come direbbero milioni di suoi ammiratori, preferiremmo vincere con lui.”
Nonostante la mobilitazione patriottica seguita alla dichiarazione di guerra alla Germania, le insinuazioni di Lord Northcliffe non allontanarono il pubblico americano dalle sale in cui si proiettavano le ultime avventure del vagabondo. In diverse località degli Stati Uniti i gestori dei cinema si lamentarono di essere costretti a rinforzare le poltrone, messe a dura prova dalle scomposte risate suscitate dalle comiche chapliniane. Anche tra i fanti europei in trincea la popolarità di Charlot rimase intatta, anzi addirittura crebbe, tanto che l’alto comando britannico si sentì in dovere di introdurre il formale divieto per i soldati di portare i baffetti alla Charlot: ne andava della serietà della guerra. Alcuni medici militari arrivarono ad attribuire a Charlot effetti taumaturgici: le sue gag potevano spingere feriti immobilizzati a letto a scattare improvvisamente in piedi, sospinti da irrefrenabili risate.
Easy street (La strada della paura), The cure (La cura miracolosa), The immigrant (L’emigrante) riscossero un enorme successo, rafforzando la determinazione di Chaplin a diventare un regista indipendente e produttore di sé stesso. Nel giugno del 1917, mentre la prima divisione americana si accingeva a sbarcare sul suolo francese, Chaplin firmò con la First National Exhibitor’s Circuit, una società appena costituitasi con l’intento di insidiare il monopolio distributivo della Paramount, un lucroso contratto che gli garantiva uno stipendio di oltre un milione di dollari l’anno ed una completa indipendenza artistica e produttiva.
La cifra di un milione di dollari non suscitò eccessivo clamore poiché un’altra star, Mary Pickford, l’aveva già ottenuta l’anno precedente, tuttavia Chaplin non poté continuare ad ignorare le accuse di codardia. Nell’agosto del 1917, mentre stava ultimando, ancora per la Mutual, le riprese di The adventurer (L’evaso), ritenne opportuno rilasciare una dichiarazione alla stampa: “Sono prontissimo a rispondere al richiamo del mio paese e sarò lieto di svolgere il mio servizio militare nei modi che le autorità riteranno più utili e opportuni, ma come migliaia di altri cittadini britannici debbo aspettare gli ordini della nostra ambasciata a Washington. Nel frattempo, ho investito duecentocinquantamila dollari nei titoli di guerra inglesi e americani… . Mi sono iscritto all’ufficio leva, e non ho chiesto esenzioni né favori. Se mi avessero chiamato sarei andato al fronte come qualunque altro cittadino che ama il suo paese. Per ora, aspetto ordini dal governo britannico tramite l’ambasciatore.”.
L’ambasciata britannica si affrettò a fornire ulteriori chiarimenti per placare le polemiche: “Non cosidereremo renitente il signor Chaplin, almeno finché non riceveremo istruzioni di mettere in atto la coscrizione obbligatoria e finché non avrà rifiutato di combattere. Ovviamente il signor Chaplin potrebbe presentarsi come volontario, ma riteniamo che possa essere più utile al paese guadagnando molto denaro e investendendolo in prestiti di guerra, specialmente in un momento in cui non risulta vi sia un bisogno pressante di truppe fresche da mandare in trincea. Ci sono modi e modi di fare il proprio dovere, e non può definirsi renitente o codardo chi sottoscrive con grande generosità ai prestiti bellici e alla Croce Rossa, affermando nel contempo di essere pronto ad andare in trincea non appena verrà chiamato.”.
Le piume bianche continuarono tuttavia ad essere recapite a Chaplin e non scomparvero neppure quando una commissione medica lo dichiarò inabile al servizio militare per insufficienza di peso. I giornali, a cominciare a quelli di Lord Northcliffe, furono però costretti a cessare ogni campagna denigratoria nei suoi confronti.
Terminate le riprese di The adventurer, Chaplin si concesse una lunga vacanza alle Hawaii, la prima dopo anni di intenso lavoro. Edna lo accompagnò nella vana speranza di riaccendere la passione in una relazione che si stava ormai spegnendo. La mente di Charlie era infatti assorbita dai progetti per la realizzazione del suo nuovo studio, situato in una delle zone più prestigiose di Hollywood, all’angolo tra il Sunset Boulevard e La Brea Avenue. Nell’autunno del 1917 diede l’avvio ai lavori che terminarono nel gennaio dell’anno successivo. Non fece economie, investì oltre 500.000 dollari per dotarsi di una struttura all’avanguardia dal punto di vista tecnico. Curò persino l’aspetto estetico dello studio, al posto delle solite baracche in cui ricavare magazzini, camerini, ed uffici fece edificare dei graziosi cottage in stile inglese, che ottennero l’apprezzamento della raffinata élite di La Brea.
Pochi giorni dopo l’inaugurazione del nuovo studio iniziò la lavorazione di I should whorry, destinato a diventare celebre con il titolo definitivo di Dog’s life (Vita da cani). Ancora una volta Chaplin seppe fondere realismo e comicità accostando la lotta per la sopravvivenza del vagabondo a quella di un buffo cane randagio. Il film uscì nelle sale americane nell’aprile del 1918, in quei giorni l’azzardo strategico di Ludendorff e di Hindemburg sembrava avere successo. Le forze dell’Intesa, in cui il contributo delle truppe americane era ancora marginale, si stavano ritirando su tutto il fronte occidentale, abbandonando sul terreno uomini e materiali: da meno di un mese la Germania aveva lanciato l’offensiva di primavera. Il crollo della russia zarista, dopo la rivoluzione bolscevica del novembre 1917, aveva reso disponibili all’alto comando tedesco preziose risorse con cui tentare di risolvere il conflitto.
L’imprevedibile colpo di coda del militarismo tedesco, che non si rassegnava alla sconfitta ed anzi si mostrava quanto mai determinato a trionfare, convinse il presidente Wilson a lanciare la terza campagna a favore del prestito di guerra. Il compito di convincere il popolo americano a contribuire con i propri risparmi allo sforzo bellico ed alla difesa degli ideali democratici fu affidato alle stelle più luminose di Hollywood: Mary Pickford, l’attrice più pagata e desiderata d’America, Douglas Fairbanks, l’incarnazione dell’eroe romantico ed avventuroso, e Charlie Chaplin, la maschera comica che aveva conquistato il mondo intero. A Washington i tre attori attraversarono trionfalmente le vie della città sino ad un campo da football, dove li attendeva una folla in delirio. L’emozione di dover prendere la parola difronte ad un pubblico così vasto tradì Chaplin che si rese protagonista di una involontaria gag cadendo dal palco e travolgendo un giovane vicesegretario alla Marina, Franklin Delano Roosevelt, all’epoca ancora ben saldo sulle gambe. A New York oltre trentamila persone si accalcarono all’incrocio tra Broadway e Wall Street per acclamare i loro idoli. Amplificato da un megafono Chaplin trovò il coraggio di arringare la folla: “Chiedo a voi qui presenti di dimenticare tutto sulle percentuali di questo terzo prestito di guerra. La vita umana è in pericolo, e nessuno deve preoccuparsi del tasso d’interesse che i buoni possono fruttare né di quel che si può guadagnare acquistandoli. C’è bisogno di denaro per sostenere il grande esercito e la marina dello zio Sam. In questo momento la Germania sta prendendo il sopravvento, e noi dobbiamo avere i dollari che ci permetteranno di intervenire in Europa e di cacciare quel vecchio diavolo del Kaiser fuori dalla Francia!” Dopo il successo di New York le stelle si separarono, Charlie proseguì per gli stati del sud, dalla Virginia al Missisippi, Douglas e Mary, marito e moglie, si occuparono invece della propaganda nel nord del paese.
L’atmosfera patriottica respirata in quel mese trascorso attraversando gli Stati Uniti convinse Chaplin a mettere in cantiere un progetto che accarezzava da tempo: ambientare una comica tra il fango delle trincee. La sfida di strappare risate su di una tragedia come la guerra che stava insaguinando il pianeta si rivelò molto ardua. Alla fine di maggio del 1918, con il titolo provvisorio di Camouflage, diede il primo ciak, seguendo un abbozzo di sceneggiatura che prevedeva tre atti: la vita civile di Charlot, oppresso da una moglie tanto dispotica da fargli accogliere la cartolina precetto come un’insperata liberazione, la visita di leva, preludio alla dura vita del fronte, ed infine un banchetto offerto dai leader dell’Intesa in onore del coraggio di Charlot che da solo era stato capace di catturare niente meno che il Kaiser. Nell’ultimo fotogramma le pedate di un feroce sergente istruttore avrebbero dovuto risvegliare la recluta Charlot dai suoi assurdi sogni di gloria.
Le scene della vita civile e della visita medica, benché conservino ancora oggi una certa verve, non convinsero del tutto Chaplin che decise di tagliarle subito dopo averle girate, sostenendo i costi di oltre un mese di lavorazione sprecato. Mutò quindi il titolo in Shoulder arms (Charlot soldato) e stravolse la storia che aveva ideato, scegliendo coraggiosamente di incentrare la narrazione sulla trasposizione in chiave comica della vita quotidiana dei fanti in trincea. Senza badare a spese fece realizzare una perfetta riproduzione delle fangose trincee del fronte occidentale, affidando alla comicità surreale del soldato Charlot il delicato compito di controbilanciare il crudo realismo della scenografia. Il vagabondo in uniforme kaki, ma con le consuete scarpacce fuori misura, affronta le privazioni della guerra con una trappola per topi appesa al taschino ed una grattugia su cui strofinare la schiena quando i pidocchi si fanno troppo molesti; semina il panico tra i feroci unni lanciando sulle loro teste un formaggio puzzolente ricevuto come sgradito dono; riesce ad addormentarsi placidamente in un ricovero allagato, dopo aver sprimacciato il guanciale e soffiato sulla candella che galleggia sull’acqua, ad infastidirlo è soltanto il russare di un commilotone; stappa bottiglie ed accende sigarette sfruttando l’infallibile precisione dei cecchini nemici; anticipando le gesta del sergente York, cattura frotte di giganteschi tedeschi comandati da un irascibile ufficiale poco più alto di un bambino, si mostra generoso regalando sigarette ai prigionieri, ma somministra una sonora sculacciata all’ufficiale tracotante; si camuffa da albero e si avventura nella terra di nessuno, salva la virtù di una ragazza francese, interpretata dall’immancabile Edna, e finisce per prendere in trappola il Kaiser, Hindemburg ed il principe ereditario: poi si desta dal sogno e si ritrova al campo di addestramento reclute.
Terminate le riprese, ulteriormente rallentate dalla produzione di The bond (Il prestito), un breve e anodino film di propaganda a sostegno del prestito di guerra, Chaplin fu colto da un improvviso ripensamento, temette di aver goffamente parodiato l’atrocità della guerra, arrivando persino a meditare di distruggere tutto il girato. Si rese conto dell’errore che stava per commettere solo quando il suo amico fraterno Douglas Fairbanks rise fino alle lacrime in occcasione della prima proiezione privata. Le sue risate anticiparono quelle di milioni di spettatori in tutto il mondo.
Shoulder arms uscì nelle sale il 20 ottobre 1918, quando le forze alleate stavano per trionfare sugli imperi centrali, ottenendo subito un clamoroso successo, forse uno dei più grandi della carriera di Chaplin. Il critico francese Louis Delluc scrisse: “Questo film giustifica tutte le speranza del cinema. Siamo veramente nel campo del prodigioso dell’illimitato…” Con minor enfasi, ma con altrettanta sincerità, milioni di combattenti che avevano vissuto orrori e sofferenze tributarono al vagabondo la loro eterna riconoscenza per essere riuscito a portare un barlume di gioia nei momenti più tragici della loro esistenza. Ai loro occhi, indossando l’uniforme ed imbracciando il fucile Charlot aveva contribuito alla vittoria finale più di chiunque altro.
Bibliografia
CHARLES CHAPLIN, La mia autobiografia, Milano, Mondadori, 1964
CHARLIE CHAPLIN (a cura di K. J. HAYES), Opinioni di un vagabondo. Mezzo secolo di interviste, Roma, Edizioni minimum fax, 2007.
DAVID ROBINSON, Chaplin. La vita e l’arte, Venezia, Marsilio, 1987.
DAVID ROBINSON, Chaplin. Un uomo chiamato Charlot, Trieste, Electa Gallimard, 1995.
GEORGES SADOUL, Vita di Charlot, Torino, Einuadi, 1952.
GIORGIO CREMONINI, Charlie Chaplin, Milano, Editrice Il Castoro, 1995.
KENNETH ANGER, Hollywood Babilonia, Milano, Adelphi, 1979.
MARTIN GILBERT, La grande storia della prima guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1998
Related Post
Owura Kwadwo: MS Word On Chalkboard
Calabria: le trivelle e lo sviluppo mancato
A Christmas Carol by J. Searle Dawley
Pavel Kuczynski: Animalismo
Writing a Quantum Program
EHANG 184 Flight Tests
Esercizi mnemonici
Fornaci di Barga
AutoDraw & QuickDarw: machine learning &...
Storia della guerra – 5: L’impero biza...
Two entire pop songs composed with Artificial Inte...
Charles Marie Widor – Sinfonia n.2 per Orchestra
.yuzo_related_post imgwidth:155px !important; height:145px !important; .yuzo_related_post .relatedthumbline-height:15px;background: !important;color:!important; .yuzo_related_post .relatedthumb:hoverbackground:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important; .yuzo_related_post .relatedthumb acolor:!important; .yuzo_related_post .relatedthumb a:hover color:!important;} .yuzo_related_post .relatedthumb:hover a color:!important; .yuzo_related_post .yuzo_text color:!important; .yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text color:!important; .yuzo_related_post .relatedthumb margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; jQuery(document).ready(function( $ ) //jQuery('.yuzo_related_post').equalizer( overflow : 'relatedthumb' ); jQuery('.yuzo_related_post .yuzo_wraps').equalizer( columns : '> div' ); )
0 notes
Text
LA GUERRA DI CHARLOT
New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/la-guerra-di-charlot/
LA GUERRA DI CHARLOT

Il 9 agosto 1914, su carta intestata dell’esclusivo Athletic Club di Los Angeles, Charlie Chaplin scrisse al fratello Sydney a Londra per informarlo sugli ultimi sviluppi della sua folgorante carriera nel mondo del cinema. Da alcuni giorni la guerra divampava nella vecchia Europa ed i fanti di tutti gli eserciti appena mobilitati si illudevano di poter ritornare alle proprie case entro Natale. Dall’assolata California i primi bagliori della guerra apparivano lontanissimi, soprattutto a chi era impegnato a scalare rapidamente la vetta del successo: “Tutto il mio tempo se lo prende il cinema. Scrivo, dirigo, recito, e ti posso assicurare che è un grosso lavoro. Tutti i teatri scrivono il mio nome a lettere cubitali, tipo ‘Oggi Chas Chaplin’ e ti dico che in questo paese ho un grande successo al botteghino. I proprietari di sale mi dicono che ricevono almeno cinquanta lettere la settimana da uomini e donne in tutti i paesi del mondo. E’ magnifico se pensi che sono diventato popolare in poco tempo, e l’anno prossimo conto proprio di fare un mucchio di quattrini. Ho avuto un sacco di offerte a 500 la settimana con il 40% degli incassi, il che significa almeno mille dollari la settimana.”
La popolarità in ascesa, i favolosi incassi al botteghino, il moltiplicarsi di generose offere da parte degli uomini più potenti di Hollywood non lo distoglievano comunque dall’obiettivo di mettersi in proprio e di conquistare la propria indipendenza artistica oltreché guadagni ancora più grandi. In California c’era addirittura posto per un altro Chaplin che dopo una breve scrittura come attore avrebbe potuto sostenere il fratello minore nei suoi ambiziosi progetti: “Ti troverai bene qui, è un bel paese e l’aria è fresca mi fa un gran bene, ho un sacco di amici e vado a tutte le feste eccetera, e sto in uno dei migliori club della città dove vanno tutti i milionari, in poche parole me la passo proprio bene e passo il tempo in modo sano e piacevole e poi ho persino il mio maggiordomo, non c’è male eh? Però sto ancora risparmiando e da quando sono qui ho messo 4000 dollari in una banca 1200 in un’altra e 1500 a Londra, non male per avere venticinque anni e buona salute grazie a Dio. Sid fra poco saremo milionari. La salute va bene e sto persino acquistando un po’ di peso. (…) Spero non ti facciano combattere laggiù. Questa guerra è orribile. Bene, mi pare sia tutto. Ho appena finito un film di sei rulli con Marie Dressler, la grande star americana, e con me. E’ costato 50.000 dollari e io ci sono in tutto il film. E’ la cosa migliore che abbia fatto. Devo smettere adesso, comincio ad avere fame e proprio in questo secondo il mio maggiordomo mi dice che ci sono degli amici che sono venuti a prendermi in automobile per portarmi a mangiare sulla spiaggia. Buona notte Sid, un abbraccio a Minnie, il tuo affezionatissimo fratello Charlie.”
L’euforia per l’agiatezza appena raggiunta, dopo un’infanzia trascorsa nella miseria più nera, le brillanti prospettive di carriera, il sogno dell’indipendenza artisitica a portata di mano relegano ad una riga la più grande tragedia europea dall’età napoleonica: “Questa guerra è orribile.” E nulla più. Dopo appena cinque giorni dall’inizio del duello mortale tra le potenze europee era impossibile immaginare quanto grande sarebbe diventato quell’orrore, soprattutto per un giovane attore londinese che aveva appena fatto fortuna nella mecca del cinema.
Charles Spencer Chaplin era sbarcato sul nuovo continente alla fine di settembre del 1910 al seguito della compagnia teatrale di Fred Karno, il celebre impresario londinese di music hall. Aveva debuttato al Colonial Theatre di New York con una pantomima dal titolo The Wow-wows or a night in a London Secret Society . La critica ed il pubblico, pur apprezzando la vis comica del giovane Chaplin, nel ruolo di un elegante ubriaco capace di irresistibili capitomboli, avevano giudicato nel complesso piuttosto debole lo spettacolo. Tra alti e bassi la tournée era comunque proseguita per 21 mesi attraversando gli Stati Uniti, da Chicago a St. Louis, da Minneapolis a Kansas City, da Denver a Seattle, da Portland a San Francisco e Los Angeles. Nel giungo del 1912 la compagnia, di cui faceva parte anche un altro promettente giovane attore, Arthur Stanley Jefferson, destinato a grande fortuna con il nome d’arte di Stan Laurel (Stanlio), aveva fatto ritorno a Londra per poi riattraversare l’oceano nell’ottobre dello stesso anno. Nella seconda tournée americana la compagnia Karno aveva riproposto lo stesso spettacolo e l’accoglienza del pubblico non era stata affatto entusiastica. Soprattutto nelle città di provincia le situazioni paradossali che costituivano il meccanismo comico della pantomima lasciavano talvolta disorientato o indifferente il pubblico. Soltanto l’abilità acrobatica di Chaplin riusciva immancabilmente a strappare fragorose risate alla platea. Forse a New York, forse a Los Angeles, numerose e discordanti sono le ricostruzioni in proposito, tra il pubblico che si sbellicava non appena appariva in scena “l’ubriaco” aveva trovato posto un dirigente della New York Motion Pictures, forse Mack Sennet, forse Adam Kessel oppure suo fratello Charles. Chiunque avesse assistito alle risate in platea non aveva esitato un attimo prima di proporre una scrittura a quel buffissimo attore mingherlino. Il 4 agosto 1913, Chaplin aveva preso la penna per comunicare al fratello Syd che finalmente la sua carriera era giunta ad una svolta: “Oh, Syd, mi sembra di vederti! il tuo viso che si illumina mentre leggi, quei tuoi occhi scintillanti mentre decifri i miei scarabocchi che cosa mai sto per annunciarti! Ti dirò come stanno le cose. Ho avuto un’offerta da una casa di produzione cinematografica per un lungo periodo … (…) Si tratta della New York Motion Pictures Co, una delle ditte più serie ed affidabili degli Stati Uniti, hanno circa quattro compagnie, la Kay Bee, la Broncho e la Keystone per cui dovrei lavorare io. La Keystone è la compagnia comica. Io dovrei prendere il posto di Fred Mace, un nome molto importante nel cinema. Così ci puoi scommettere che hanno un’opinione piuttosto buona di me… . (…) Bene, abbiamo contrattato a lungo e poi ho dovuto condurre l’affare per iscritto e con l’aiuto di un dizionario ho redatto una bella lettera d’affari. Alla fine siamo giunti a questo accordo: un contratto di un anno con uno stipendio iniziale di 150 la settimana che dopo tre mesi, se me la cavo bene, diventeranno 175 e spesato di tutto a Los Angeles per l’intero periodo. Non so se tu abbia visto qualche film della Keystone, ma sono molto divertenti e hanno anche belle ragazze e così via. (…) Pensa, Syd, 35 sterline la settimana sono da prendere in seria considerazione, se solo ci lavoro per circa cinque anni saremo indipendenti per tutta la vita. Risparmierò fino all’osso.”
Senza intoppi il contratto era stato firmato nel settembre del 1913, in dicembre, dopo l’ultima rappresentazione con la compagnia Karno a Kansas city, Chaplin aveva raggiunto Los Angeles per iniziare il suo nuovo lavoro. Ad accoglierlo presso gli studi di Edendale aveva trovato Mack Sennett, un canadese oriundo irlandese che aveva assunto, in qualità di produttore, sceneggiatore e regista, la guida della Keystone fin dalla sua fondazione nell’estate del 1912. Dopo vari sfortunati tentativi di sfondare nel mondo del teatro e della commedia musicale, Sennett era approdato al cinema presso la casa di produzione Biograph, dove aveva potuto apprendere le tecniche della regia da un grande mestro come David Wark Griffith. Passato alla Keystone aveva sviluppato il suo gusto istintivo per le situazioni farsesche ed iperboliche, diventando in breve tempo uno dei padri dello slapstick, la comicità, che affondava le sue origini nella commedia dell’arte, basata sul linguaggio del corpo e sul moto perpetuo dei personaggi, come in un balletto sfrenato. Baruffe, capitomboli, pedate, martellate, torte in faccia e soprattutto inseguimenti, tra dame impennacchiate e monelli dispettosi, tra cani randagi ed azzimati gentiluomini in redingote, tra baffuti poliziotti che brandivano nodosi manganelli e sciagurati pasticcioni vittime del caso e della loro goffagine, erano diventati i tratti inconfondibili dei suoi film. Non esisteva una sceneggiatura, ma una situazione su cui si esercitava l’inesauribile improvvisazione degli attori che in un crescendo, capace di lasciare lo spettatore senza fiato, doveva sfociare nel catastrofico inseguimento finale. Nelle comiche, prodotte al ritmo forsennato di due la settimana, ricorrevano sempre le stesse location che fornivano innumerevoli variazioni alla stessa esile storia. I “park film”, i più economici e rapidi da girare, erano ambientati nel parco Westlake, nei pressi degli studi di Edendale, al centro della scena vi era una coppia di innamorati infastidita ora da un rivale geloso, ora da un monello, ora da un occhiuto poliziotto. Sennett amava anche inserire le sue comiche sullo sfondo di manifestazioni pubbliche, parate, gare sportive, corse di cavalli, in modo da poter sfruttare gratuitamente una folla di involontarie comparse. Più strutturati si presentavano invece i film girati in studio su di un set permanente: una grande stanza centrale con una camera a destra ed una sinistra che all’occorrenza potevano essere trasformate negli ambienti di una casa borghese, in un ufficio pubblico, in un ambulatorio medico, nella hall di un albergo ecc.. . La quarta tipologia di film era una combinazione di riprese esterne e di interni riprodotti in studio. Ovviamente era il prodotto più sofisticato che richiedeva i tempi di lavorazione più lunghi, cioè qualche giorno. Nel gennaio 1914, dopo alcune settimane di intenso apprendistato sui metodi di lavoro della Keystone, Chaplin aveva esordito proprio in un film della tipologia più elaborata, Making a living (Per guadagnarsi la vita), sotto la direzione di Henry Lehrman, un assistente di Sennett di origine viennese. Nessuno degli elementi che avrebbero costituito la maschera di Charlot aveva fatto la sua comparsa, la vis comica di Chaplin era risultata appena intuibile in qualche rapido gesto.
Deluso dalla sua prima prova davanti alla macchina da presa, Chaplin aveva deciso di costruirsi un personaggio dalle caratteristiche comiche più esasperate. Per farlo aveva incominciato a lavorare sul trucco e sul costume. Secondo la versione più accreditata, in un pomeriggio di pioggia nei camerini degli studi di Edendale avrebbe messo assieme alcuni indumenti abbandonati dai suoi colleghi, giocando sul contrasto tra ciò che si presentava troppo attillato e pretenzioso e ciò che era goffo ed informe: i pantaloni cascanti del pingue “Fatty” Arbuckle, la giacchetta del minuscolo Charles Avery, gli enormi scarponi di Ford Sterling, una minuscola bombetta del suocero di Arbuckle, una paio di baffi destinati a Mack Swain, ridotti alla dimensione di uno spazzolino da denti. Certamente l’esperienza maturata con la compagnia Karno gli era stata preziosa nell’accostare indumenti tanto grottescamente mal assortiti. Per mettere a punto la sua esilarante andatura Chaplin aveva fatto invece ricorso ai ricordi di infanzia, imitando un certo “Rummy” Binks, un disgraziato vecchietto afflitto da terribili reumatismi che accudiva i cavalli nel posteggio di carrozze situato nei pressi del pub gestito da un suo zio.
Nel febbraio 1914 in poco più di mezz’ora era stato girato Kid auto races at Venice (Charlot si distingue) in cui per la prima volta il buffo vagabondo destinato a far parlare di sé il mondo intero compariva impegnato a molestare una troupe intenta riprendere una gara di bambini su carrettini a rotelle. Già in aprile Chaplin aveva acquisito una tale padronanza della tecnica cinematografica da curare personalmente la regia dei suoi film, dando prova di una grande abilità nell’arte di raccontare per immagini. Dopo quel fortunato esordio erano seguite al ritmo serrato imposto da Sennett trentacinque pellicole in cui il vagabondo aveva man mano assunto tutti i suoi attributi comici, conquistando il pubblico americano. A poche settimane dalla prima apparizione di Chaplin sullo schermo i distributori avevano tempestato di ordini la Keystone. Nel giugno del 1914, mentre a Sarajevo Gavrilo Princip ed i suoi complici mettevano a punto i dettagli dell’attentato destinato a spingere l’Europa nel baratro della guerra, i suoi primi sette film erano giunti in Inghilterra, ottenendo una accoglienza trionfale. La stampa specializzata aveva giudicato Kid auto races at Venice il film più comico mai realizzato.
Chaplin, ormai noto da una sponda all’altra dell’oceano con il diminutivo ideato da Sennett di Chas Chaplin, non aveva tardato a rendersi conto del proprio valore commerciale. All’approssimarsi della scadenza del suo contratto aveva incominciato a guardarsi attorno nell’eventualità che la Keystone non fosse disposta a riconoscergli condizioni economiche ben più vantaggiose ed una maggiore indipendenza artistica.
La lettera indirizzata a Sid il 9 agosto 1914 fu scritta con ogni probabilità proprio all’indomani del rifiuto da parte della New York Motion Pictures di concedere condizioni più generose. Nei mesi successivi Sennett fu irremovibile sull’offerta di 400 dollari a settimana, pertanto nel novembre del 1914 Chaplin passò senza rimpianti alla Essanay, una compagnia di Chicago, di proprietà della star del cinema western “Boncho Billy” Anderson, disposta a riconoscergli la ragguardevole somma di 1250 dollari a settimana per quindici film da realizzare nel corso dell’anno. I dirigenti della Essanay non si mostrarono più sensibili alla qualità di quelli della Motion, i ritmi di lavoro rimasero convulsi ed i set essenziali come quelli degli studi di Edendale. A fare la differenza fu invece la crescita artistica di Chaplin che, pur accettando di girare le solite esili storielle, seppe moltiplicare le trovate comiche ed arricchire il suo personaggio di una dimensione patetica, malinconica e romantica destinata ad incantare il pubblico. Dopo l’esordio con His new job (Charlot principiante), realizzato nel febbraio del 1915 a Chicago, ottenne di poter lavorare negli studi californiani di Niles nei pressi di San Francisco, dove il clima mite era più favorevole alle riprese. Da Chicago portò con sé alcuni attori di cui apprezzava le caratteristiche comiche: lo strabico e baffuto Ben Turpin, Leo Whithe, specializzato nella caratterizzazione dell’elegantone sciocco, Bud Jamison, un colosso alto un metro ed ottanta per 120 chili di peso con cui creare grotteschi contrasti. Non tardò neppure a trovare in Edna Purviance, una giovane e bella segretaria notata per caso in un bar di San Francisco, una prima donna capace di non far rimpiangere al pubblico l’affascinante Mabel Normand con cui aveva recitato alla Keystone. Il sodalizio con Edna, con cui avrebbe girato trentacinque film nei successivi otto anni, non fu soltanto artistico, ma anche sentimentale.
Negli stessi mesi in cui Chaplin scopriva l’amore per Edna e regalava al pubblico momenti di puro divertimento con pellicole come The Champion (Charlot boxeur) in cui si improvvisava pugile, A nigth out (Charlot nottambulo) in cui riproponeva, in coppia con Turpin, il suo celebre numero dell’ubriaco, The tramp (Charlot vagabondo), in cui faceva la sua comparsa il finale malinconico sull’omino solitario che si allontana su di una strada polverosa, in Europa l’illusione di una guerra breve svaniva. Il piano Schlieffen si era impantanato, sul fronte occidentale un reticolo quasi ininterotto di trinceee si snodava ormai dalle Fiandre alla Svizzera; su quello orientale la situazione non si era cristallizzata, ma si combatteva accanitamente dal Mar Baltico ai Carpazi. Un corpo di spedizione alleato si preparava a sbarcare sulla penisola di Gallipoli, con l’obiettivo, sostenuto con convinzione dal Primo Lord dell’Ammiragliato britannico, Sir Winston Churchill, di fiaccare la resistenza degli imperi centrali attaccando il loro alleato più debole: l’impero ottomano. L’Italia dopo nove mesi di neutralità si accingeva a rompere gli indugi ed a scendere in campo a fianco di Francia, Gran Bretagna e Russia per completare il suo processo di unificazione nazionale e conquistarsi finalmente un posto tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti nel frattempo stavano a guardare, chiusi nel loro prudente isolazionismo, godendo dell’avvio di una fase di intenso sviluppo economico, oltreché della travolgente comicità di Chaplin.
La generosità americana a sostegno dell’Europa minacciata dal Kaiser e dai suoi alleati non si limitò alla fornitura di derrate alimentari, prestiti, materie prime, armi e munizioni, ma si estese anche alle risate. Le comiche di Chaplin una volta sbarcate in Inghilterra nel 1914 si diffusero in Francia ed in Italia come un potente antitodo agli orrori della guerra. Gli imperi centrali non poterono invece godere della corroborante comicità chapliniana, si rassegnarono ad affrontare il conflitto dilapidando tutte le loro riserve interne di risate. Intorno alla metà del 1915, il vagabondo fu ribattezzato Charlot dal distributore francese Jacques Haïk per renderlo ancor più familiare al grande pubblico. Al di là dei nomi, il personaggio ideato da Chaplin riusciva, da una parte all’altra dell’oceano, tra i reduci delle trincee come tra i lavoratori nel loro giorno di riposo, a strappare ben più di una risata, a fare breccia nei cuori con la sua romantica malinconia, addirittura a sollevare, quasi inconsapevolmente, temi sociali con una pungente ironia. Ad esempio in Work (Charlot apprendista), vestendo i panni di uno svagato decoratore vessato da un tirannico datore di lavoro, Chaplin offrì una rappresentazione dello sfruttamento del lavoro. Memorabili le sequenze iniziali in cui l’apprendista Charlot arranca su di una ripida salita, trascinando un traballante carretto ingombro di materiali, scale, pennelli, bidoni di vernice e quant’altro su cui troneggia il suo terribile boss munito di una frusta che non esita ad usare.
Nell’ultimo periodo della sua collaborazione con la Essanay Chaplin accarezzò l’idea di sviluppare questo filone sociale, sfruttando l’estremo realismo per dare corpo ad una comicità che fosse quanto più vicina possibile al suo pubblico. Lavorò al progetto di un lungometraggio intitolato Life, ma ben presto abbandonò le riprese, forse temendo di eccedere con i toni cupi. Non rinunciò comunque ad un certo dissacrante cinismo in Police (Charlot ladro). Il film si apre con Charlot che esce di prigione, una didascalia spiega il contesto: “ancora una volta in balia della infinita crudeltà del mondo”.
Sul finire del 1915, mentre sul fronte italiano si esaurivano senza alcun esito la terza e la quarta offensiva del generale Cadorna sull’Isonzo, le preoccupazioni artistiche di Chaplin si intrecciarono con quelle economiche. I 350.000 dollari offerti dalla Essanay per un rinnovo contrattuale di un anno esprimevano realisticamente il valore raggiunto dalla sua popolarità oppure rappresentavano poco più di una mancia in confronto alle dimensioni del suo successo? Trovò la risposta definitiva all’interrogativo che lo tormentava attraversando in treno gli Stati Uniti, ad ogni stazione tra Los Angeles e New York folle in tripudio erano assiepate ad accoglierlo. L’amore del pubblico per il suo personaggio appariva assoluto ed incondizionato. Il vagabondo era già diventato un’icona, i suoi tratti distintivi: bombetta, baffetti, bastoncino, scarponi, silhouette, andatura, ispiravano, nel vecchio e nel nuovo continente, canzoni, balli, cartoline, fumetti, spille, cartoni animati, bambolotti, giochi e persino dolciumi; un merchandising smisurato su cui i fratelli Chaplin tentarono, senza troppa fortuna, di affermare un diritto di sfruttamento in esclusiva.
Le grandi case di produzione, Universal, Famous Players, Vitagraph, Fox, Triangle, ovviamente non rimasero indifferenti, si affrettarono a contendersi il re Mida della celluloide, tempestandolo di offerte, una più generosa dell’altra. In questo gioco al rialzo si impose una compagnia fondata appena tre anni prima, la Mutual Film Corporation, con un’offerta di 670.000 dollari. Chaplin si dichiarò finalmente soddisfatto accettando la cifra più alta mai concessa fino ad allora ad una singola star.
Il contratto fu perfezionato il 26 febbraio 1916, cinque giorni prima, a Verdun, sulle sponde della Mosa, a circa 250 chilometri ad ovest di Parigi, le artiglierie tedesche avevano incominciato a martellare le posizioni francesi, annunciando una massiccia offensiva. Le sorti della battaglia oltreché della guerra apparivano quanto mai incerte. Fort Douamont, uno dei baluardi del sistema difensivo francese, era appena stato espuganto dalle truppe al comando del Kronprinz Guglielmo.
La Francia gettava nella mischia tutte le sue residue risorse e lottava per la vita, intanto i giornali americani, nelle pagine interne, si ingegnavano a proporre i più disparati termini di paragone per esprimere l’entità del compenso ottenuto da Chaplin. Secondo il Globe Commercial Advertiser di New York il comico inglese possedeva ormai “…tanto denaro da permettergli di comprare le uniformi nuove per tutto l’esercito alleato …” se solo l’avesse voluto. Il Picture-Play Magazine si avventurava in un calcolo ancora più ardito: “Se un uomo riesce a percepire un compenso annuo tanto al di sopra del mezzo milione di dollari che con quello che avanza potrebbe pagare lo stipendio al Segretario di stato per quattordici anni, vivere felice con quello che rimane per dodici mesi …, quell’uomo merita tutta la nostra fiducia.” La stessa Mutual si preoccupava di diffondere a scopo pubblicitario un curioso conteggio: “Ogni ora che passa fa cadere nelle tasche di Chaplin settansette dollari e cinquanta centesimi; e se gli servisse un nickelino per il tram, ci metterebbe solo due secondi per guadagnarlo.”
Tanto improvviso interesse per i guadagni di Chaplin finì per alimentare la leggenda della sua avarizia. A nulla servirono i suoi generosi assegni versati per opere di beneficienza. Un giornalista scrisse: “La sua unica stravaganza è un’auto a 12 cilindri: non si concede nemmeno il lusso di una moglie. Gioielli, cavalli di razza, compagnie rumorose, case di campagna, objects d’art e le altre costose manie dei ricchi più aggressivi non interessano questo giovane attore magrolino che in meno di 5 anni è passto dall’oscurità al rango del salariato più pagato del mondo… . Le sue spese lo scorso anno sono state notevolmente inferiori a 500 dollari e non ci sono indicazioni che il nuovo contratto gli abbia fatto girare la testa: caso mai lo ha spinto ad essere più parsimonioso. La sua teoria può non essere quella di vivere semplicemente e nutrire elevati pensieri, ma rimane il fatto che vive semplicemente, a meno che non sia qualcun altro a pagare il conto.”
Una volta raggiunta la ricchezza lo stile di vita di Chaplin non era poi così spartano, soprattutto a confronto di quello dei suoi coetani europei costretti a vestire l’uniforme ed a soffrire il freddo e la fame in trincea in attesa che un assalto decidesse della loro sorte, amava il lusso, ma non l’ostentazione, odiava lo sperpero, ma vestiva con ricercatezza, offriva di rado dei ricevimenti, ma non per questo rinunciava né alle comodità di una grande casa, né alle cure di un maggiordomo, né ad pittoresco chauffeur giapponese a cui affidare le sue fuori serie.
Le insinuazioni circa la sua avarizia accesero a loro volta l’interesse del pubblico sulle sue origini razziali. Già nel 1915 alla domanda di un giornalista a proposito della sua presunta ascendenza ebraica Chaplin aveva risposto cortesemente: “Non ho questa fortuna”. Non aveva mentito per opportunismo. Effettivamente, come ha dimostrato David Robinson dopo un’attenta analisi, anche risalendo di quattro generazioni tra i suoi antenati Chaplin non avrebbe potuto trovare legami con l’ebraismo. Tale smentita non era stata certo sufficiente a fugare ogni dubbio. Soprattutto dopo la firma del principesco contratto con la Mutual, i suoi capelli ricciuti, la fama di essere parsimonioso, di avere un gran fiuto per gli affari e la sua indubbia genialità convinsero una parte del pubblico e della critica ad attribuirgli un’origine ebraica. Ancora negli anni ’50 un autorevole storico del cinema come Georges Sadoul considerava l’origine ebraica di Chaplin come un dato assolutamente certo. Persino Hannah Arendt, in un saggio edito in Italia nel 1981 con il titolo “Il futuro alle spalle”, si è avventurata ad enfatizzare il profondo legame tra Chaplin e la cultura ebraica.
Anche la clausola sui rischi bellici prudentemente inserita dalla Mutual nel contratto ebbe pesanti ripercussioni sull’immagine pubblica di Chaplin. Tale clausola, corredata da un’assicurazione sulla vita del comico del valore di 250.000 dollari, prevedeva che Chaplin non potesse lasciare gli Stati Uniti senza l’autorizzazione della compagnia prima della scadenza del contratto annuale, in modo tale da evitare un eventuale arruolamento nell’esercito britannico. Nel gennaio del 1916 la Gran Bretagna aveva infatti introdotto la coscrizione obbligatoria per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 41 anni, cessando di affidare le sue sorti unicamente all’arruolamento volontario che pure aveva fornito un consistente afflusso di uomini nelle file dell’esercito. Fin dall’agosto del 1914 il ministro della Guerra, il generale Kitchener, aveva promosso un’efficacissima campagna di stampa, di cui la sua stessa effigie era diventata il simbolo, che aveva portato alla costituzione in tutto l’impero dei Pals battalions, reparti costituiti da gruppi di amici, di compagni di scuola e di club, di colleghi d’ufficio o di fabbrica che avevano lasciato volontariamente le loro case per combattere fianco a fianco. Pertanto, ancor prima dell’introduzione della leva obbligatoria la posizione del comico rispetto alla guerra poteva apparire quanto meno sospetta all’opinione pubblica inglese, abituata a considerare come un imperativo morale la spontanea mobilitazione di tutti i giovani in età militare.
Lo sdegno manifestato, nel marzo del 1916, dall’influente quotidiano londinese Daily Mail per la clausola sui rischi bellici amareggiò profondamente Chaplin, ma non compromise la sua creatività artisitica. Non appena si insediò nel modernissmo studio Lone Star, messogli a completa disposizione dalla Mutual nel quartiere di Colegrave a Los Angeles, si immerse nuovamente in un lavoro frenetico e dimenticò, almeno per qualche tempo, maldicenze, accuse e polemiche. Con il primo film, The Floorwalker (Charlot commesso), mise insieme uno staff tecnico di prim’ordine, in cui spiccava l’ingegnoso operatore Roland Totheroh, ed una valida compagnia di interpreti. Edna Purviance rimase l’indiscussa prima donna, Leo White, lasciata la Essanay, tornò a vestire i panni del nobil uomo dai modi raffinati, Eric Campbell sostituì Bud Jameson nella parte del gigante dalla faccia feroce, Albert Austin, un vecchio routinier della Karno, arricchì con il suo volto patibolare la galleria dei possibili contrasti comici con il sorriso ineffabile di Charlot. L’ampia autonomia concessagli dalla Mutual gli consentì di adottare un metodo di lavoro scrupoloso, assolutamente rivoluzionario rispetto agli standard qualitativi della cinematografia dell’epoca. La scelta dell’ambientazione delle sue comiche non fu mai casuale, ma mirata ad ottenere precisi effetti comici. In un’intervista rilasciata al Los Angeles Sunday Times dichiarò: ”E’ facile … ambientare una gag esilarante in una sala da biliardo o in una panetteria; una stanza da bagno possiede un umorismo implicito; al solo pensiero di una bottega di un impagliatore di animali viene da ridacchiare; un taxi, ribattezzato per scherzo ‘la delizia del mariolo’, è potenzialmente buffo… .” Poteva far costruire, smontare, modificare e rimontare un set decine di volte prima di decidersi a girare e una volta realizzate le riprese poteva sperimentare infinite varianti della stessa scena finché non maturava la convinzione di aver raggiunto la perfezione. Tanta attenzione ai dettagli ed alle sfumature espressive sarebbe stata considerata dalla Essanay ed ancor più dalla Keystone un inutile spreco di pellicola e di dollari, al contrario Chaplin ne fece la sua cifra artistica.
Dopo aver costruito The Floorwalker intorno al potenziale comico della scala mobile di un grande magazzino, dopo aver sfruttato in The fireman (Charlot pompiere) pertiche, veicoli ed attrezzature antincendio per ricavarne irresistibili gag, Chaplin tornò in The vagabond (Il Vagabondo) a mettere in risalto gli aspetti romantici del suo personaggio. La sapiente miscela tra risate e sentimentalismo, tra realismo e trasposizione della realtà continuava ad incantare il pubblico, anche in Europa, dove la guerra aveva ormai assunto le proporzioni di una inutile strage di cui nessuno era più in grado di prevedere la fine. Nel tentativo di alleggerire la pressione tedesca su Verdun l’alto comando alleato aveva lanciato un’offensiva lungo il fiume Somme, in Piccardia. La prima giornata di battaglia, il 1° luglio 1916, era costata all’esercito britannico circa 20.000 morti ed oltre 40.000 feriti.
L’estrema cura produttiva di Chaplin non pregiudicò gli impegni assunti con la Mutual: a ritmo mensile nuove comiche affluirono alle sale. Il personaggio di Charlot venne declinato in tutte le sue sfaccettature, offrendo nuove occasioni di espressione al virtuosismo comico di Chaplin ora nelle vesti del solito ubriaco in One A.M. (Charlot rientra tardi), ora in quelle di un impiegato del banco dei pegni che ausculta una sveglia come se fosse un paziente in The Pawnshop (Charlot usuraio), oppure in quelle di un flessuoso pattinatore in The rink (Charlot pattinatore).
Nell’autunno del 1916, quando il bilancio finale dell’offensiva sulla Somme registrava per gli anglo-francesi circa 620.000 perdite tra morti e feriti, nella valanga di ringraziamenti, lodi, dichiarazioni d’amore, richieste di denaro e proposte di matrimonio che ogni giorno intasava la casella postale di Chaplin incominciarono a comparire anonimi insulti e piume bianche, simbolo di codardia. Prima dell’istituzione della coscrizione obbligatoria per le strade di Londra si aggiravano gruppi di zelanti fanciulle pronte a consegnare una piuma bianca a tutti i giovani che ancora non si fossero arruolati.
L’atteggiamento ostile di una parte del pubblico inglese crebbe nel corso del 1917, fomentato dalla stampa, in particolare dal Daily Mail, di proprietà di Lord Northcliffe, probabilmente animato da un rancore personale nei confronti del comico. Il gruppo editoriale a cui faceva capo il Daily Mail aveva infatti incautamente acquistato i diritti per la pubblicazione in Gran Bretagna di una biografia non autorizzata di Chaplin. L’opera, che si annunciava come un best seller, era stata ricavata mescolando elementi di pura invenzione, come ad esempio la nascita di Charlie in territorio francese, con dichiarazioni autentiche rilasciate da Chaplin nel corso di una lunga intervista ad un giornale di San Francisco. Messo a conoscenza della pubblicazione di un’opera che giudicava lesiva della sua immagine ed offensiva per la sua famiglia, Chaplin diede immediatamente mandato ai suoi legali di intervenire. La sentenza di un giudice di New York pose termine alla questione, condannando la casa editrice americana per calunnia e diffamazione a mezzo stampa. Lord Northcliffe si trovò quindi proprietario dei diritti di un libro che non poteva dare alle stampe e non esitò a vendicarsi, dipingendo Chaplin come un vigliacco che accumulava immense ricchezze mentre il suo paese si stava dissanguando sul fronte occidentale.
Nel giugno del 1917, quando ormai gli Stati Uniti avevano messo da parte il loro tradizionale isolazionismo per schierarsi contro la Germania, Lord Northcliffe dalle colonne di uno dei suoi giornali lanciò un velenoso attacco: “Anche se di esile corporatura, Charles Chaplin è ben saldo sulle gambe, come dimostrano le sue acrobazie sullo schermo; e il modo con cui corre su e giù per le scale fa pensare che sarebbe bravissimo ad arrampicarsi sull’albero maestro al fischio del nostromo. Nei trentaquattro mesi di guerra, pare che Chaplin abbia guadagnato molto più di 125.000 sterline…(…) E’ stato affermato che Chaplin ha investito 25.000 sterline nel prestito di guerra britannico, ma la voce non ha avuto conferma. Del resto come può Chaplin negare al suo paese il suo denaro e i suoi servigi? Se Charlie si arruolerà, com’è suo dovere, almeno altri trenta cittadini britannici di età adeguata che stanno ora lavorando come artisiti negli Stati Uniti non avranno più scuse per starsene lontani dall’esercito del loro paese. Nessuno vuole che Chaplin si arruoli se i medici militari lo troveranno inabile al servizio, ma fino a che non si sottopone alla visita rimarrà il sospetto che si consideri dotato di speciali privilegi e autorizzato ad eludere le responsabilità dei comuni cittadini britannici. Forse il noto attore dello schermo non avrà avuto il tempo di pensarci, e sarà dunque grato che una simile occasione si sia presentata per ricordarglielo. Charlie con l’uniforme kaki sarebbe senza dubbio una delle figure più popolari dell’esercito… . E se risultasse inabile al servizio in trincea, potrebbe fare un ammirevole lavoro nell’intrattenere le truppe. In ogni caso, è dovere di Charlie Chaplin quello di arruolarsi e di mostrarsi fiero delle sue origini britanniche. Pensiamo naturalmente alla forza del suo esempio, non al valore intrinseco del suo eventuale contributo. Vinceremo anche se senza Charlie, ma, come direbbero milioni di suoi ammiratori, preferiremmo vincere con lui.”
Nonostante la mobilitazione patriottica seguita alla dichiarazione di guerra alla Germania, le insinuazioni di Lord Northcliffe non allontanarono il pubblico americano dalle sale in cui si proiettavano le ultime avventure del vagabondo. In diverse località degli Stati Uniti i gestori dei cinema si lamentarono di essere costretti a rinforzare le poltrone, messe a dura prova dalle scomposte risate suscitate dalle comiche chapliniane. Anche tra i fanti europei in trincea la popolarità di Charlot rimase intatta, anzi addirittura crebbe, tanto che l’alto comando britannico si sentì in dovere di introdurre il formale divieto per i soldati di portare i baffetti alla Charlot: ne andava della serietà della guerra. Alcuni medici militari arrivarono ad attribuire a Charlot effetti taumaturgici: le sue gag potevano spingere feriti immobilizzati a letto a scattare improvvisamente in piedi, sospinti da irrefrenabili risate.
Easy street (La strada della paura), The cure (La cura miracolosa), The immigrant (L’emigrante) riscossero un enorme successo, rafforzando la determinazione di Chaplin a diventare un regista indipendente e produttore di sé stesso. Nel giugno del 1917, mentre la prima divisione americana si accingeva a sbarcare sul suolo francese, Chaplin firmò con la First National Exhibitor’s Circuit, una società appena costituitasi con l’intento di insidiare il monopolio distributivo della Paramount, un lucroso contratto che gli garantiva uno stipendio di oltre un milione di dollari l’anno ed una completa indipendenza artistica e produttiva.
La cifra di un milione di dollari non suscitò eccessivo clamore poiché un’altra star, Mary Pickford, l’aveva già ottenuta l’anno precedente, tuttavia Chaplin non poté continuare ad ignorare le accuse di codardia. Nell’agosto del 1917, mentre stava ultimando, ancora per la Mutual, le riprese di The adventurer (L’evaso), ritenne opportuno rilasciare una dichiarazione alla stampa: “Sono prontissimo a rispondere al richiamo del mio paese e sarò lieto di svolgere il mio servizio militare nei modi che le autorità riteranno più utili e opportuni, ma come migliaia di altri cittadini britannici debbo aspettare gli ordini della nostra ambasciata a Washington. Nel frattempo, ho investito duecentocinquantamila dollari nei titoli di guerra inglesi e americani… . Mi sono iscritto all’ufficio leva, e non ho chiesto esenzioni né favori. Se mi avessero chiamato sarei andato al fronte come qualunque altro cittadino che ama il suo paese. Per ora, aspetto ordini dal governo britannico tramite l’ambasciatore.”.
L’ambasciata britannica si affrettò a fornire ulteriori chiarimenti per placare le polemiche: “Non cosidereremo renitente il signor Chaplin, almeno finché non riceveremo istruzioni di mettere in atto la coscrizione obbligatoria e finché non avrà rifiutato di combattere. Ovviamente il signor Chaplin potrebbe presentarsi come volontario, ma riteniamo che possa essere più utile al paese guadagnando molto denaro e investendendolo in prestiti di guerra, specialmente in un momento in cui non risulta vi sia un bisogno pressante di truppe fresche da mandare in trincea. Ci sono modi e modi di fare il proprio dovere, e non può definirsi renitente o codardo chi sottoscrive con grande generosità ai prestiti bellici e alla Croce Rossa, affermando nel contempo di essere pronto ad andare in trincea non appena verrà chiamato.”.
Le piume bianche continuarono tuttavia ad essere recapite a Chaplin e non scomparvero neppure quando una commissione medica lo dichiarò inabile al servizio militare per insufficienza di peso. I giornali, a cominciare a quelli di Lord Northcliffe, furono però costretti a cessare ogni campagna denigratoria nei suoi confronti.
Terminate le riprese di The adventurer, Chaplin si concesse una lunga vacanza alle Hawaii, la prima dopo anni di intenso lavoro. Edna lo accompagnò nella vana speranza di riaccendere la passione in una relazione che si stava ormai spegnendo. La mente di Charlie era infatti assorbita dai progetti per la realizzazione del suo nuovo studio, situato in una delle zone più prestigiose di Hollywood, all’angolo tra il Sunset Boulevard e La Brea Avenue. Nell’autunno del 1917 diede l’avvio ai lavori che terminarono nel gennaio dell’anno successivo. Non fece economie, investì oltre 500.000 dollari per dotarsi di una struttura all’avanguardia dal punto di vista tecnico. Curò persino l’aspetto estetico dello studio, al posto delle solite baracche in cui ricavare magazzini, camerini, ed uffici fece edificare dei graziosi cottage in stile inglese, che ottennero l’apprezzamento della raffinata élite di La Brea.
Pochi giorni dopo l’inaugurazione del nuovo studio iniziò la lavorazione di I should whorry, destinato a diventare celebre con il titolo definitivo di Dog’s life (Vita da cani). Ancora una volta Chaplin seppe fondere realismo e comicità accostando la lotta per la sopravvivenza del vagabondo a quella di un buffo cane randagio. Il film uscì nelle sale americane nell’aprile del 1918, in quei giorni l’azzardo strategico di Ludendorff e di Hindemburg sembrava avere successo. Le forze dell’Intesa, in cui il contributo delle truppe americane era ancora marginale, si stavano ritirando su tutto il fronte occidentale, abbandonando sul terreno uomini e materiali: da meno di un mese la Germania aveva lanciato l’offensiva di primavera. Il crollo della russia zarista, dopo la rivoluzione bolscevica del novembre 1917, aveva reso disponibili all’alto comando tedesco preziose risorse con cui tentare di risolvere il conflitto.
L’imprevedibile colpo di coda del militarismo tedesco, che non si rassegnava alla sconfitta ed anzi si mostrava quanto mai determinato a trionfare, convinse il presidente Wilson a lanciare la terza campagna a favore del prestito di guerra. Il compito di convincere il popolo americano a contribuire con i propri risparmi allo sforzo bellico ed alla difesa degli ideali democratici fu affidato alle stelle più luminose di Hollywood: Mary Pickford, l’attrice più pagata e desiderata d’America, Douglas Fairbanks, l’incarnazione dell’eroe romantico ed avventuroso, e Charlie Chaplin, la maschera comica che aveva conquistato il mondo intero. A Washington i tre attori attraversarono trionfalmente le vie della città sino ad un campo da football, dove li attendeva una folla in delirio. L’emozione di dover prendere la parola difronte ad un pubblico così vasto tradì Chaplin che si rese protagonista di una involontaria gag cadendo dal palco e travolgendo un giovane vicesegretario alla Marina, Franklin Delano Roosevelt, all’epoca ancora ben saldo sulle gambe. A New York oltre trentamila persone si accalcarono all’incrocio tra Broadway e Wall Street per acclamare i loro idoli. Amplificato da un megafono Chaplin trovò il coraggio di arringare la folla: “Chiedo a voi qui presenti di dimenticare tutto sulle percentuali di questo terzo prestito di guerra. La vita umana è in pericolo, e nessuno deve preoccuparsi del tasso d’interesse che i buoni possono fruttare né di quel che si può guadagnare acquistandoli. C’è bisogno di denaro per sostenere il grande esercito e la marina dello zio Sam. In questo momento la Germania sta prendendo il sopravvento, e noi dobbiamo avere i dollari che ci permetteranno di intervenire in Europa e di cacciare quel vecchio diavolo del Kaiser fuori dalla Francia!” Dopo il successo di New York le stelle si separarono, Charlie proseguì per gli stati del sud, dalla Virginia al Missisippi, Douglas e Mary, marito e moglie, si occuparono invece della propaganda nel nord del paese.
L’atmosfera patriottica respirata in quel mese trascorso attraversando gli Stati Uniti convinse Chaplin a mettere in cantiere un progetto che accarezzava da tempo: ambientare una comica tra il fango delle trincee. La sfida di strappare risate su di una tragedia come la guerra che stava insaguinando il pianeta si rivelò molto ardua. Alla fine di maggio del 1918, con il titolo provvisorio di Camouflage, diede il primo ciak, seguendo un abbozzo di sceneggiatura che prevedeva tre atti: la vita civile di Charlot, oppresso da una moglie tanto dispotica da fargli accogliere la cartolina precetto come un’insperata liberazione, la visita di leva, preludio alla dura vita del fronte, ed infine un banchetto offerto dai leader dell’Intesa in onore del coraggio di Charlot che da solo era stato capace di catturare niente meno che il Kaiser. Nell’ultimo fotogramma le pedate di un feroce sergente istruttore avrebbero dovuto risvegliare la recluta Charlot dai suoi assurdi sogni di gloria.
Le scene della vita civile e della visita medica, benché conservino ancora oggi una certa verve, non convinsero del tutto Chaplin che decise di tagliarle subito dopo averle girate, sostenendo i costi di oltre un mese di lavorazione sprecato. Mutò quindi il titolo in Shoulder arms (Charlot soldato) e stravolse la storia che aveva ideato, scegliendo coraggiosamente di incentrare la narrazione sulla trasposizione in chiave comica della vita quotidiana dei fanti in trincea. Senza badare a spese fece realizzare una perfetta riproduzione delle fangose trincee del fronte occidentale, affidando alla comicità surreale del soldato Charlot il delicato compito di controbilanciare il crudo realismo della scenografia. Il vagabondo in uniforme kaki, ma con le consuete scarpacce fuori misura, affronta le privazioni della guerra con una trappola per topi appesa al taschino ed una grattugia su cui strofinare la schiena quando i pidocchi si fanno troppo molesti; semina il panico tra i feroci unni lanciando sulle loro teste un formaggio puzzolente ricevuto come sgradito dono; riesce ad addormentarsi placidamente in un ricovero allagato, dopo aver sprimacciato il guanciale e soffiato sulla candella che galleggia sull’acqua, ad infastidirlo è soltanto il russare di un commilotone; stappa bottiglie ed accende sigarette sfruttando l’infallibile precisione dei cecchini nemici; anticipando le gesta del sergente York, cattura frotte di giganteschi tedeschi comandati da un irascibile ufficiale poco più alto di un bambino, si mostra generoso regalando sigarette ai prigionieri, ma somministra una sonora sculacciata all’ufficiale tracotante; si camuffa da albero e si avventura nella terra di nessuno, salva la virtù di una ragazza francese, interpretata dall’immancabile Edna, e finisce per prendere in trappola il Kaiser, Hindemburg ed il principe ereditario: poi si desta dal sogno e si ritrova al campo di addestramento reclute.
Terminate le riprese, ulteriormente rallentate dalla produzione di The bond (Il prestito), un breve e anodino film di propaganda a sostegno del prestito di guerra, Chaplin fu colto da un improvviso ripensamento, temette di aver goffamente parodiato l’atrocità della guerra, arrivando persino a meditare di distruggere tutto il girato. Si rese conto dell’errore che stava per commettere solo quando il suo amico fraterno Douglas Fairbanks rise fino alle lacrime in occcasione della prima proiezione privata. Le sue risate anticiparono quelle di milioni di spettatori in tutto il mondo.
Shoulder arms uscì nelle sale il 20 ottobre 1918, quando le forze alleate stavano per trionfare sugli imperi centrali, ottenendo subito un clamoroso successo, forse uno dei più grandi della carriera di Chaplin. Il critico francese Louis Delluc scrisse: “Questo film giustifica tutte le speranza del cinema. Siamo veramente nel campo del prodigioso dell’illimitato…” Con minor enfasi, ma con altrettanta sincerità, milioni di combattenti che avevano vissuto orrori e sofferenze tributarono al vagabondo la loro eterna riconoscenza per essere riuscito a portare un barlume di gioia nei momenti più tragici della loro esistenza. Ai loro occhi, indossando l’uniforme ed imbracciando il fucile Charlot aveva contribuito alla vittoria finale più di chiunque altro.
Bibliografia
CHARLES CHAPLIN, La mia autobiografia, Milano, Mondadori, 1964
CHARLIE CHAPLIN (a cura di K. J. HAYES), Opinioni di un vagabondo. Mezzo secolo di interviste, Roma, Edizioni minimum fax, 2007.
DAVID ROBINSON, Chaplin. La vita e l’arte, Venezia, Marsilio, 1987.
DAVID ROBINSON, Chaplin. Un uomo chiamato Charlot, Trieste, Electa Gallimard, 1995.
GEORGES SADOUL, Vita di Charlot, Torino, Einuadi, 1952.
GIORGIO CREMONINI, Charlie Chaplin, Milano, Editrice Il Castoro, 1995.
KENNETH ANGER, Hollywood Babilonia, Milano, Adelphi, 1979.
MARTIN GILBERT, La grande storia della prima guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1998
0 notes
Text
sede: Museo MAGMMA (Villacidro).
L’esposizione raccoglie i disegni realizzati di Walter Lazzaro (1914-1989) durante il periodo d’internamento avvenuto tra il 1943 e il 1944 in Polonia. Qui Lazzaro fu imprigionato prima nel lager Biala Podlaska (con il numero di matricola 55930) e poi in quello Nürberg Langwasser.
L’esposizione è una sorta di diario per immagini di quei giorni, quando Lazzaro, spesso nella penombra e con mezzi di fortuna come avanzi di matita o di gessetti, tratteggiava la desolazione e l’orrore per un’umanità annientata e senza più diritti.
Una testimonianza preziosa, ma anche un monito affinché tragedie come quelle dell’Olocausto non si ripetano mai più, che è stata posta al pari di altre grandi opere di guerra come “Guernica” di Picasso, “Disastri della guerra” di Goya, o i quadri della Shoah di Anton Zoran Music.
Disegni dalla potenza dirompente, che hanno fanno parte della mostra allestita a Roma, nel Chiostro del Bramante, nel 2014 con il titolo “Lo stupore del silenzio”, un’antologia dedicata alle opere di Walter Lazzaro in occasione del centenario della nascita.
Walter Lazzaro fu internato nel lager di Biala Podlaksa insieme agli altri Granatieri di Sardegna, di stanza in Macedonia. Apparteneva a quelle migliaia di soldati arrestati poiché considerati traditori di Hitler visto che, dopo l’8 settembre 1943, non aderirono più né alle SS né alla Repubblica Sociale.
#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Walter Lazzaro. La misura dell'Infinito sede: Museo MAGMMA (Villacidro). L'esposizione raccoglie i disegni realizzati di Walter Lazzaro (1914-1989) durante il periodo d'internamento avvenuto tra il 1943 e il 1944 in Polonia.
0 notes