#meglio che non sappiano da dove arrivano
Text
Io lo sapevo che stavo sbagliando a non mettere più il watermark sulle gif
#vabbè vista la sanità mentale media#meglio che non sappiano da dove arrivano#tenitavelle#care care#anche se rubare le gif è sempre una roba#stronza#sapevatelo
4 notes
·
View notes
Text
Se avete amato Avatar forse amerete anche questi libri
L’uscita di Avatar la via dell’acqua a così tanti di distanza dal primo film della serie con gli alieni blu di James Cameron ha senza dubbio scosso il mondo del cinema grazie alle sue incredibili visuali. Credo che tutti conoscano il film Avatar (sia il primo che il secondo) e credo anche che tutti sappiano che si tratta di un soggetto originale, non tratto da alcun romanzo (se mai al massimo un poco ispirato a Pochaontas e altre storie), ma anni fa del tutto per caso ho scoperto un romanzo scifi con altri alieni blu, una vera e propria saga che parla sempre di invasioni pianetarie, scontro tra due culture molto diverse, e di un umano che suo malgrado viene educato e cambiato da questi alieni pur non potendosi mai integrare del tutto nel loro popolo....e che si innmaora persino di un’aliena. Vi ricorda qualcosa?
Questa saga scifi ha molti punti in comune con Avatar è vero, ma è anche molte diversità, è molto più violenta, cruenta e crudele. Siete avvertiti
La serie composta da tre libri si intitola IN HER NAME, è inedita in italiano, ed è stata scritta dall’autore Micheal R. Hicks:
Link acquisto: https://amzn.to/3iMKMRw
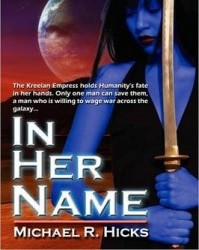
1. Empire (2009)
2. Confederation (2009)
3. Final Battle (2009)
In realtà i tre volumi sono stati anche poi raccolti in un unico volume di circa 600 pagine intitolato IN HER NAME. E io ho letto questo libro unico in effetti, che è un bel mattone, forse leggere i libri separati sarebbe stato meglio col senno di poi.
e nel caso non ne abbiate abbastanza di questo universo esistono anche tre prequel intitolati:
1. First Contact (2009)
2. Legend Of The Sword (2010)
3. Dead Soul (2011)
Come vi dicevo io ho letto solo la trilogia principale, non i prequel, e la trama di questi libri è questa, molto ma molto succintamente:
Trama: Un bambino umano assiste impotente all'arrivo di enormi astronavi sulla sua fattoria e al massacro di parenti, genitori e amici per mano degli alieni, delle donne alte e muscolose dalla pelle blu cobalto, lunghi capelli neri e occhi completamente neri. Senza pietà e con armi primitive queste sgozzano e fanno a pezzi ogni umano, tranne lui, che in un impeto di rabbia osa ferire una loro sacerdotessa. Essa in lui vede un imporante tassello del proprio futuro e lo rilascia. Quel bambino, Reza, cresce perciò orfano in un campo di lavoro mascherato da orfanotrofio, ma le privazioni e le torture, non riescono a spegnere il suo fuoco interiore. Lui stuidia di nascosto per un giorno diventare un soldato e potersi vendicare. Ma gli alieni, chiamati Kreelans, stanno conquistando pianeta dopo pianeta tutto il sistema e arrivano anche dove Reva sta vivendo. Stavolta viene catturato e rso schiavo. Anni di tortura e prove fisiche al limite del'umano lo cambiano, pur contro il suo stesso volere cresce sul pianeta nemico e assimila la loro brutalità per sopravvivere. Il suo odio per loro si attenua e abbraccia la loro cultura, perchè sopravvivere conta più di ogni altra cosa. Arriva a diventare un membro di quella socità ripettato dagli alieni stessi, l'unico umano sopravvissuto alla loro educazione. Reza si innamora ricambiato di un'aliena e per la prima volta è felice, almeno finchè, come guerriero non gli viene chiesto di guidare un attacco contro i soldati umani. Lui nonostante abbia accettato la cultura aliena, non può tradire i suoi fratelli umani, o sì? Il conflitto interiore lo attanagila e solo….
La mia opinione: questo libro enorme, più di 600 pagine, non è un vero e proprio sci fi romance, è più un romanzo di fantascenza che contiene anche una storia d'amore. Potrebbe essere visto come simile ad Avatar per alcuni versi, solo che qui le aliene blu belle snelle muscolose e dagli occhi allungati sono molto ma molto crudeli, come gli antichi Spartani per intenderci. La debolezza non è accettata nella loro società matriarcale militare. Bello il conflitto interiore del protagonista diviso tra la sua umanità, le sue origini, e la cultura aliena che ha in parte abbracciato.
0 notes
Text
Ho letto un post, dove una donna chiedeva a noi uomini come vivevamo l’arrivo di una donna; come possano arrivare a noi le donne e cosa vorremmo “in più” in loro.
Ho risposto così:
Come viviamo l'arrivo di una donna... dipende.
Come arrivano le donna... dipende.
Cosa verremmo trovare in più in una donna... dipende.
Dipende sempre da come ci si comporta e come ci si muove nella vita.
Posso dirti però cosa ho sempre desiderato io.
Ho sempre desiderato due occhi, di quelli che sanno farti arrossire se commetti un errore, che sappiano farti sentire importante quando non hai fiducia in te stesso; ma che sappiano farti sudare freddo quando esprimono veglia e desiderio.
Un cuore, di quelli sufficientemente generosi per accoglierti tutto e farti stare comodo. Un cuore così grande da riporci dentro anche il mio, con tutti i sentimenti e le emozioni che esso prova; uno scrigno pulsante.
Un pensiero, che sia il più ampio possibile senza confini. Che sappia esplorare, che abbia sete di conoscenza e che cerchi sempre il confronto onesto e leale.
Più che ammirare le gambe preferisco il sorriso, più che perdermi sulle sinuose curve cercherei di comprendere i suoi silenzi. Perché il silenzio, a volte, vale più di mille parole.
Posso sembra scontato, me ne rendo conto, eppure ho sempre sognato di colorare la vita di una donna, invece di renderla grigia. Mi farei colorare volentieri la mia, anche con colori accesi, nonostante adori anche le atmosfere dark.
Ho sempre cercato due labbra, di quelle che incantano, che raccontino tanto e a volte niente. Due labbra che chiedono, che spieghino, che cerchino.
Ho sempre desiderato di incontrare un carattere che sappia scherzare come un bambino, ma anche essere tremendamente serio quando necessita.
Una personalità decisa, che sappia essere sincera quando è dubbiosa e fragile chiedendo protezione.
Di una cosa sono sicuro che non è facile amare veramente una donna, ci vuole tanto impegno e coraggio, il resto sono solo avventure.
Credo che forse, in fondo, abbia sempre desiderato di essere un uomo migliore per rendere interessante e piena di soddisfazioni la vita di una donna.
Prima di aspettarsi qualcosa in più da una donna, dovremmo imparare e capire se noi siamo in grado di reggere quel "di più", altrimenti meglio non aspettarsi niente se non delle delusioni.
27 notes
·
View notes
Text
“Un artista è sempre in pericolo, questo è il suo destino”: quando Isaiah Berlin andò a trovare Boris Pasternak (“parlava come un genio, mi sembrava un po’ matto”)
Un grande autore che ha parlato di nazionalismo, tema mai fuori moda, era Isaiah Berlin (1909-1997). Una bibliografia sterminata, la sua, che si staglia ancora per La volpe e il riccio, Le radici del romanticismo e Il senso della realtà, libri editi in Italia da Adelphi. Come ogni autore che si rispetti, Berlin va affrontato nei punti difficili: non solo nei testi famosi, nelle solite nenie dove spiega che questo grande personaggio storico era astuto e aperto (dunque ‘volpe’) mentre l’altro era chiuso e riflessivo (‘riccio’) tagliando la storia a fette. E poi magari i soliti discorsi su quel che è razionale e quel che sfugge al controllo nel primo Ottocento, di qui i nazionalismi e via così. Nossignori, sotto Berlin c’è di più: questo sito di interviste inedite in italiano lo prova.
*
A onor del vero osserviamo che in Italia Berlin godeva di buona stampa da Adelphi perché piaceva all’Avvocato. Cerchiamo però il filo d’oro nel fango dell’opera omnia. Sul sito trovate molte interviste ad argomento ‘nazionalismo’. Berlin sapeva queste cose da dotto, peggio di Herzog nel romanzo di Bellow. Se avete presente Oxford di primo Novecento in Momenti di gloria con quei professoroni espertissimi di Locke, capirete subito dove sguazzava il nostro Berlin quando da Riga – per la spinta della Russia in subbuglio – si trasferì sull’isola inglese e si laureò su Locke. Di qui una rutilante carriera accademica che per lui fu sinonimo del suo lavoro ‘seminale’ (come dicono i dotti) intitolato Due concetti di libertà. Meglio leggere l’intervista del 1991 concessa a Portofino: Due concetti di nazionalismo.
*
L’intervista è fatta con garbo a suon di mazzate: “l’autodeterminazione culturale senza una rete politica che la sorregga – questo è il tema preciso e attuale. Non solo per l’Europa orientale. Baschi e catalani in Spagna, Irlanda del Nord per il Regno Unito, i fiamminghi in Belgio, il Québec in Canada e Israele in terra di arabi. Chi l’avrebbe detto, anche tra gli idealisti di fine Settecento che lanciavano le nazioni? […] alla fine auspico questo: un grado di uniformità nelle nazioni sazie combinato con un buon livello di varietà nel resto del mondo. Ammetto però che la tendenza attuale va all’opposto: autoaffermazione affilata e talvolta aggressiva da parte di gruppi molto ristretti”.
Così ci avviciniamo a capire Berlin che discute di poesia e linguaggio in Pasternak: “credo che il cosmopolitismo sia vuoto, le persone non possono svilupparsi se non appartengono a una cultura, tutte le nuove correnti provengono sempre da qualche sorgente e se questa si secca, quando le persone non sono un più prodotto della loro cultura, quando non hanno né parenti né stirpe e non si sentono più appartenenti al loro gruppo, quando non c’è più la lingua madre – ebbene tutto quel che c’è di umano si dissecca […] se dovessimo arrivare a un linguaggio universale, non solo per scopi politici ed economici ma per conservare e trasmettere scelte emotive, per formare la vita interiore – suppongo che arriveremo tutti a provare lo stesso sentimento mentre guardiamo un concerto di Madonna. Questo non sarebbe il linguaggio universale ma la morte della cultura. Prima si poteva fare esperienza di una saga nordica solo leggendola, non serviva infilarsi in una tempesta del Mare del Nord. Sono felice di essere così anziano da aver provato quella sensazione”.
*
Arriviamo a Pasternak. È divertente immaginarsi queste piacevoli parole pronunciate a Portofino dal professore in vacanza mentre i Balcani crepavano: “nell’età odierna il nazionalismo non sta risorgendo perché semplicemente non è mai morto, proprio come il razzismo. Infatti questi sono i due più potenti movimenti del mondo oggi, e attraversano molti sistemi sociali. […] Continuo a dire che lo spirito del popolo è come un ramoscello quando passate nella boscaglia, lo premete in basso quando passate e lo fate con tanta forza che poi quando lo rilasciate, scatta con furia. Il nazionalismo, almeno in Occidente, viene creato dalle ferite inflitte da questo stress. Quanto all’Europa orientale e all’ex Impero sovietico, sembrano oggi una ferita vasta e ben aperta. Dopo anni di oppressione e umiliazione, c’è spazio per una reazione violenta, uno scoppio di orgoglio nazionale, certamente autoaffermantesi, da parte delle nazioni liberate e dei loro leader […] Oggi Georgiani, Armeni e altri ancora cercano di riprendersi il loro passato sommerso, spinto sul fondo dall’immenso potere imperiale sovietico. Le loro letterature benché perseguitate da Stalin sopravvissero: Isakian e Yashvili furono poeti donati al loro popolo; le traduzioni di Vaz Pshavela e Tabidze fatte da Pasternak sono meravigliose a leggersi. Capite perciò che quando Ribbentrop andò da Stalin nel 1939 si presentò con una traduzione tedesca del poema epico georgiano Il cavaliere con la pelle di pantera di Rustaveli. Chi lo conosce in Occidente? Prima o poi gli schianti per rinculo arrivano, irresistibili. La gente è stanca di essere coperta di sputi e di ricevere ordini da una nazione ‘superiore’. Prima o poi sorgono le domande nazionaliste: ‘perché dobbiamo obbedirgli? Che diritti hanno…? E noi? Perché non possiamo…?’”.
*
Il poema georgiano lo leggete in inglese qui. Le traduzioni italiane ci sono ma non si trovano più. La prima volta che sentii parlare di questo titolo era un venerdì o un sabato sera, ero in un bunker della Normale di Pisa e insieme con un compagno di corso che mi diceva ‘andiamo da Nika, mi ha parlato del suo poema nazionale, ha a che vedere con una pantera’. Aprimmo la porta accanto e trovammo l’amico georgiano che ci confidò di star lavorando a una continuazione della storia di Rustaveli. Ce lo diceva con pudore, mi colpì come l’abbaglio di un popolo innamorato della sua timidezza. Quando tornai a leggere i libri di storia per dovere universitario, mi sembrò che non contassero un grammo di ragione di buon senso. Che ci avessero presentato una versione della storia schiacciata sulla pace ‘contemporanea’. Che tutto ci fosse dovuto, o quasi. Che il georgiano fosse dalla parte giusta e noi europei a due passi dalla cecità. Per riprendermi dalla nebulosa europea ho chiesto all’amico georgiano qualche notizia di costume: laggiù i genitori recitano le più belle strofe del poema ai figli prima delle elementari così che le sappiano a memoria: “quindi molti bambini di 4 o 5 anni sanno a memoria almeno due strofe dove per la prima volta appare il cavaliere principale, Tarieli. Poi alla seconda elementare si comincia a leggere il poema fin dall’inizio e gli allievi fortunati trovano insegnanti che si prendono libertà nelle scelte e leggono più Rustaveli e meno cose attuali: a me è andata così, quindi ciò che ci è rimasto è la letteratura vera e non certi testi di nessun valore che spesso si insegnano alla prima o alla seconda elementare. Se un georgiano non sa a memoria almeno le prime de strofe del quarto canto è una vergogna, penso”. Chiaro? Se aveste ancora bisogno della benedizione chic, leggete queste righe di Eco per convincervi di Rustaveli.
*
Ecco a voi una grande intervista, di quelle discorsive e informali, su Boris Pasternak. Fu condotta a Londra trent’anni fa in russo da Lev Shilov. Nota di passaggio. È curioso trovare un ragionatore come Berlin a dialogo su materie più creative: ma tant’è. Per lui sono un’esigenza di base, anche se poi scriveva in modo molto piano, senza voli. Era pur sempre l’uomo che delle poetesse si invaghiva (vedi Achmatova) quando doveva solo informarsi per ragioni di intelligence su che combinava la Russia. Il testo lo leggete qui, qui trovate il sottotesto palpitante. (Andrea Bianchi)
***
Pasternak aveva due sorelle che vivevano a Oxford, ora una se n’è andata, l’altra c’è ancora, e loro mi diedero un paio di scarponi da consegnare a Pasternak. Non sapevo come raggiungerlo. Quattro o cinque giorni dopo la cerimonia letteraria all’ambasciata andai con Madame Prokofiev e Lina Ivanovna a Peredelkino, dove viveva Pasternak. Stava lì con la moglie. Mi salutò calorosamente, gli porsi gli scarponi e disse “no, no, non sono per me”. Era molto sconcertato. “Non penso che siano per me, non ne ho bisogno, penso debbano essere per mio fratello”. Gli dissi che me li avevano consegnati espressamente le sue sorelle. “Oh allora molto bene, ma non parliamone più”. E parlammo. Parlammo di tutto. Persone come Pasternak e sua moglie e altri scrittori sovietici che avevo incontrato erano sotto l’illusione che tutto a Occidente fosse meraviglioso, ma non ne sapevano nulla. Dovevo fargli capire il contrario, che forse in Russia c’erano persone più talentuose, per quanto la cosa sembrasse strana. Mi chiese di Eliot, Auden, poco della Woolf e di Forster, e molto invece di Herbert Read [1893-1968, Il Significato dell’arte è del 1931], il critico d’arte che era un ‘personalista’ come lui, Pasternak. Gli chiesi cosa significasse questa parola: era un anarchismo personale. Conta l’individuo, il suo mondo. Mi raccontò come andarono le cose quando nel 1935 fu chiamato da Malraux al convegno antifascista quando in quell’occasione c’erano Robert Frost e altri.
Poi gli chiesi cosa stesse leggendo. Disse: “Proust”. Non so chi glielo avesse mandato, ma ne traeva molta delizia, anch’io gli lasciai dei libri inglesi ma non saprei dirti quali. Lo rividi solo in un’altra occasione, due settimane dopo a Mosca. Non so di che parlammo, vedi, era tutto così strano ma il suo modo di esprimersi era straordinario. Parlava come un genio, un mezzo matto, a volte non si capiva nulla, altre volte ti batteva in testa, ti affascinava come nessun’altro. Era quello che più si avvicinava al genio: l’unico che abbia trovato in vita mia. Parlava animatamente, mi diceva che si era servito di Shakespeare, ma non era stato pubblicato. Era il ’45 e mi diede due capitoli dello Zivago perché li consegnassi alle sue sorelle. Diceva che era un lavoro corrotto e che non si era potuto esprimere, ma per la prima volta si sentiva orgoglioso, era una cosa bilanciata, ben scritta, chiara, trasparente. Gli chiesi di Majakovskij: disse che non si amavano ma erano amici e che ne fu influenzato come poeta perché era una persona reale con un’anima umana: per questo i due potevano parlarsi mentre con gli altri non ci si poteva dire nemmeno una parola. Ma non capivo chi fossero le persone alle quali si riferiva. A quel punto la moglie mi disse di non far pubblicare Zivago in Italia, i bambini e tutta la famiglia avrebbero sofferto, mentre lui voleva far conoscere l’opera nel mondo. Gli dissi: “Ascolta, Boris Leonodovich, la porterò con me, certamente, ne prenderò una copia. Le metterò in una scatola da qualche parte, la lascerò, non so, in Uruguay, in Islanda, nel sud del Giappone, in vari paesi. La nasconderò perché possa sopravvivere ad un attacco atomico, ma tu non devi pubblicarla”. “Perché lo dici?” mi chiese. Gli dissi: “Per tua moglie, qui”. E lui: “Ho parlato ai miei bambini, sono pronti a tutto, pronti a soffrire, se deve esser così, che sia. Un artista, lo sai, è sempre in pericolo. Questo il suo destino. Non posso fare altro”. Così capii che gli avevo chiesto qualcosa che non avevo il diritto di domandargli. Presi la copia in mano, la portai alle sorelle e penso che la traduzione italiana sia cominciata allora. Dopo, sai cosa è successo. Ne fu felice.
Isaiah Berlin
*In copertina: Isaiah Berlin in un ritratto fotografico di Cecil Beaton, 1955
L'articolo “Un artista è sempre in pericolo, questo è il suo destino”: quando Isaiah Berlin andò a trovare Boris Pasternak (“parlava come un genio, mi sembrava un po’ matto”) proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2mg4abU
0 notes
Text
Ci sono tante città dalla bellezza un po’ sofisticata, pretenziosi salotti bohémien in cui, come diceva giustamente Andy Warhol, viene prodotto anticonformismo di massa a masse “hipsteriche” che per moda vogliono apparire anticonformiste. Città indubbiamente belle nel loro cuore affaticato da questa obesità commerciale, non si può dire il contrario. Ma che tendono sempre più a diventare un continuum indistinto di non luoghi, tranquillizzanti nella loro familiarità per bovini alimentati in via parenterale con dosi massicce di panico sociale. Città lottizzate nelle loro piazze e in ogni angolo dalle grandi multinazionali dell’abbigliamento, della finanza, dell’alimentazione e sui cui tavolini di cromo luccicante si può indifferentemente assistere alla loro stessa autopsia quanto bere un caffè all’americana. Magari dopo aver ingoiato favole alle benzodiazepine di chi ha delocalizzato nei posti più assurdi, per qualche centesimo in più di profitto, ed ora promette improbabili ridistribuzioni eque e solidali di parte di quel capitale, solo per lucidare la coscienza dei consumatori.
Poi c’è Belgrado.
Per sgombrare il campo da ogni ingenuità retorica, anche questa sorta di ultima Stalingrado è ormai accerchiata e magari prossima a capitolare. Oppure ha già capitolato ma dissimula con malizia. Anche qui puoi ordinare il tuo insipido hamburger ai coliformi fecali, persino prelevare un po’ di Dinari da uno sportello della banca di casa tua, magari la stessa che dilapida i tuoi risparmi con il beneplacito del governo. Eppure Belgrado conserva quell’aura di bellezza autentica e incontaminata, che sembra fluttuare sospesa in un tempo e in uno spazio indefinito. Forse sarà suggestione di un osservatore innamorato di questa città dallo strano fascino, indefinito tra il razionalismo di matrice sovietica e il classicismo mitteleuropeo. O forse è per davvero un tratto comune di quei posti culturalmente e diametralmente distanti dall’Occidente cresciuto sotto le amorevoli cure e il guinzaglio del Patto Atlantico.
La mia partita inizia già verso l’ora di pranzo. Appuntamento con il mio amico Paolo, all’ingresso della stazione. Nonostante non sia molto distante dal mio alloggio, ci metterò più del necessario a raggiungerla: un po’ perché sono ancora stordito dai due voli e dalle pochissime ore di sonno, un po’ perché io e i Serbi abbiamo in comune la scarsa dimestichezza con l’inglese; infine, e lo capirò mio malgrado solo dopo, per gli autoctoni “stazione” corrisponde comunemente ad una qualunque fermata dei mezzi pubblici.
L’antipasto doveva essere Rad Belgrado – Javor delle 14, ma scopriamo che il Rad è costretto a giocare tutte le sue gare a porte chiuse per cori razzisti dei suoi tifosi (galeotti furono i versi della scimmia al brasiliano del Partizan Everton Luiz). Il derby avrà luogo invece alle 18 per cui abbiamo tutto il tempo di ritemprarci nella cucina tipica locale, mettendo tenda allo Zavičaj, una kafana (nella via dedicata a Gavrilo Princip, per chi come me crede alla bellezza del fato) ovverosia il corrispettivo di una nostra trattoria dove si possono mangiare i piatti tipici della cucina Serba, ma secondo gli usi è centrale anche la socializzazione. I miei compagni di ventura avevano già guadagnato un’ottima reputazione in loco andandovi a far colazione a base di Rakija, un superalcolico distillato di prugne che praticamente (bevuto tutto d’un fiato) accompagna ogni momento a tavola, da quando ci si siede a quando ci si alza. A cominciare da quando si deve ancora imboccare la prima forchettata: “per digerire”, ci fanno capire in una sorta di esperanto fatto di inglese, serbo, italiano e gesti, anche se a parte un caffè e una brioche, non hai ancora messo niente nello stomaco da poter digerire.
Sotto la regia dei soci che nell’area est-europea son di casa, passiamo in rassegna Goveđa čorba (una sorta di zuppa di manzo per “aprire” lo stomaco alla pietanza principale), Pljeskavica, Ćevapčići e tutta una serie di portate di carne molto abbondanti ed impegnative, annaffiate da tanta birra e dall’onnipresente Rakija.
Il tempo corre veloce, così io e Paolo ci stacchiamo dal gruppo perché ci toccherà guadagnare l’accredito e l’accesso al campo. I tassisti non ne vogliono sapere di portarci al Marakana, troppo traffico e troppi blocchi stradali in cui non hanno voglia di rimanere incastrati. Alla fine ne convinciamo uno mercanteggiando e alzando la posta a cuor leggero, visto che i prezzi di base dei taxi sono davvero molto bassi: accetta ma ci lascerà ad un bivio ingorgato, indicandoci il resto della strada che ci separa dalla nostra meta.
Scolliniamo dopo una salita e ai nostri piedi, alla nostra vista, si apre lo stadio già brulicante di vita, sotto la protezione di San Sava che domina dall’alto del suo tempio, il più grande della chiesa Ortodossa.
Siamo arrivati con un certo anticipo ed è bello tergiversare nei murales, nell’atmosfera, nella calca e nell’aria del derby che monta man mano che i minuti si susseguono verso l’ora di inizio. La presenza delle forze di polizia è paradossalmente imponente ma discreta al tempo stesso: sono lì a vigilare in ogni angolo, specie i più critici e la sola vista di questi Robocop in cirillico, già mette di per sé timore reverenziale.
Ad un certo punto comincia a salire un po’ di ansia anche a noi che giriamo in tondo, venendo rimbalzati da parte a parte senza trovare il varco giusto per entrare in campo. Alla fine e per fortuna troviamo il tanto sospirato “green gate” di cui aveva parlato l’addetto stampa il giorno prima, mentre il mitologico, lunghissimo ed inquietante tunnel che porta al terreno di gioco è stato notevolmente accorciato nel suo percorso, così dopo un paio di svolte siamo già dentro, abbacinati dal verde brillante del terreno di gioco.
Le due curve appaiono sin da subito cariche, molto cariche, per cui il pre-partita è quasi indistinguibile dall’inizio della gara, se non fosse per il repentino cambio di registro delle tifoserie che imbastiscono le loro coreografie. A dire il vero i Partizan all’inizio resteranno alla finestra e il palcoscenico sarà tutto dei Delije padroni di casa: un tappeto di cartoncini rossi metallizzati copre la curva per la sua intera grandezza, e se cromaticamente appare una scelta un po’ monotona, arrivano a smentita una serie di torce ad intermittenza (“big flash”, come le chiama qualcuno) disposte in maniera tale da comporre la scritta “звезда”, ossia “Zvezda” che è come brevemente i tifosi son soliti chiamare la Crvena Zvezda, la Stella Rossa. Spettacolo suggestivo di cui la reale riuscita è apprezzabile meglio in video, proprio a causa dell’intermittenza delle torce, impossibile da immortalare con delle foto.
La dedica particolare alla squadra non è casuale, ricorre infatti proprio in questi giorni il 72esimo anniversario dalla sua fondazione. A dare ulteriore senso in tali termini è lo striscione che sormonta la vetrata, il quale recita più o meno “Ti diranno che (la Stella) si sta spegnendo, lo diranno proprio coloro che non hanno mai brillato così tanto”. La frase è parte di un coro che gli stessi tifosi canteranno per accompagnare lo spettacolo coreografico e il cui senso si completa con il verso: “Non credere a loro figliolo, sii fiero perché il cuore della Stella batte nel tuo petto”.
Il settore dei Grobari ospiti si presenta invece molto più sobrio ma comunque anch’esso dal notevole impatto visivo per numeri e compattezza. A dir poco impressionanti i battimani: se solo si provasse ad allungare lo sguardo nell’angolo più lontano della Curva, di sicuro ci si troverebbe qualcuno con le braccia alzate a partecipare alle manate. È una particolarità che entrambe le tifoserie condividono ed è per certi versi emblematico di come in questi lidi sappiano conservare questo equilibrio perfetto e risultare, come i vecchi gruppi italiani, autorevoli e trascinanti per tutta la tifoseria, senza cedere a insulsi vaneggiamenti elitaristici, stupidamente auto-referenziali, con i quali ci si è scavati il vuoto attorno e poi la fossa. Il calcio popolare a cui si dice di aspirare, cedendo spesso a quel “nostalgismo” sciatto che ora va tanto di moda, è in realtà un calcio dove centrale è la partecipazione popolare dal basso, estesa e aggregante, non di certo una sfilata settaria di borghesi snob che si credono meglio degli altri, consanguinei o avversari, solo perché sono pochi.
Popolare mi sembra davvero l’adesione all’evento calcistico e il modo in cui la gente lo vive. La passione per la squadra è tanta, vibrante e si tocca con mano ad ogni palpito generato dai movimenti sul campo. Si canta con la voglia visibile di voler incidere sul match e allorquando questo succede, l’esplosione quasi orgasmica di urla, movimenti e colore è qualcosa di davvero eccitante e coinvolgente. È passione vera la loro, c’è amore per la squadra, si sente la gioia delle conquiste e i vuoti della delusione. Non si prova mai nemmeno lontanamente quella straniante sensazione di trovarsi in una fiction, come può capitare di fronte a quei cori sì inarrestabili, ma sincopati, quasi robotici di certe tifoserie sotto steroidi.
Il differente livello di adesione emotiva lo si deduce inoltre scrutando la folla, nella quale, con quanto impegno ci si possa mettere, è davvero difficile trovare persone che anziché cantare o guardare la partita, spendano invece energie e tempo dietro ad un telefonino. A compensare ci penserà il massiccio ed inversamente proporzionale stuolo di fotografi, tantissimi stranieri ed alcuni molesti oltre la soglia della stupidità, tanto che ad un certo punto verranno fatti oggetto di un lancio di rotoli di nastro adesivo.
Salta all’occhio, nella parte di stadio occupata dagli ospiti, soprattutto la prudente divisione attuata da polizia e steward in due gruppi distinti, retaggio del vecchio scontro in atto fra Zabranjeni e Alcatraz: qualche anno fa, proprio durante un derby, i più grossi grattacapi per l’ordine pubblico non vennero tanto per scontri fra le due tifoserie quanto per alcuni incidenti intestini proprio ai bianconeri. Quest’oggi la situazione sembra molto più calma del passato: niente tensioni, niente lancio di torce fra le due parti e addirittura qualche coro cantato in simultanea. Nel pre-partita un coro riesce persino ad accomunare tutti i presenti, da Curva a Curva, a prescindere dalla loro fede calcistica: si inneggia al Kosovo, luogo simbolo della storia ortodossa e nazionale, ferita ancora aperta di fronte a cui nessuno rimane insensibile.
La presenza dei temi politici è molto forte, tanti i riferimenti e una sola la dominante, quella del Panserbismo. Da un certo punto di vista sembra trovarsi al cospetto delle curve italiane degli anni ’80 e ’90 dove la politica era onnipresente, nelle sue varie sfumature. Se questo da una parte può essere reso possibile da una maggiore libertà in materia (a fronte dell’Italia dove è per legge proibito portare allo stadio qualsiasi elemento politico o che non sia strettamente legato alla propria squadra), d’altro canto è una prerogativa tipica Serba e dell’Est Europa in genere, dove per una sorta di reazione fisiologica uguale e contraria all’epoca comunista, c’è un rifiorire di rivendicazioni nazionalistiche molto particolari. Tra le bandiere ce ne sono per esempio diverse di ispirazione Cetnica, dal teschio simbolo dell’Esercito Jugoslavo in Patria al volto del generale Draza Mihajlović.
Allo stesso generale Mihajlović, e contro i Delije, farà riferimento uno striscione esposto nel settore dei Partizan: “Bugarcic, Krcun, Rankovic nel nome della vostra squadra sono morti migliaia di Serbi. Gestori di Goli Otok e assassini di Draza è questo il vostro vero volto”. Qui vertiamo nel campo della storia e la questione è così complessa e sono così pesanti (e in realtà persino un po’ pretestuose) le accuse che è difficile spiegare in breve. Rimandiamo perciò ogni lettore ad approfondire con proprie ricerche e farsi un’idea personale, diciamo solo che Bugarcic, Krcun e Rankovic erano tre dirigenti della Lega dei Comunisti Jugoslavi; Goli Otok invece un’isola al largo della Croazia in cui Tito costruì un bagno penale dopo lo strappo da Mosca nel 1948, in cui furono tradotti principalmente i cosiddetti “Cominformisti”, ossia coloro i quali continuavano a dimostrare fedeltà alla linea del Partito Comunista Russo. Oltre ai membri non allineati del partito stesso, ci finirono a Goli Otok anche criminali comuni e generici oppositori. Chiaramente c’è da immaginare che i metodi o i processi non fossero propriamente democratici, ma al di là di questo non si trattava in alcun modo di persecuzioni etniche nei confronti dei Serbi quanto di persecuzioni politiche. Se di persecuzioni vogliamo parlare. Il grado di coinvolgimento dei tre politici citati in Goli Otok e nella Stella Rossa non è ben chiaro. La morte di Draza Mihajlović, generale dell’esercito monarchico-nazionalista dei Cetnici, quella sì è imputabile a Tito e i suoi. Ma perché debba essere addebitata anche alla Stella Rossa e i suoi tifosi non è ben chiaro, in un’epoca – quella Titoista – in cui entrambi i club erano sotto lo stretto controllo del Partito: non a caso il nome Partizan richiama direttamente alla memoria proprio l’esercito di Tito. Certo restare sobri in questa indistinta suggestione e revisione di simboli e miti politici attuata dalle due tifoserie, cercando di decifrarne fatti reali e evidenze storiche è un esercizio per fini accademici.
Tornando ai Grobari e al tifo vero e proprio, dopo che la partita è avviata da qualche minuto, tirano fuori uno stuolo di bandiere in cui si combinano bianco, nero e grigio in varie fogge. Mentre viene sollevato a mano lo striscione nero in cui dichiarano “Non ho sbagliato quando ho scelto di amare i colori più belli”, inizia una fumogenata nera e bianca a dir poco corposa e spettacolare. È questa la punta massima di esuberanza dei Partizan che, per la sobrietà dei propri colori sociali, non si prestano particolarmente ad irretire l’occhio del fotografo o di qualsiasi osservatore. Il tifo vocale è invece di una potenza e di una continuità che fanno veramente spavento. E le sonorità aspre della lingua Serba non fanno che accrescere la soggezione che incute questa tifoseria quando canta. L’alto livello canoro non viene nemmeno scalfito dal vantaggio che la Stella Rossa trova al 34’ con Kanga e sorprende pensare a quanto poderoso poteva essere se anche la parte di bianconeri nei distinti, i succitati Zabranjeni, avessero partecipato al tifo. Poco e poco continuo il loro apporto, il cui coro più bello è uno a rispondere effettuato assieme al gruppo principale dei Grobari.
Nel secondo tempo altri striscioni verranno srotolati in zona Partizan, oltre a quello di cui ho fatto già menzione. Il primo è davvero enigmatico e difficile da intendersi, recita qualcosa del tipo “I figli di mamma e papà non sono più tifosi, adesso non sono che costruttori”. Cercando spiegazioni fra le mie fonti, che però sono di fede opposta, l’idea è che si riferiscano a esponenti in vista del tifo biancorosso che nel frattempo hanno fatto fortuna e sono diventati imprenditori.
Mentre i padroni di casa non espongono alcuno striscione, gli ospiti hanno ancora un messaggio da mostrare e ancora una volta è dedicato ai loro dirimpettai: “72 anni di falsi miti, delusioni e complessi. Vi auguriamo che questo sia il vostro ultimo compleanno, Tzigani!”. I tifosi della Stella Rossa sono infatti indicati dispregiativamente come Gipsy o Tzigani sin dai tempi dell’unità federale, in special modo dai Croati, che però con tale epiteto erano soliti indicare tutti i Serbi, ma loro ne divennero bersaglio principale in quanto squadra più rappresentativa di quell’area geografica. Mi smo cigani najjaci smo, Noi siamo Tzigani noi siamo i più forti divenne di conseguenza e ben presto la rivendicazione quasi orgogliosa d’identità dei tifosi calcisticamente più noti di Serbia.
Nel secondo tempo, dopo la bella torciata in chiusura di frazione innescata dal vantaggio, mi porto sotto il settore dei Delije. Molto, molto belli da vedersi per l’infinità di bandiere, due aste e drappi di ogni sorta, compreso qualcuno che fa chiaramente il verso agli ultras italiani. Da qui in poi, a più riprese e in più parti delle gradinate, verrà appiccato il fuoco ad una serie di felpe e maglie degli avversari, ipotetici cimeli di guerra. Anche se per quello che ho avuto modo di vedere e sentire, fuori questa volta non è successo niente di rilevante, a parte il corteo bello e indisturbato con cui i Partizan sono giunti al “Marakana”, per cui molto probabilmente si tratta di vecchi trofei. Quello che colpisce è che questi continui roghi, uno dei quali anche nel settore ospiti, assieme agli scavalcamenti di settore di alcuni tifosi, avvengano nella totale indifferenza di steward e polizia, che si limitano ad assistere senza intervenire mai se la situazione non degenera, come avvenuto nel derby scorso in cui molto duro fu il confronto fra le parti e ancor più pesante la coda di arresti. Sì, è stucchevole il continuo raffronto con l’Italia, ma nel nostro caso per operare la cinquantina di arresti della violenta ultima stracittadina balcanica, sarebbero bastati i roghi. Lungi dall’invocare inasprimento di pene ovunque o importare impunità, quanto per una logica riduzione dei danni e dei rischi che ogni operatore di sicurezza pubblica dovrebbe sempre tenere bene in mente di fronte a tali considerevoli masse di persone.
Importante ed emozionante il ricorso alla pirotecnica. Una vera e propria pioggia di torce ad illuminare la notte in questa seconda frazione, soprattutto nel settore della Stella Rossa, ma anche i Grobari non saranno da meno. La più bella è al fatidico minuto 72’ durante il quale, per celebrare nuovamente i 72 anni del proprio club, i biancorossi effettuano l’ennesima corposa torciata. Quella più carica d’entusiasmo è invece all’87esimo nel settore ospiti, quando l’attaccante Uroš Djurdjevic trova un pareggio che sembrava ormai insperato e che a maggior ragione fomenta la scatenata esultanza dei suoi tifosi.
Tra le altre cose che mi hanno colpito e che segnalerei a margine di questa cronaca, sono le diverse bandiere fra i Delije dedicate ad ultras scomparsi, ognuna delle quali racconta una storia particolare che aiuta a mettere insieme la prismatica identità e a capire gli ultras di quest’angolo di mondo così diverso e così affascinante. Uno è Velibor Dunjic, immortalato megafono alla mano sia in una bandiera che in una pezza montata proprio sul palchetto da cui il corista attuale dirige il tifo. Figura molto controversa la sua, di indubbio spessore nella vita di Curva, ma con un altrettanto pronunciato lato oscuro nella vita quotidiana, in cui aveva collezionato una infinità di carichi penali soprattutto nel narcotraffico e in queste stesse spire era rimasto avviluppato e freddato a colpi di arma da fuoco nel maggio 2014. Mi piace pensare, a rischio di sbagliarmi, che se gli ultras continuano a ricordarlo, sia perché non ha lasciato mai che i suoi (mal)affari personali pesassero nell’economia della Curva. Che poi nella realtà il mondo ultras finisca spesso in scacco a certe dinamiche non lo si può negare, ma nemmeno lo posso dire di questo caso specifico che non conosco così da vicino.
L’altra triste dedica su bandiera è per Marko Ivkovic detto “Jagoda”, ossia “Fragola”: proprio in virtù del suo nomignolo, oltre alla bandiera col suo volto, aguzzando la vista potrete vedere sventolare una bandiera con il disegno appunto di una fragola. Marko fu ucciso a Istanbul prima di una gara di Eurolega fra il Galatasaray e la rappresentativa di basket che i Delije seguono indifferentemente assieme a pallamano, pallanuoto o qualsiasi altra disciplina della polisportiva Stella Rossa. Ovviamente differenti sono le ricostruzioni a seconda della fonte, il dato inconfutabile è che Marko sia morto a causa di una coltellata e c’è davvero poco altro da aggiungere. L’aggravante è che, date le parti in causa, questo nefasto evento butta benzina sul fuoco secolare dello scontro interetnico e interreligioso che contrappone Serbi e Turchi, Ortodossi e Mussulmani fin dall’epoca dell’impero Ottomano e che ancora oggi, in certa misura, avvampa in vari crinali dei Balcani, dal già menzionato Kosovo alla Repubblica Sprska.
Last but not least, come direbbero gli inglesi, Aleksandar Jacimovic, ventunenne ucciso l’anno scorso durante la trasferta in casa del Borac Kacac, squadra la cui tifoseria rientra nel novero della stragrande maggioranza delle ultra-ortodosse e ultra-nazionaliste Serbe, eppure Aleksandar ne è tornato in una bara e con una coltellata al cuore. Il mito della lealtà di cui si fregiano certi estremismi è una contraddizione in termini, così come pericolosa è la sovrastima e la sovraesposizione della violenza nelle logiche di un gruppo ultras. È una regola del gioco implicita in cui può capitare di imbattersi in questo percorso molto particolare di antropologia e sociologia applicata che è lo stadio, ma la violenza gratuita, programmatica e tutt’altro che simbolica rischia poi di generare diverse derive. Le generano il culto di quei gruppi moderni centro-europei in cui le palestre contano più della strada e le generano anche le spinte repressive di chi criminalizzando in toto le espressioni del tifo, finisce per favorire proprio quella violenza che vorrebbe debellare: vista la mancanza di proporzionalità fra delitti e pene, va da sé che il rischio di una sanzione amministrativa e penale valga maggiormente la pena di correrlo per un confronto fisico con l’avversario e non per aver acceso un fumogeno. Non è apologia di reato, è matematica Watson!
Finita la gara mi confondo con Paolo e Michael nella folla, lasciandoci trasportare da essa in una lunga camminata fino al centro cittadino. Abbiamo altri giri di birre da concederci, pensieri da confrontare, ultime chiacchiere da spendere, scampoli di città e di vita da assaporare ancora, nella vana illusione che il tempo non passi, che questa sensazione non ci si lavi via e ci riporti indietro nel tempo o indietro quel che abbiamo perduto. La polizia ingombra gli angoli dei nostri sogni, facendo da corridoio umano in questo lungo tragitto sulla strada del ritorno. Un volo ci aspetta a poche ore di distanza. Eludendo gli incubi incipienti, godiamo di attimi: è stato un derby spettacolare, la più bella esperienza di tifo vissuta nella mia vita, un’esperienza assolutamente da consigliare e da ripetere.
Matteo Falcone.
#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Viviamo di sogni, godiamo di attimi: Stella Rossa – Partizan, Superliga Serba Ci sono tante città dalla bellezza un po’ sofisticata, pretenziosi salotti bohémien in cui, come diceva giustamente Andy Warhol, viene prodotto anticonformismo di massa a masse “hipsteriche” che per moda vogliono apparire anticonformiste.
0 notes
Text
“Caro Davide, non ci daranno mai la direzione: tutti, in fondo, preferiscono la solita minestra, la solita mafietta”; “Caro Matteo, stai tranquillo, tanto sono tutti morti”. Per un Salone del Libro come Fight Club
Caro Davide,
ho il sospetto che non ci daranno mai la direzione del Salone del Libro di Torino. Tanto più che anche molti dei nostri lettori sono contrari alla cosa. Mica abbiamo la fortuna di quelli di “La Repubblica” che hanno solo fruitori allineati al loro pensiero binario “fascisti-antifascisti”.
Ho timore che molti di coloro che “dirigono la baracca” sappiano bene che con noi si svolgerebbe una vera kermesse e non avrebbero modo di dare luogo alla loro camorra del libro. Pensa uno dei soliti noti che arriva con il suo fare peloso, stucchevolmente amichevole, e ci dice che dobbiamo per forza organizzare la presentazione di X perché lui lo conosce e X a sua volta è intimo di quell’altro che elargisce i finanziamenti. Già mi vedo la tua faccia, gli occhi come due fiamme ossidriche durante il turno in fabbrica. Ti immagino che spieghi al leccaculo di turno che il libro di X è una porcheria. Quello volge lo sguardo verso di me, nella speranza di trovare uno corruttibile, senza sapere che io sono peggio di Robespierre, solo molto più propenso al turpiloquio e all’azione muscolare. “Neanche se si mette a novanta tua sorella. Adesso levati dalle palle”: ecco quale sarebbe la mia risposta, seguita da un bicchiere di vino – dovrò pure bere per sopportare tutti questi scrittori.
Riesci a figurarti come reagirebbe l’ex Direttore di turno? Sparerebbe minacce, urlerebbe indignato che noi vogliamo sovvertire una logica oramai consolidata. Io, in tutta risposta, gli rutterei in faccia. Lui ci darebbe dei fascisti. Io gli farei cenno di attaccarsi. Quello griderebbe, in falsetto, “sessista”. Molti di loro, lo sappiamo, sono incredibilmente prevedibili e privi di fantasia.
Forse sarebbe meglio fare, come suggeriva un lettore sostenendo che la mia visione della letteratura è roba da Fight Club, dato che io auspicavo di prenderci a botte per il piacere della platea, di organizzare davvero un qualche festival alternativo in uno scantinato umido e marcescente. Uomini a petto nudo che discutono animatamente dei loro gusti letterari e, quando la cosa non può risolversi dialetticamente, in nome di un sano vitalismo, si abbandonano ai cazzotti. Il tutto con la sola differenza, rispetto al Fight Club, di lasciare entrare anche qualche poetessa, giusto per pizzicare un po’ di culi alla fine della rissa. Alle vere poetesse piacciono gli uomini con la pancia da birra, il muscolo guizzante da muratore, che citano Cardarelli mentre sputano sangue e denti a lato del ring.
Dopo un certo tempo, avendo guadagnato un po’ di successo – e sono certo che ci sarebbe, perché tutte ’ste mezze seghe hanno bisogno di sentirsi vivi – stai sicuro che Raimo scriverebbe un post (in falsetto) dicendo “a destra nascono tutte queste realtà letterarie alternative, dove uomini fascisti si scambiano botte e, da veri sessisti quali sono, si sentono in diritto di toccare le donne. Ma noi prima o poi reagiremo istituendo un club dove tra letterati ci baciamo”.
Ma tu ricorda, amico mio, la prima regola del Fight Club letterario è che, se arrivano quelli del Salone, noi ci dobbiamo disporre subito con la schiena contro il muro.
Matteo Fais
***
Caro Matteo,
visto che la questione, nella sua miseria, è alta, alzo il tono e ti racconto una storia, mentre tu scazzotti il primo che passa.
Io ho avuto il privilegio di vivere nell’ustione. Ti parlo di quasi vent’anni fa. Era già tutto chiarissimo – come, per altro, lo era dai decenni precedenti, ma con un ‘eroismo’ più acuto, con una più scaltra spensieratezza. Era chiaro che le case editrici non erano più ‘case’ ma soltanto aziende editoriali, McDonald’s dell’ovvio – poi, è ovvio, siamo tutti felici, ogni tanto, a ingollare hamburger. Era chiaro che quelle griffe – Einaudi, Mondadori, Feltrinelli, Bompiani… – non sacralizzavano altro che l’impero del denaro. La poesia, piuttosto, era atto ostinato e contrario – anche nel dire l’ingordigia della gioia – era sovversione, emersione dei morti, esaurimento di ogni verbosità, lucido lavoro di sarchiatura. Adamantino. Poesia è prepararsi a una lotta a mani nude, fieri della propria incapacità al sopravvivere. Usando la tua metafora, il mio fight club, cioè la mia casa, era Atelier. Lì ho pubblicato per la prima volta – numero 28, Dicembre 2002; cose orrende, come è buono e giusto che sia – lì, soprattutto, ci si riuniva in cerchio – io, Marco, Flavio, Federico, Riccardo, Massimo, che ho visto al Salone del Libro, a proposito, e la maturità non ci tortura!, poi Tiziana, Alessandro, Giovanni, Simone – ciascuno estraeva i propri versi, li leggeva, si discuteva. Ci si distruggeva. Prima di pubblicare quelle liete assurdità, non sai quanti testi abbiamo valutato e disossato e scartato. Una azione di rigenerante incendio. Se poi in copertina – numero 29, Marzo 2003 – leggo, tra gli altri nomi, accostati, quelli di Brullo e di Cattaneo, come puoi capire, il dolore continua come un idrante a istigare le ossa al volo.
Voglio leggerti alcune frasi tratte da alcuni editoriali di Marco Merlin, per farti capire la lucidità e la ferocia e la vita, da sanguinari del vocabolario, da cannibali del tempo:
“Discutere di poesie dentro alla dittatura aziendale che guadagna sempre più terreno sul campo della cultura… è di per sé un atto sovversivo, perché mantiene vivo il pensiero critico tout court… Resistiamo dunque alla tentazione del buonismo… Siamo sempre tutti in gioco, che lo si voglia o no”
“Se poi, nel reame della letteratura, si guarda più attentamente alla poesia, si ha la sensazione di assistere alla lotta fra barboni, che difendono il loro bocconcino e il loro territorio con i denti… Il fatto è che siamo imprevedibili: ci vogliono davanti, schiena contro il muro, per misurarci e darci il voto nelle loro scuole, ma noi li osserviamo alle spalle. Ci vogliono giovani: siamo già più vecchi di loro”
“Non cedere ad alcuna idolatria dello stile, non compiacersi davanti a nessuno specchio di solitudine. E tutto ciò è veramente arduo: accettare la fine, sentire la giovinezza che muore e andare avanti senza più voltarsi, resistendo alle sirene, distogliendo lo sguardo dagli occhi di Medusa: cambiare temi e figure, lo stile seguirà di conseguenza (non è, infatti, un problema di stile, ma di percezione del mondo)”
“C’è anche una generazione di poeti che ha trovato la forza di costruire spazi alternativi al mondo editoriale che non funziona (per precise lacune politiche, mica perché la poesia è morta o altre battute da provinciali che vivono in città), consapevole che l’onore del nome si valuta sulla qualità e non sulla quantità; una generazione che non ha bisogno di uccidere nessun padre e nessun fratello maggiore per riconoscersi, perché ha la coscienza di lavorare per il futuro, non per il presente… Ecco, questa generazione è pronta a lanciare il contrattacco, a tessere con pazienza la propria opera, forte della propria povertà, libera di dire, semplicemente, la verità disarmante di una tradizione che ha rischiato di morire di lenta consunzione, per dispersione di sguardo, per mancanza di lotta e di dialogo interni”
Al Salone del Libro, vedi, non ci si andava. Non per snobismo. Perché non c’era nulla, non c’erano libri. Come puoi capire, uno come Marco Merlin (che quelle cose le ha scritte nel 2002 e nel 2003) ora dovrebbe essere sulla cima di un qualche gruppo editoriale, dirimere il rinnovamento del Salone dei Libri o dei Festival della lettura o delle Fiere degli scrittori. Invece. Non parla. Non dice. Sta nella latitanza del vivere, con una felicità che sovrasta. Troppo prossimo a sé, si è ritirato, ad adempiere l’opera, che ha un tempo altro a quello storico.
Cosa voglio dirti, Matteo? Che noi siamo un esempio marziano prima che marziale. La pensiamo diversa su tutto – vita, letteratura, donne, forse – ma facciamo un giornale insieme (e ti sono grato). Per questo, se dovessi rifondare il Salone del Libro, per prima cosa, prima ancora di pigliarti a pugni, in quelle aule svuotate di banchetti e di libri, miracolosamente linde, aperte al silenzio, al creare onnivoro, inviterei Raimo-Lagioia, questa specie di Sfinge. E tutti quelli che prima di loro, tutti uguali, hanno fatto del Salone il Saloon dei perbenisti, delle educande democristiane. Come sai, io so nulla – io mordo. E voglio capire, voglio capire tutto consapevole del mio niente. Poi, cominceremo a suonarcele. Ci sfasciamo fino allo sfinimento del sangue che nessun calice raccoglierà, perché siamo marci. La battaglia con la storia è vinta dai miseri potentini, dai potentati editoriali, dai valvassini, resterà Lagioia & Missiroli & Gamberale, mica Brullo, vincerà Saviano e la Ferrante, mica Fais. Ma questo scrivere sulla lingua dell’oblio è esaltante. Tanto, loro, sono già morti.
Davide Brullo
L'articolo “Caro Davide, non ci daranno mai la direzione: tutti, in fondo, preferiscono la solita minestra, la solita mafietta”; “Caro Matteo, stai tranquillo, tanto sono tutti morti”. Per un Salone del Libro come Fight Club proviene da Pangea.
from pangea.news http://bit.ly/2Es2AtI
0 notes