#I rancori del giovane Hitler
Text
Non sapeva fare nulla, non lavorava, amava smisuratamente la madre, pensava di essere un artista. Poi scoprì di avere una vera passione, l'odio, e un unico talento: saper parlare.
0 notes
Photo
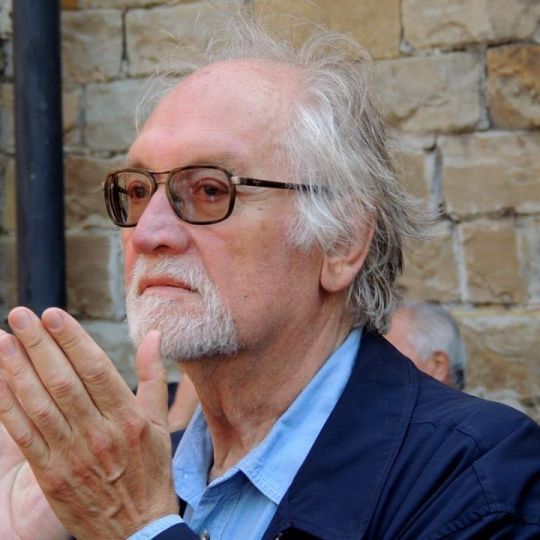
Egregio Signor Presidente della Repubblica italiana on. Sergio Mattarella Quirinale Roma Passata la “giornata dell’odio” di orwelliana memoria verrebbe la voglia di chiudersi in casa e lasciar decantare i rancori e la rabbia per le strumentalizzazioni e le falsità dichiarate in quest’occasione. Il 6 agosto del lontano 1989 accompagnai il giovane Gianni Cuperlo, segretario della FGCI, in un suo pellegrinaggio pacifista e contro la violenza delle guerre partito dall’isola quarnerina di Arbe, dove in un campo di concentramento italiano morirono a migliaia, anche neonati, per poi continuare al Pozzo della miniera di Basovizza, cenotafio in ricordo delle foibe, e finire nella Risiera di san Saba, unico campo di sterminio con forno crematorio in territorio italiano, ancorché ceduto dai fascisti al III Reich di Hitler. In quell’occasione venne ribadito il no alla violenza cieca che a volte colpì anche qualche innocente. Ci furono polemiche ed iniziative discutibili. Ne seguì, dopo la dissoluzione della federazione jugoslava, la costituzione della commissione mista italo-slovena che preparò un rapporto storico sulle vicende del confine orientale ma che l’Italia inaspettatamente non volle pubblicare. Era nel frattempo iniziato il periodo del revisionismo storico e della parziale riabilitazione dei “ragazzi di Salò”. Poi si istituì per legge la Giornata del Ricordo, sostanziale contrappeso alla Giornata della Memoria, ridotta a semplice occasione per qualche sbrigativa cerimonia. Ormai da quindici anni subiamo ripetuti tentativi di fomentare l’odio contro i popoli vicini con accuse di “pulizia etnica” ed uccisioni di massa di persone “colpevoli soltanto di essere italiani”. A questo coro Lei ha aggiunto la sua autorevole voce. Ma è proprio così? Il fascismo non c’entra? Era solo odio etnico? Mi permetta di segnalarle alcuni fatti incontrovertibili. L’Italia fascista ha aggredito la Jugoslavia annettendosi la provincia di Lubiana, trasformata in una prigione a cielo aperto circondata da filo spinato. Nelle sue fosse ardeatine (Gramozna jama) l’esercito italiano fucilò in un solo mese più di cento ostaggi. In tutta la Slovenia ci furono stragi e fucilazioni indiscriminate di civili. Si legga la testimonianza del curato militare Pietro Brugnoli “Santa messa per i miei fucilati”. In Montenegro fu peggio. Ma li decine di migliaia di soldati italiani decisero dopo l’armistizio di unirsi ai partigiani di Tito formando la divisione Garibaldi. Alle migliaia di caduti garibaldini venne eretto un monumento al quale solo il presidente Sandro Pertini rese omaggio. In Istria la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini il 26 luglio 1943 provocarono una sollevazione dei contadini oppressi e dei minatori di Arsia. Vi furono uccisioni indiscriminate di possidenti terrieri, funzionari dello Stato, gabellieri ed esponenti fascisti, anche qualche vendetta personale. Furono infoibate alcune centinaia di persone. Intanto i gerarchi fascisti sfuggiti alla “jaquerie” chiamarono da Trieste le truppe naziste. Per paura dei possibili delatori le uccisioni aumentarono. Complessivamente furono 400-500 in totale gli uccisi riesumati. Ma i partigiani nel frattempo avevano anche salvato molte vite italiane. Pochi ne parlano, ma i partigiani sloveni, croati ed italiani fermarono a Pisino un treno bestiame pieno di soldati italiani diretto nei lager in Germania. Furono liberati, circa 600, e vestiti dalla popolazione con abiti civili affinché potessero raggiungere le loro case. Lo stesso successe in tutta la penisola istriana. Poi arrivarono i tedeschi chiamati dai fascisti locali. La “Prinz Eugen Division” bruciò una ventina di paesi ed uccise 2500 persone. Mio padre, partigiano in Istria, venne ferito e curato dalla famiglia di colui che poi divenne il primo ambasciatore croato a Roma. Nel maggio del ’45 le truppe jugoslave della IV Armata dalmata e del IX Korpus locale aiutarono i battaglioni di Unità operaia, lavoratori armati delle principali fabbriche e dei cantieri, a liberare Trieste assieme agli alleati neozelandesi. In quell’occasione alcune migliaia di persone vennero fermate per accertamenti. Gli elenchi erano stati evidentemente preparati dalla Resistenza locale. La gran parte venne rilasciata, mentre alcune centinaia accusate di vari crimini vennero passate per le armi. Nelle foibe del Carso triestino vennero inumati anche moltissimi soldati tedeschi caduti nelle battaglie attorno la città e che in seguito furono recuperati e trasportati al cimitero militare di Costermanno. Sia a Trieste che a Gorizia vi furono, nella resa dei conti, anche vittime innocenti tra cui persino aderenti ai CLN italiani. Così come vi furono uccisioni da parte di criminali comuni che si fecero passare per partigiani. Scoperti vennero poi giustiziati dagli stessi jugoslavi. E’ vero. La fine della guerra in tutt’Europa vide momenti di atrocità e di vendetta, ma non si può parlare di pulizia etnica o di uccisi “soltanto perché italiani”. E’ inutile parlare di pace ed Europa se poi la complessità storica viene ridotta a semplificazioni spesso funzionali alla progressiva riabilitazione del fascismo ed attraverso questa dei suoi nuovi fenomeni razzisti, nazionalisti e revanscisti. Io condanno le violenze gratuite e lo spirito di vendetta che si cerca di rinnovare in questi momenti difficili in cui il continente europeo è attraversato da rigurgiti pericolosi quanto antistorici. Mi permetta, Signor Presidente, di osservare che le sue parole non aiutano certamente la collaborazione tra i popoli del Nord Adriatico, ne la conciliazione che può rafforzarsi soltanto nel ricordo della comune lotta contro il nazifascismo e per la libertà. Vicino a Fiume operò un battaglione di partigiani italiani, croati e sloveni che significativamente si chiamava “Fratellanza”. Vicino c’è il paese di Lipa dove tedeschi e fascisti uccisero, come a Sant’Anna di Stazzema, tutti gli abitanti, circa trecento, bambini compresi. Non le chiedo di recarsi a Lipa o alle fosse ardeatine di Lubiana, e nemmeno all’isola quarnerina di Arbe. Per capire meglio la storia del confine orientale basterebbe che Lei visitasse il cimitero di Gorizia, dove giace Lojze Bratuž, mite cattolico e musicista, che nel 1936 a Podgora diresse canti in lingua slovena durante la messa natalizia. Due giorni dopo i fascisti gli fecero bere olio di macchina mescolato con benzina e frammenti di vetro per cui morì dopo un’atroce agonia durata settimane. Lasciò due bambini e la moglie, nota poetessa, che durante la guerra venne sadicamente torturata dai poliziotti dell’ ispettorato speciale di PPSS diretto dal commissario Gaetano Collotti, giustiziato dai partigiani veneti e poi decorato dalla Repubblica Italiana con medaglia d’argento per i “meriti acquisiti nella difesa dell’italianità del confine orientale”. L’on. Corrado Belci cercò inutilmente di farla revocare. La decorazione è ancora valida come quella al carabiniere che a Trieste uccise una ragazza, la staffetta partigiana Alma Vivoda. In compenso nessun riconoscimento andò al maresciallo dei carabinieri del comune di Dolina, vicino a Trieste, che durante un rastrellamento tedesco si rifiutò di indicare le famiglie di sentimenti partigiani. Venne caricato per primo sul camion che lo portò in Germania, da dove non fece ritorno. Venne respinta persino la proposta di intitolargli la locale caserma dell’Arma… Vede, Signor Presidente, la legge istitutiva del Giorno del Ricordo fissa la data del 10 febbraio che invece dovrebbe essere una festa per ricordare la firma del Trattato di pace a Parigi nel 1947 quando 21 paesi della vittoriosa alleanza antifascista riconobbero, grazie alla Resistenza che la riscattò, l’Italia come paese cobelligerante e quindi parte della comunità dei paesi democratici e civili, mentre la Germania e l’Austria vennero divise in zone di occupazione militare. L’Italia perse i territori conquistati nella Grande guerra. Nei due paesi rimasero minoranze slovena ed italiana. L’esodo degli italiani dall’Istria venne regolato anch’esso dal Trattato di pace. Fu comunque una tragedia per molti, come lo fu per gli sloveni ed i croati che nel primo dopoguerra dovettero emigrare per salvarsi la vita dalla violenza iniziata già coll’incendio della Casa nazionale degli sloveni a Trieste nel luglio 1920 cui seguì una dura repressione fascista. La pace ed il riconoscimento dei rispettivi confini col Trattato di Osimo del 1975 gettarono le basi per una convivenza pacifica e la collaborazione in tutti i settori dell’economia, della scienza e della cultura con prospettive di sviluppo inattese, che il rivangare dei sentimenti di revanscismo e di odio possono inficiare. Spero di averla fatta riflettere. Ossequi. Stojan Spetič, già senatore del PCI
58 notes
·
View notes
Text
“Che cos’è l’umanità se non dissennata follia?”. Oggi muore Morselli, scrittore d’immortale grandezza. Pubblichiamo “Irrenanstalt”: un esercito di pazzi nella Seconda guerra
Era il 1949, Guido Morselli era un giovane uomo, aveva trentasette anni. Sono trascorsi settant’anni da allora. Il ricordo della Seconda guerra mondiale era vivido, dentro i suoi occhi, il tambureggiare dei bombardamenti nitido nelle sue orecchie, forse – suppongo – da allora nutriva il culto del silenzio, combatteva ferocemente ogni forma di rumore. Il racconto che calchiamo su questo foglio, è stato pubblicato, nel 1999, all’interno del volume Una missione fortunata e altri racconti, pubblicata dalla Nuova Editrice Magenta a cura di Valentina Fortichiari con il titolo Gli ultimi eroi, ma il pezzo aveva visto la luce ben prima, sul «Mondo» di Pannunzio, quel lontano 4 marzo 1950, con un altro nome e qualche differenza nella versione. Irrenanstalt era il titolo originariamente scelto per la pubblicazione sul «Mondo». Un titolo azzeccato se diamo uno sguardo all’etimologia, a quell’irren, vagare, errare, sbagliarsi. Manicomio, in italiano. In effetti, se diamo uno sguardo all’inizio del testo pubblicato da NEM, la revisione del testo è notevole. Leggo la versione pubblicata: “Farsa e tragedia spesso confluiscono, sullo sfondo degli eventi storici. E lo spirito di onor patrio è così tenacemente radicato da sopravvivere, quasi un istinto, anche quando dell’uomo non rimane più che la macchina; se pur non conviene concludere semplicemente, che la guerra è tutta e in tutti pazzia”. Qui parte invece il vero abbrivio del testo pubblicato da Pannunzio, nel ’50: “La guerra è una pazzia e noi siamo da considerare tutti dei pazzi?”. L’avventura della riflessione sulla pazzia nell’opera di Guido Morselli e nella sua vita era destinata ad avere largo corso. E non voglio alludere qui soltanto a Nipic, il santo folle, protagonista dell’opera teatrale inedita Il Redentore (a lungo studiata da Fabio Pierangeli), che presenta molti punti di contatto con questo articolo di giornale, ma penso anche al suicidio, che si commemora oggi. Era la notte tra il 31 luglio e il primo agosto 1973. Nipic, di origine boema, era dedito ai poveri, salvatore di ebrei in territorio tedesco, sospettato di attività anti-tedesca, in un manicomio, nel settembre del 1938, alla vigilia della guerra. Nel racconto di Irrenanstalt, invece, sulla Mosa, troviamo un altro folle, Schölpke, anch’egli rinchiuso in manicomio prima della guerra, già nel 1922. La sua follia è umana, patriottica, salvifica, gioca alla guerra. Da falegname, costruisce le armi di legno verniciato, trasforma i reclusi, detenuti, in commilitoni. La follia è carismatica, il falegname Schölpke, “un campione di razza germanica”, un possente tedesco biondo con gli occhi cerulei, ha organizzato un vero e proprio esercito, tale da ingannare persino dei validi soldati americani. La neve aveva fatto il resto, nascondendo i simboli della croce rossa. Il soldato californiano Graetz, con un riso assurdo e sinistro, traduce, troppo tardi, la parola della grossa targa che penzolava: manicomio. Nomina sunt consequentia rerum? Non è forse vero il contrario? Che cosa è l’umanità se non dissennata follia? Un disegno apparentemente innocuo che si rivela una farsa e una tragedia? Forse a questo pensava Guido Morselli, ormai sulla soglia dei sessantuno anni – avrebbe compiuto gli anni, tra pochi giorni, a ferragosto – all’estrema vanità del tutto. Quel suo gesto coraggioso, estremo, così vicino alla trama del suo capolavoro, Dissipatio H.G. non è frutto di follia, ma della lucida certezza che senza “felicità” non è possibile vivere. “Sento che la notte sarà lunga…. Ma a casa non torno, per l’amor del cielo, no”. La pistola la teneva nel cruscotto della sua macchina, nel viluppo della coperta militare, sotto il cuscino. Era la pistola militare, la Browning 7,65, la ragazza dall’occhio nero, che gli teneva compagnia da una vita. La ragazza che gioca col fuoco. “Sono andato a prenderla, la mia ragazza dall’occhio nero, mi sono ridisteso sul letto con lei. Ho premuto la bocca sulla sua, a lungo. L’ho sollecitata col dito, una prima volta. Non abbastanza a fondo. E una seconda volta, sempre con la bocca sulla sua”. Quella “strana eternità” si stava preparando sotto i suoi occhi. C’è anche un momento per chiedere scusa, “non ho rancori” lascia scritto. In Dissipatio: “Mi tolgo le scarpe, la giacca, rimango in calzoni e bretelle. Scusami Tuti”. Non ce la faceva più a vivere. La vita era un carcere, troppo dura da vivere, erano crollate a terra tutte le sue illusioni e le insegne, non c’era più nessun cartello e nessun santo folle a cui prestare ascolto per imbracciare inutili armi di legno. Era tutto perduto. E la morte era lì, così affascinante, così facile, così poetica. La pistola era carica.
Linda Terziroli
*Linda Terziroli ha curato di Guido Morselli le “Lettere ritrovate” (2009) e “Una rivolta e altri scritti. 1932-1966” (2012); ha curato inoltre il volume “Guido Morselli, un Gattopardo del Nord” (2016). Ha da poco pubblicato “Un pacchetto di Gauloises. Una biografia di Guido Morselli” (Castelvecchi, 2019)
***
IRRENANSTALT
di GUIDO MORSELLI, Il Mondo, 4 marzo 1950
La guerra è una pazzia e noi siamo da considerare tutti dei pazzi? Questa è la domanda che si poneva un valoroso e colto amico americano nel riferirmi l’episodio che segue, e che esporrò con le parole stesse di lui, che ne fu uno dei testimoni oculari. La gelida primavera del ’45, nella Germania del nord, uno dei giorni in cui si attendeva l’annuncio dell’entrata degli alleati in Berlino e della cattura di Hitler. Appartenevo al comando di una divisione di retroguardia; la nostra armata, proveniente dalla Frisia, avanzava nel cuore della regione prussiana. Costeggiavamo il mare a bordo di un pigro apparecchio da ricognizione. Pochi minuti di volo più a sud, lo spettacolo ormai monotono delle nostre colonne, aprentisi un varco nella folla dei tedeschi reduci dal fronte e diretti alla rinfusa verso l’interno. Le spiagge, invece, deserte; a intervalli, fra le dune, fortificazioni costiere vuote da tempo dei difensori, e già squallide come resti archeologici. Eravamo in procinto di rientrare quando, nella landa brulla, ammantata di neve, scorsi un gruppo di costruzioni scure, massicce, divise da cortili. Ci giungemmo sopra, e il pilota accanto a me levò il braccio in un gesto di stupore. Intorno ai fabbricati, soldati tedeschi lavoravano a scavare trincee; pezzi d’artiglieria allungavano le loro volate fuori dei ripari; a quanto potrei giudicare, erano pezzi di un modello antiquato, ma i serventi andavano e venivano svelti fra piazzuole e riservette, e parevano portare proiettili. C’era di più. Nei cortili, reparti di truppa facevano evoluzioni agli ordini di un comandante, con sincronismo perfetto, come da noi gli allievi di West Point; e nessuno sembra darsi pensiero dell’apparecchio che sorvolava a bassa quota.
La “Casina rosa” di Morselli a Gavirate (Va), in una fotografia di Luca Tonin
Presentai il mio rapporto al comando, che sostava a qualche miglio dalla misteriosa caserma. Doveva trattarsi, mi si disse, di un centro di addestramento per paracadutisti, di cui si conosceva l’esistenza nella zona. Verso sera si ebbe notizia che nella stessa località due staffette motocicliste si erano imbattute in pattuglie tedesche armate; uno dei nostri era stato preso prigioniero. Venne dato l’allarme all’aviazione. Bombardieri leggeri volteggiarono brevemente in direzione del mare; il solito tremendo seguirsi di boati, un greve nuvolone sulfureo che si librò nel crepuscolo; poi il segnale «greenlight to the troops», via libera alla fanteria. Se non erro, quel segnale fu l’ultimo della guerra in Europa.
La caserma, o quel che si fosse, era dunque trasferita al Wahlalla; per l’accertamento, e per il recupero della staffetta, dovendo il comando ripartire nella notte, fu lasciato un sottotenente con due carri. Non so per quale curiosità, sollecitai di rimanere anch’io. Ci mettemmo in moto al mattino, attraverso magri cespugli di erica. Dalla nebbia emersero finalmente le mura fumanti della caserma. Mi sfuggì un’imprecazione. Quella gente non cedeva ancora! Nell’orbita del mio binocolo ecco cinquanta, cento sagome grigie: soldati tedeschi in attesa dietro le loro postazioni, come pietrificati. Un momento dopo un’esplosione lacerò l’aria; il carro alla nostra dritta giaceva sul fianco, un cingolo e la torretta divelti; e gli occupanti, per fortuna solo malconci, ne saltarono fuori. Bomba d’aereo inesplosa, o mina? Nel dubbio il mio collega preferì fermarsi e chiedere l’intervento dei mine-detectors, nelle strade dietro a noi il passaggio dei nostri seguitava ininterrotto, ce ne arrivava il fragore confuso. Quattro feriti lievi, e l’umore degli equipaggi che peggiorava: farsela con quella bicocca, e rischiarci la pelle oltretutto, quando c’era Berlino che li aspettava! Non ricordo se ne fu dato l’ordine, ma a un certo punto partì una granata dal nostro carro, poi una seconda, una terza. Puntai il binocolo: i tedeschi se ne stavano fermi nelle trincee sotto il fioccare dei colpi; adesso le canne delle loro armi erano puntate verso di noi, ma non sparavano. Vedevo i loro caschi, i visi, ne indovinavo l’espressione stupida, sgomenta.
Un caccia ronzava sulle nostre teste; discese, tracciò qualche ampio giro sulla caserma. Il radiotelegrafista del carro ci passò un messaggio. Il caccia si burlava di noi: «Cosa combinate, ragazzi? I vostri mi stanno facendo in cortile l’ordine chiuso…». Interrogai con gli occhi il mio collega: cominciavo a provare un sottile disagio. Lontano, verso ovest, si delineò la massa di un semovente, scortato da due sherman. Proiettili da 149 presero a cadere sulle rovine della caserma, sulle trincee gremite. Proseguimmo anche noi. A duecento passi dai tedeschi, li scorgemmo caricare le armi, spianarli, mirare, senza far fuoco. Il carro imboccò la strada, procedette sicuro. Con uno scatto d’automi, i tedeschi si levarono, ci vennero incontro correndo, alla baionetta: soldati vecchi e giovani, grotteschi nelle loro giubbe troppo larghe, allucinati e pietosi nei volti asciutti, bruttati di fango. Decine e decine di uomini in file serrate, gesticolanti, contro il carro: sul loro furore i cingoli rompevano, schiantando, macellando. E ancora ne sbucavano fuori dalla cinta smantellata, goffamente brandendo i fucili a due mani, e si gettavano per la discesa all’assalto, spingevano i cannoni in batteria, li puntavano, accanendosi sui congegni inceppati. Lo strepito del carro era così alto da coprire gli spari, pure quella gente non faceva uso delle proprie armi; dalle feritoie i nostri guardavano senza capire. Ma tutto era ben reale, tangibile. I corpi che giacevano a terra erano corpi di uomini, convulsi nello spasimo o inerti nell’abbandono della morte. La carneficina non richiese che qualche istante, e fu compiuta con pochi tiri a bruciapelo delle mitragliatrici di bordo. Avevo al mio fianco il capocarro, Graetz, un californiano oriundo sassone. Lo vidi arrestare il veicolo, balzare al portello, scendere a precipizio: eravamo sotto il muraglione, davanti all’ingresso. Una grossa targa vi penzolava, ancora leggibile. Graetz la staccò mostrandocela, con un riso che nell’improvviso silenzio suonò assurdo e sinistro. «Irrenanstalt»; manicomio, egli ci tradusse.
Nella fotografia di Luca Tonin, Linda Terziroli nella “Casina rosa”
Il resto ci fu spiegato dai due medici che, con gli infermieri e la nostra staffetta, rinvenimmo legati in fondo a un sotterraneo, affamati ma illesi. I loro ospiti si erano ammutinati il giorno precedente. Li guidava nel dissennato disegno un certo Schölpke, falegname di mestiere rinchiuso sin dal 1922, per i postumi di una ferita cranica riportata in uno scontro con gli americani, nel ’18, sulla Mosa. La mania di costui era sembrata innocua; aveva irregimentato i compagni, li aveva addestrati a rigida disciplina; ogni nuovo ricoverato, una recluta. Con le sue mani, in vent’anni di lavoro, si era fabbricato un vero arsenale, cannoni e fucili di legno verniciato, elmetti di lamierino, e vessilli, e distintivi. Per Schölpke il Kaiser regnava sempre, la guerra in cui lui aveva combattuto non era finita, e la sua certezza si era fatta trionfale quando aerei alleati, alcune settimane prima, avevano colpito l’edificio, i simboli della croce rossa che lo contrassegnavano essendo nascosti dalla neve.
Le bombe non avevano in quell’occasione causato danni gravi, soltanto avevano aperto vaste buche nel terreno. In una di esse, fra la facciata dell’edificio ed il muro perimetrale, fu ritrovato l’infelice eroi con i suoi luogotenenti. Un campione di razza germanica, questo Schölpke, un uomo di mezza età e di media statura, di pelo infantilmente biondo, le spalle e il collo poderosi, lo sguardo ceruleo dilatato in una fissità ingenua e feroce. Si stringeva a un simulacro di cannocchiale a periscopio; sulla casacca verdognola dei ricoverati portava galloni di panno rosso e i nastrini delle campagne, mentre sul petto gli pendeva un rettangolo di latta con incisa la parola: colonnello. In modo simile erano decorati gli altri. Lo spostamento d’aria causato da un colpo da 149, aveva ucciso in una volta tutto quel bislacco stato maggiore, ma non lo aveva scompigliato; immersi nel terriccio, erano in piedi e gerarchicamente disposti, gli elmetti assestati in capo. Preparati alla battaglia contro l’invasore, e parevano attendere l’esito vittorioso. Chiusa nel fodero la bandiera bianca e oro con l’aquila prussiana, e accanto le stava il più giovane di quei morti; poco più di un ragazzo, la mano sinistra orgogliosamente puntata alla piastrina che attestava il suo grado: «Faehnrich», alfiere.
L'articolo “Che cos’è l’umanità se non dissennata follia?”. Oggi muore Morselli, scrittore d’immortale grandezza. Pubblichiamo “Irrenanstalt”: un esercito di pazzi nella Seconda guerra proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2ZhBY74
0 notes
Text
Non sapeva fare nulla, non lavorava, amava smisuratamente la madre, pensava di essere un artista. Poi scoprì di avere una vera passione, l'odio, e un unico talento: saper parlare.
(I rancori del giovane Hitler)
Com'è ancora attuale...
5 notes
·
View notes
Text
Non sapeva fare nulla, non lavorava, amava smisuratamente la madre, pensava di essere un artista. Poi scoprì di avere una vera passione, l'odio, e un unico talento: saper parlare.
I rancori del giovane Hitler
2 notes
·
View notes